
INTRODUZIONE
A Cura di: Alessandro Baratti
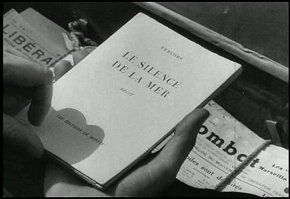
ANNICHILIRE IL TEMPO: IL SILENZIO DEL SAMURAI
Inattualità. La posa sdegnosa della solitudine. Il cinema come cerimonia. Melville, esploratore nostalgico sprezzantemente estraneo alla sua epoca, è tutto questo. Jean-Pierre Grumbach, ribattezzatosi Melville in omaggio al suo scrittore preferito, incarna la gloriosità del fare cinema, dell’essere cinema. Con un’intransigenza che mette i brividi. Nel 1947, un anno prima del celebre scritto di Alexandre Astruc sulla caméra-stylo (1) e con più di dieci anni di anticipo sugli esordi dei giovani turchi dei “Cahiers” (2), JPM gira Le silence de la mer, uno dei debutti cinematografici più autarchici, insubordinati e sconvolgenti della storia della settima arte. Strappa a Vercors (3), l’autore del romanzo omonimo scritto nel 1942, il permesso di girare a casa sua e con una troupe ridotta all’osso (tra cui figura un altro esordiente di lusso: Henri Decaë, IL futuro direttore della fotografia della Nouvelle Vague) si reca a Villiers-sur-Morin e mette a soqquadro la casa dello scrittore. Ne esce un film devastante: intimo come una confessione e solenne come un monumento. Le emozioni rimbombano grazie a uno stile di inaudita libertà, capace di decantarsi in soluzioni classicheggianti ma anche di infiammarsi in virtuosismi di audace sperimentalità.
 Gli uomini occupano il centro esatto del film, come sempre nel cinema di Melville. Intorno a loro ruota il tempo, vettore necessario al dispiegarsi della loro verità interiore. Il ticchettio di un orologio scandisce inesorabile il dramma che si consuma nell’intimità dei personaggi, dolorosamente separati dalla guerra ma poderosamente avvicinati da un sentire che li spinge alla reciprocità, all’affetto autentico. La voice over dà letteralmente voce ai sentimenti inespressi, ma dal di dentro, scaturendo come cristallo dalle immagini. Sconquassante. Le categorie analitiche di ridondanza, complementarità o contrapposizione vanno in frantumi: di fronte all’opera d’arte l’intelletto vacilla, immerso in un tempo che è quello costruito dall’opera stessa: una temporalità irriproducibile al di fuori dell’esperienza estetica. E qui veniamo alla seconda grande creazione di Melville: il noir ambientale. Dopo aver precorso con una precocità semplicemente derisoria quel cinema della soggettività che gli autori della Nouvelle Vague frequenteranno e celebreranno coprendosi le spalle a vicenda, JPM esce dal branco e “fa parte per se stesso”. Con l’orgogliosa spavalderia che lo contraddistingue, prende le distanze dalla corrente dei giovani turchi e si rivolge, da Léon Morin, prêtre (1961) in poi, al cinema spettacolare: produzione sfarzosa, grandi budget e star.
Gli uomini occupano il centro esatto del film, come sempre nel cinema di Melville. Intorno a loro ruota il tempo, vettore necessario al dispiegarsi della loro verità interiore. Il ticchettio di un orologio scandisce inesorabile il dramma che si consuma nell’intimità dei personaggi, dolorosamente separati dalla guerra ma poderosamente avvicinati da un sentire che li spinge alla reciprocità, all’affetto autentico. La voice over dà letteralmente voce ai sentimenti inespressi, ma dal di dentro, scaturendo come cristallo dalle immagini. Sconquassante. Le categorie analitiche di ridondanza, complementarità o contrapposizione vanno in frantumi: di fronte all’opera d’arte l’intelletto vacilla, immerso in un tempo che è quello costruito dall’opera stessa: una temporalità irriproducibile al di fuori dell’esperienza estetica. E qui veniamo alla seconda grande creazione di Melville: il noir ambientale. Dopo aver precorso con una precocità semplicemente derisoria quel cinema della soggettività che gli autori della Nouvelle Vague frequenteranno e celebreranno coprendosi le spalle a vicenda, JPM esce dal branco e “fa parte per se stesso”. Con l’orgogliosa spavalderia che lo contraddistingue, prende le distanze dalla corrente dei giovani turchi e si rivolge, da Léon Morin, prêtre (1961) in poi, al cinema spettacolare: produzione sfarzosa, grandi budget e star.
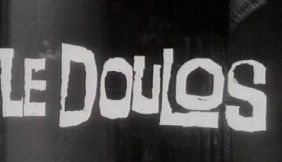 Il successo di pubblico arriva dritto come un proiettile. Melville non si accontenta e compie il miracolo: col “dittico del milieu” (Le doulos e Le deuxième souffle), con l’ultimo capitolo della “trilogia della Resistenza” (L’armée des ombres) e soprattutto con la “trilogia dell’astrazione” (Le samouraï; Le cercle rouge; Un flic) (4), Jean-Pierre si inventa un cinema semplicemente inarrivabile e irripetibile. Alla sfarzosità della produzione e alla sontuosità dell’impaginazione combina una sobrietà fenomenologica e un’ineluttabilità drammatica così algide e austere da sfociare apertamente in tragedia. Spettacolarità e rigore. Anzi: lo spettacolo del rigore. JPM crea un vero e proprio supercinema, in grado di dialogare stabilmente col pubblico senza compiacerlo, senza blandirlo (5). Ancora una volta è il Tempo a fondare questo meccanismo infallibile: dilatando la durata della rappresentazione ben oltre i limiti convenzionali (è doveroso rimarcare che la ponderazione temporale da parte dello spettatore avviene sulla base delle regole del genere e non sulla durata reale delle azioni (6)), Melville magnifica le regole della classicità, inevitabilmente dilaniandole.
Il successo di pubblico arriva dritto come un proiettile. Melville non si accontenta e compie il miracolo: col “dittico del milieu” (Le doulos e Le deuxième souffle), con l’ultimo capitolo della “trilogia della Resistenza” (L’armée des ombres) e soprattutto con la “trilogia dell’astrazione” (Le samouraï; Le cercle rouge; Un flic) (4), Jean-Pierre si inventa un cinema semplicemente inarrivabile e irripetibile. Alla sfarzosità della produzione e alla sontuosità dell’impaginazione combina una sobrietà fenomenologica e un’ineluttabilità drammatica così algide e austere da sfociare apertamente in tragedia. Spettacolarità e rigore. Anzi: lo spettacolo del rigore. JPM crea un vero e proprio supercinema, in grado di dialogare stabilmente col pubblico senza compiacerlo, senza blandirlo (5). Ancora una volta è il Tempo a fondare questo meccanismo infallibile: dilatando la durata della rappresentazione ben oltre i limiti convenzionali (è doveroso rimarcare che la ponderazione temporale da parte dello spettatore avviene sulla base delle regole del genere e non sulla durata reale delle azioni (6)), Melville magnifica le regole della classicità, inevitabilmente dilaniandole.
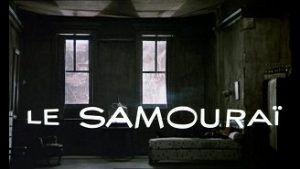 È solo grazie a questa squarciante sublimazione che gli spazi si offrono all’azione in tutta la loro pregnanza, in tutta la loro densità situazionale. E, soprattutto, è grazie a questa dilatazione estrema che i personaggi, gli uomini, possono agire pienamente, muoversi, dunque esprimersi. Un gesto improvviso si erge a segno di sfida, un’esitazione tradisce la vulnerabilità, una distrazione precipita in fatalità: è soltanto in questo tempo eccedente che il comportamento può schioccare di senso, l’azione sibilare il linguaggio. Leggere questa temporalità espansa come mero fattore di suspense sarebbe imperdonabilmente fuorviante: certo, il conto alla rovescia scatta all’inizio del film (le didascalie lo testimoniano inconfutabilmente), ciononostante quello che conta davvero non è la corsa contro il tempo, ma il corso del tempo.
È solo grazie a questa squarciante sublimazione che gli spazi si offrono all’azione in tutta la loro pregnanza, in tutta la loro densità situazionale. E, soprattutto, è grazie a questa dilatazione estrema che i personaggi, gli uomini, possono agire pienamente, muoversi, dunque esprimersi. Un gesto improvviso si erge a segno di sfida, un’esitazione tradisce la vulnerabilità, una distrazione precipita in fatalità: è soltanto in questo tempo eccedente che il comportamento può schioccare di senso, l’azione sibilare il linguaggio. Leggere questa temporalità espansa come mero fattore di suspense sarebbe imperdonabilmente fuorviante: certo, il conto alla rovescia scatta all’inizio del film (le didascalie lo testimoniano inconfutabilmente), ciononostante quello che conta davvero non è la corsa contro il tempo, ma il corso del tempo.
 E non solo per i personaggi: “trappole per spettatori” i film di Melville lo sono effettivamente, ma non nel senso commerciale e vagamente dispregiativo sottinteso dalla critica d’epoca (7), bensì in quello più preciso e stringente di dispositivi di captazione ambientale. Invischiati nella temporalità abnorme e paludosa di questa rappresentazione, gli spettatori sono impossibilitati a consumare la finzione come semplice occasione di suspense, sono imperativamente costretti a condividere la fenomenologia del delitto, la performance del crimine. La situazione filmica è esperita con una densità assolutamente inusitata: non vi è palpitazione, vi è pulsazione (8).
E non solo per i personaggi: “trappole per spettatori” i film di Melville lo sono effettivamente, ma non nel senso commerciale e vagamente dispregiativo sottinteso dalla critica d’epoca (7), bensì in quello più preciso e stringente di dispositivi di captazione ambientale. Invischiati nella temporalità abnorme e paludosa di questa rappresentazione, gli spettatori sono impossibilitati a consumare la finzione come semplice occasione di suspense, sono imperativamente costretti a condividere la fenomenologia del delitto, la performance del crimine. La situazione filmica è esperita con una densità assolutamente inusitata: non vi è palpitazione, vi è pulsazione (8).
 Se la temporalità dilatata è elemento fondante (e a dire il vero è stata più o meno diffusamente ravvisata), non meno decisivo, in chiave ambientale, risulta un procedimento sintattico squisitamente melvilliano (questo, al contrario, totalmente trascurato): l’iscrizione dell’evenienza drammatica in una struttura ternaria che la ingloba e la trascende. Prima e dopo l’evento forte (un regolamento di conti, un omicidio su commissione o una rapina non fa differenza), Melville piazza delle massicce sequenze strettamente imparentate all’azione centrale, che la incorniciano e la espandono ulteriormente. Così circondata, “accerchiata”, l’azione centrale si trova inserita in una struttura dialettica che, anziché saturarla di tensione, la dedrammatizza, la svuota di pathos.
Se la temporalità dilatata è elemento fondante (e a dire il vero è stata più o meno diffusamente ravvisata), non meno decisivo, in chiave ambientale, risulta un procedimento sintattico squisitamente melvilliano (questo, al contrario, totalmente trascurato): l’iscrizione dell’evenienza drammatica in una struttura ternaria che la ingloba e la trascende. Prima e dopo l’evento forte (un regolamento di conti, un omicidio su commissione o una rapina non fa differenza), Melville piazza delle massicce sequenze strettamente imparentate all’azione centrale, che la incorniciano e la espandono ulteriormente. Così circondata, “accerchiata”, l’azione centrale si trova inserita in una struttura dialettica che, anziché saturarla di tensione, la dedrammatizza, la svuota di pathos.
 Ne deriva una sensazione di ineluttabilità alla quale segue un senso di disarmante vacuità, in cui la refurtiva o gli oggetti dell’aggressione arrivano letteralmente a svanire, magari sotterrati in fretta e furia oppure inghiottiti da un burrone. Se Melville non fosse alieno da ogni forma di intellettualismo e se il suo giapponismo fosse meno esotico di quanto sembra, i due procedimenti di dilatazione temporale esaminati sussurrerebbero le idee di “esperienza pura” e “nulla assoluto” del buddismo Zen e della scuola filosofica di Kyoto (9). Osservati da questa angolazione, i noir ambientali di Melville (in particolare Le samouraï e Le cercle rouge), oltre ad inverare cinematograficamente la perfetta immutabilità del rituale, si connoterebbero come meditazioni filosofiche di insospettabile profondità sulle nozioni di Essere e Nulla. Il tutto all’insegna di un ostentato nichilismo, segretamente riscattato dalla celebrazione del śūnyatā zen, la vacuità come volto disadorno, “kenotico”, dell’Assoluto.
Ne deriva una sensazione di ineluttabilità alla quale segue un senso di disarmante vacuità, in cui la refurtiva o gli oggetti dell’aggressione arrivano letteralmente a svanire, magari sotterrati in fretta e furia oppure inghiottiti da un burrone. Se Melville non fosse alieno da ogni forma di intellettualismo e se il suo giapponismo fosse meno esotico di quanto sembra, i due procedimenti di dilatazione temporale esaminati sussurrerebbero le idee di “esperienza pura” e “nulla assoluto” del buddismo Zen e della scuola filosofica di Kyoto (9). Osservati da questa angolazione, i noir ambientali di Melville (in particolare Le samouraï e Le cercle rouge), oltre ad inverare cinematograficamente la perfetta immutabilità del rituale, si connoterebbero come meditazioni filosofiche di insospettabile profondità sulle nozioni di Essere e Nulla. Il tutto all’insegna di un ostentato nichilismo, segretamente riscattato dalla celebrazione del śūnyatā zen, la vacuità come volto disadorno, “kenotico”, dell’Assoluto.
(2) È pedante ma indispensabile ricordare che Le beau Serge di Chabrol esce nel 1958, I quattrocento colpi di Truffaut nel 1959 e Fino all’ultimo respiro di Godard nel 1960.
(3) Nome di battaglia scelto da Jean Bruller all’inizio della guerra.
(4) Le definizioni “dittico del milieu” e “trilogia dell’astrazione” sono mie, mentre “trilogia della Resistenza” è etichetta comunemente diffusa e accettata per i film bellici di Melville: Le silence de la mer (1947), Léon Morin, prêtre (1961) e L’armée des ombres (1969). A mio avviso, tuttavia, sarebbe più opportuno scorporare Léon Morin, prêtre dal summenzionato trittico e abbinarlo al film negletto di Melville: Quand tu liras cette lettre (1953). Nonostante JPM lo abbia perentoriamente rinnegato bollandolo più e più volte come film alimentare, Quand tu liras cette lettre presenta molte affinità con Léon Morin, prêtre, a partire dalle tematiche affrontate (l’amor sacro e l’amor profano, l’anima e la carne, appunto) e dal genere di appartenenza (il mélo). Così accostati, i due film comporrebbero un dittico che definirei volentieri “dittico della dissacrazione”.
(5) Stando alle feroci stroncature della critica, si potrebbe credere che Un flic (1972), il suo ultimo e sottostimatissimo film, abbia incrinato il rapporto tra Melville e il pubblico. In realtà, dopo lo strabiliante record d’incassi ottenuto col precedente Le cercle rouge, è quello che ha totalizzato il maggior numero di spettatori in tutta la Francia: 2,832,912 contro i 4,339,821 de Le cercle rouge. Al terzo posto figura Le samouraï, con il notevole risultato di 1,932,372 spettatori.
(6) In questo senso, benché non priva di una sua suggestività, la definizione coniata da Colin McArthur a proposito del cinema di Melville come “cinema del processo” viene a cadere, dal momento che per lui il termine di paragone non è tanto la durata standard del genere di riferimento quanto la durata reale, di cui il cinema melvilliano tenderebbe a rispettare l’integrità.
(7) È stato Pierre Billard, descrivendo lo sbalorditivo successo de Le cercle rouge sulle pagine del settimanale «L’express», ad usare l’espressione “trappola per spettatori”.
(8) Ecco perché i film di Melville, più di ogni altro film e autore, dovrebbero essere visti al cinema: hanno bisogno del massimo grado di coinvolgimento sensoriale, della stretta avvolgente delle poltroncine, del magnetismo promanante dallo schermo per attuarsi pienamente. Detto altrimenti, hanno bisogno della situazione cinematografica. Per Melville – stare attenti! – il cinema è un rito, non un passatempo: la comodità non va confusa con la distrazione.
(9) I concetti di “esperienza pura” (junsui keiken) e “nulla assoluto” (zettai mu), pur appartenendo alla tradizione giapponese, sono stati messi a punto e disposti in prospettiva filosofica da Nishida Kitaro (1870-1945), il padre della scuola di Kyoto che, dialogando con i sistemi filosofici occidentali, ha cercato di dare una fondazione razionale all’esperienza Zen dell’illuminazione.

