TRAMA
RECENSIONI
LIFE OF LARS?

Nymph()maniac, ultimo capitolo della trilogia della depressione (e oggi, cuspide, primo frammento di un dittico autocritico), definiva la tattica del genere (prima l’horror di Antichrist, poi il catastrofico di Melancholia, infine il pornografico del suddetto) evocato per ammantare di spettacolarità appetibile film che non ne avevano alcuna e che attestavano una necessità del regista di porsi autoreferenzialmente al centro del discorso. The House That Jack Built, ricorrendo alla consueta esca (il serial killer movie), quel discorso lo mette a nudo. Non è un caso se, ancora una volta, si parli di tagli e di versioni più o meno epurate: il regista gira poche scene estreme perché se ne possa parlare e ne accetta la soppressione perché realizzate in previsione di quella sforbiciata che le mitizzerà innescando l’automatico dibattito sulla censura, i divieti, ciò che è giusto vedere su uno schermo e ciò che no. Tutta chiacchiera mediatica che fa il gioco del danese e permette che questa cosa difficile che è il suo cinema diventi qualcosa di (contenutamente) popolare, che persone che dell’autore sanno pochissimo quel suo finto nome da nobile decaduto lo sentano risuonare almeno una volta a lustro. Così a Cannes abbiamo visto con chiarezza l’abbattimento dei bambini o l’asportazione brutale di un seno, solo per poter dire, oggi, della loro scomparsa nella famigerata versione tagliata (era avvenuto qualcosa di simile per Idioti e Nymph()maniac). Lars non se ne dispiace: è così che persone che ne ignorerebbero l’esistenza apprendono dell’esistenza di un film con dettagli di tale insostenibilità da provocare un esodo dalla sala alla proiezione festivaliera (ma quando?).
 Che volpe: alla Croisette, sul programma (cosa che non avviene mai), avvertiva preventivamente che alcune scene avrebbero potuto urtare la sensibilità degli spettatori. E quell’avvertenza marchiava il film. Che poi, guardandolo, di questo urtare sensibilità non ci fosse traccia (con tutta la macelleria che si pratica negli horror, poi, figuriamoci…) era dettaglio irrilevato o irrilevante. Potere della parola e sete di polemica fanno sì che se Lars ti dice che quest’opera si pone ai limiti della guardabilità, automaticamente è lì che questa va a collocarsi, anche contro l’evidenza dei fatti (vale per la millantata pornografia di Nymph()maniac: se Trier usa quella parola, si discetterà del film come se ve ne fosse, persino dopo aver constatato che no, non ve n’è traccia).
Che volpe: alla Croisette, sul programma (cosa che non avviene mai), avvertiva preventivamente che alcune scene avrebbero potuto urtare la sensibilità degli spettatori. E quell’avvertenza marchiava il film. Che poi, guardandolo, di questo urtare sensibilità non ci fosse traccia (con tutta la macelleria che si pratica negli horror, poi, figuriamoci…) era dettaglio irrilevato o irrilevante. Potere della parola e sete di polemica fanno sì che se Lars ti dice che quest’opera si pone ai limiti della guardabilità, automaticamente è lì che questa va a collocarsi, anche contro l’evidenza dei fatti (vale per la millantata pornografia di Nymph()maniac: se Trier usa quella parola, si discetterà del film come se ve ne fosse, persino dopo aver constatato che no, non ve n’è traccia).
In virtù di questo potere il cinema di Lars von Trier è diventato provocatorio anche per necessità: cerca la reazione, la divisione, il dibattito perché senza non avrebbe appeal commerciale, senza appeal commerciale non potrebbe essere venduto, se non fosse venduto non consentirebbe a Von Trier di proseguire a crearne alle sue condizioni. Kanye West si muove sulla stessa onda: perché come Lars (e Gaspar Noé, pure) è un maestro dell’hype, avendo compreso che il bailamme mediatico va aizzato e poi cavalcato, nella coscienza che quel che conta è l’opera, che essa sopravvive alle provocazioni, al dibattito pubblico, all’effimero circo dei social.  I rapporti tra West e i media non sono poi molto diversi da quelli di Von Trier: impulso incontrollabile, ai limiti della patologia, al proclama, senza filtri e senza pensare alle conseguenze (la gaffe sul nazismo a Cannes, per Lars; la questione dello schiavismo per Kanye - in entrambi i casi sintetizzate brutalmente in formula, senza considerazione della circostanza, delle sfumature e degli stati d'animo; ma nell’era di Twitter è così che funziona: anche l’avvenimento più complesso verrà compresso in pochi caratteri -). Ma soprattutto la stessa tendenza a personalizzare tutto: The Life of Pablo non è altro che The Life of Kanye, questo film è The House That Lars Built. E non ci sorprenderemo quando constateremo che, ancora una volta, vengono diffusi poster con l’effigie del regista: è lui la vera star delle sue opere.
I rapporti tra West e i media non sono poi molto diversi da quelli di Von Trier: impulso incontrollabile, ai limiti della patologia, al proclama, senza filtri e senza pensare alle conseguenze (la gaffe sul nazismo a Cannes, per Lars; la questione dello schiavismo per Kanye - in entrambi i casi sintetizzate brutalmente in formula, senza considerazione della circostanza, delle sfumature e degli stati d'animo; ma nell’era di Twitter è così che funziona: anche l’avvenimento più complesso verrà compresso in pochi caratteri -). Ma soprattutto la stessa tendenza a personalizzare tutto: The Life of Pablo non è altro che The Life of Kanye, questo film è The House That Lars Built. E non ci sorprenderemo quando constateremo che, ancora una volta, vengono diffusi poster con l’effigie del regista: è lui la vera star delle sue opere.
Quanto sia importante la sua figura oggi, lo dice il fatto che tutti sentano il dovere di prendere posizione sui suoi film: in questo senso un sostenitore vale quanto un detrattore (l’abilità di Lars è appunto questa: far provare a quest’ultimo il piacere del disgusto e il piacere ulteriore del dichiararsi disgustato) [1].
[1] Giulio Sangiorgio nell’editoriale del n.10/2019 di Film Tv: «Penso che Von Trier abbia raggiunto l’impensabile: è riuscito, con i suoi personaggi che non provano empatia, che «non sentono niente», e con un cinema mai come ora didascalico e parodico, a far tornare in auge un discorso sull’etica delle immagini. A far ritrovare una sensibilità che i media, che mostrano tutto e non fanno sentire niente, hanno cancellato. Ed è proprio questo, oggi, il suo capolavoro».
LUI E LUI

Detto del pre-testo (che è comunque testo, ma questa è una cosa che, nelle schede richiamate, abbiamo più volte ribadito e che questo film non fa che confermare) Jack si presenta come un nuovo film-analisi, un’autoconfessione sotto forma di dialogo [2]. Anche qui abbiamo a che fare con due personaggi che discutono e che sono Lars che parla con se stesso, si autoesamina, si accusa per difendersi, richiama le critiche, le disinnesca, ne aizza di nuove: diviso tra tra provocazione calcolata e amara contrizione, vanagloria e rammarico (perché c’è frustrazione nel sapere che non diventerà mai Tarkovskij o Dreyer, come per Jack nell’essere un ingegnere aspirando a essere un architetto). Jack e Verge (poi pacchiani Dante e Virgilio), come Seligman e Joe, come Lui e Lei (Antichrist) sono schizofrenicamente istinto e raziocinio a confronto, il tormento che attanaglia Von Trier messo in scena, che si traduce ancora una volta in un’autogiustificazione che è anche autoderisione - patetica forse, ironica sicuramente - che trova in Jack l’espressione ideale: «È liberatorio avere per eroe uno psicopatico perché può fare e dire quello che vuole». Jack, dunque, conscio della sua efferatezza, esamina se stesso e, sapendo di non meritarlo, tenta di raggiungere il Paradiso nell’unico modo che gli è possibile, una pericolosa scorciatoia. Così precipita negli inferi.
Che potremmo tradurre così: io Lars so di aver prosperato attraverso i delitti (i miei film infarciti di provocazioni e trovate gratuite). Ma non mi importa se questo mi ha reso persona non grata nei Campi Elisi: non torno indietro per pagare il fio, voglio raggiungerli e se cadrò nella lava ribollente dell'Inferno sarà, ancora una volta, nel tentativo di fuggirla.
[2] Lo ripeto per l’ennesima volta: il secondo film di Lars von Trier, Epidemic, conteneva moltissimo del Lars von Trier che sarebbe seguito. E oggi scopriamo mostrare in nuce anche questo approccio autoanalitico, “arrogantemente” rivelatorio, la tendenza del regista a non limitarsi a un discorso, ma a mostrare la logica con la quale quel discorso viene fatto.
(the) JACK

Lo schema, ripeto, echeggia quello del film precedente, ma stavolta la narrazione, è palesemente costruita: se in Nymph()maniac la questione della finzione del racconto era sottilmente suggerita, in questo caso Trier non nasconde che ciò sta raccontando è un’invenzione (del resto i crimini dell’american psycho di Bret Easton Ellis non erano anch’essi tutti raccontati? Raccapriccianti, sì, ma mentali?). Lo dice esplicitamente l’incipit. La casa che Jack costruì va letto come un racconto costruito da un cric (jack, in inglese). L’edificazione di questa casa (la narrazione che segue) si fonda su quel jack. Si sta dicendo che il cric (the jack) viene scelto dal demiurgo Lars von Trier come inizio del racconto sulla base di un semplice gioco di parole. Una costruzione che prende spunto dall’omonima filastrocca popolare (This is the house that Jack built) che uno per uno cumula gli elementi in un rapporto di inscindibile causa - effetto (come, citandola, faceva Alla fiera dell’Est, il brano di Angelo Branduardi).
This is the house that Jack built
This is the malt that lay in the house that Jack built.
This is the rat that ate the malt
That lay in the house that Jack built.
This is the cat
That killed the rat that ate the malt
That lay in the house that Jack built.
This is the dog that worried the cat
That killed the rat that ate the malt
That lay in the house that Jack built… etc
Ogni elemento dipende dal precedente, quindi, traslando, tutta la narrazione vontrieriana procede da quel cric, il motore primo, the jack. E infatti l’oggetto viene ripetutamente impugnato, inquadrato, enfatizzato.
 E allora quella dichiarazione stentorea della prima vittima, alla sua apparizione: «So I'm standing here holding this jack» assume davvero il significato di un innesco, a dire: stiamo facendo di questo arnese l’inizio della nostra orrorifica nursery rhyme e la questione è talmente importante da essere io, Uma Thurman (la diva), a farmene latrice. E infatti sarà Thurman a introdurre, in maniera del tutto forzata, la questione dell’omicida seriale. Jack vi si trasforma perché questa autostoppista in difficoltà è la vittima narrativamente predestinata, colei che dovrà essere uccisa dal serial killer protagonista del film. Talmente cosciente del suo destino da istigare l’uomo ad assassinarla e da suggerirgli come: «A jack like that can do quite a bit of damage, don't you think?». Del resto perché la scena fa ridere? Perché è costruita sulla base di consapevolezze incrociate: lo spettatore sa che il film parla di un serial killer (Lars von Trier lancia i suoi film non appena sa di poterli realizzare, anticipandone alcuni elementi) e sa (desidera?) che Jack ammazzi quella donna; il regista sa che il pubblico sa e gioca al gatto e topo a carte scoperte, portando i suoi personaggi su un piano di coscienza di sé quasi beckettiano (il pre-testo è nel testo, appunto).
E allora quella dichiarazione stentorea della prima vittima, alla sua apparizione: «So I'm standing here holding this jack» assume davvero il significato di un innesco, a dire: stiamo facendo di questo arnese l’inizio della nostra orrorifica nursery rhyme e la questione è talmente importante da essere io, Uma Thurman (la diva), a farmene latrice. E infatti sarà Thurman a introdurre, in maniera del tutto forzata, la questione dell’omicida seriale. Jack vi si trasforma perché questa autostoppista in difficoltà è la vittima narrativamente predestinata, colei che dovrà essere uccisa dal serial killer protagonista del film. Talmente cosciente del suo destino da istigare l’uomo ad assassinarla e da suggerirgli come: «A jack like that can do quite a bit of damage, don't you think?». Del resto perché la scena fa ridere? Perché è costruita sulla base di consapevolezze incrociate: lo spettatore sa che il film parla di un serial killer (Lars von Trier lancia i suoi film non appena sa di poterli realizzare, anticipandone alcuni elementi) e sa (desidera?) che Jack ammazzi quella donna; il regista sa che il pubblico sa e gioca al gatto e topo a carte scoperte, portando i suoi personaggi su un piano di coscienza di sé quasi beckettiano (il pre-testo è nel testo, appunto).
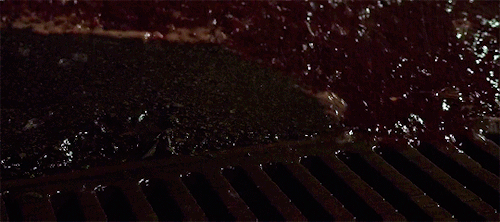 La novità rispetto a Nymph()maniac sta proprio nella spudoratezza con la quale la narrazione viene denunciata come tale: nel precedente le storie, per quanto fittizie (Joe, novella Sherazade, racconta le sue avventure al sultano Seligman), rimanevano credibili, continuavano ad avere un’attrattiva, una continuità, una pluralità di personaggi ancora persuasivi, un po’ di dramma, un pizzico di tensione. Qui no. Qui tutto è dichiaratamente artificioso, scritto senza preoccupazione alcuna di conferire a ciò che si mette in scena la minima plausibilità. Ai limiti del ridicolo. Ridicolo come chiamare degli omicidi incidenti. Ridicolo come trascinare un cadavere con il van senza incontrare nessuno per la strada e poi far intervenire una pioggia a ripulire il tracciato (quella precipitazione è come la meta-neve di Battisti-Panella che, come ogni fenomeno atmosferico che si descrive nelle canzoni, si manifesta quando serve: «la neve tornerà come un pretesto, dipinta e sempre finta», Timida molto audace, 1990). Ridicolo come invitare la donna che si sta per uccidere a urlare dalla finestra di un condominio sicuri che nessuno ascolterà. Perché si è sicuri che non ascolterà nessuno? Perché la nursery rhyme non può fermarsi lì, prevede altre tappe dopo l'omicidio col cric, la donna ammazzata in casa, la casa in cui entrò un poliziotto opportunamente idiota, poliziotto opportunamente idiota che si lasciò sfuggire il van, il van che trascinò il corpo, il corpo che perse sangue, il sangue che la pioggia pulì eccetera eccetera. Tutta roba «dipinta e sempre finta».
La novità rispetto a Nymph()maniac sta proprio nella spudoratezza con la quale la narrazione viene denunciata come tale: nel precedente le storie, per quanto fittizie (Joe, novella Sherazade, racconta le sue avventure al sultano Seligman), rimanevano credibili, continuavano ad avere un’attrattiva, una continuità, una pluralità di personaggi ancora persuasivi, un po’ di dramma, un pizzico di tensione. Qui no. Qui tutto è dichiaratamente artificioso, scritto senza preoccupazione alcuna di conferire a ciò che si mette in scena la minima plausibilità. Ai limiti del ridicolo. Ridicolo come chiamare degli omicidi incidenti. Ridicolo come trascinare un cadavere con il van senza incontrare nessuno per la strada e poi far intervenire una pioggia a ripulire il tracciato (quella precipitazione è come la meta-neve di Battisti-Panella che, come ogni fenomeno atmosferico che si descrive nelle canzoni, si manifesta quando serve: «la neve tornerà come un pretesto, dipinta e sempre finta», Timida molto audace, 1990). Ridicolo come invitare la donna che si sta per uccidere a urlare dalla finestra di un condominio sicuri che nessuno ascolterà. Perché si è sicuri che non ascolterà nessuno? Perché la nursery rhyme non può fermarsi lì, prevede altre tappe dopo l'omicidio col cric, la donna ammazzata in casa, la casa in cui entrò un poliziotto opportunamente idiota, poliziotto opportunamente idiota che si lasciò sfuggire il van, il van che trascinò il corpo, il corpo che perse sangue, il sangue che la pioggia pulì eccetera eccetera. Tutta roba «dipinta e sempre finta».
 Semplice, no? Semplice almeno come il personaggio di Jacqueline Simple.
Semplice, no? Semplice almeno come il personaggio di Jacqueline Simple.
- You know I hate it when you call me Simple. (...)
- To me, your name is Simple, simple.
Del resto la stanza in cui Jack e Verge si incontrano, dietro la fantomatica porta chiusa che si trova nella cella frigorifera, è uno spazio mentale nel quale si compie il processo di rielaborazione che è il film, quella in cui il regista, nella forma del dialogo interiore, si confronta con le cose più terribili, indicibili, impensabili e che porterà Jack e Verge all’epilogo (per questo i Campi Elisi corrispondono alla stessa immagine di beatitudine di Jack bambino, quella dei mietitori: perché è la sua personale, infantile idea di Paradiso che riaffiora nell’ora fatale - Rosebud? -). L'ultima parte è insomma ambientata nella testa di Jack, in una dimensione psicologica in cui Jack/Dante/Lars è autentico, creativo: un livello che sublima, anche attraverso l’Inaccettabile, l’artificiosità degli altri piani dell'opera.
MR. SOPHISTICATION
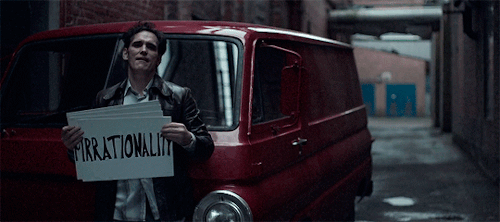
E che questo sia un film-catarsi che si nasconde dietro un racconto posticcio (Lars è Mr. Sophistication, no?), lo dicono gli inserti incongrui, le dissertazioni a contrappunto e questo mix spiazzante tra un registro visivo iperrealista, la parte documentaria e di repertorio e la deriva kitsch-visionaria finale che ha i tratti surreali del lynchiano Twin Peaks 3. O certi stacchetti, come quello che cita Subterranean Homesick Blues di Bob Dylan, il protovideo tratto da Dont Look Back di D. A. Pennebaker dove i cartelli sembrano elencare le keyword di una carriera cinematografica (egocentrismo, volgarità, maleducazione, impulsività, narcisismo, intelligenza, irrazionalità, manipolazione…) e che probabilmente servono a Jack a dissipare, razionalizzandoli, i suoi attacchi ossessivo-compulsivi (che sono anche quelli del regista alle prese con il suo film). E a proposito di musica, ancora una volta la scelta cade su David Bowie (Fame, tratto da quel Young Americans il cui brano omonimo aveva accompagnato i titoli di coda di Dogville e Manderlay), un po’ per l’ambientazione (siamo negli anni 70 e, soprattutto, siamo in America - forse per questo i personaggi sono tutti un po’ stupidi, caro Verge -), un po’ perché Lars ci tiene evidentemente a ricordare a tutti che la fama è importante e che è grazie a quel suo essere un personaggio noto che riesce a fare quello che vuole («Fama, fa acquistare a un uomo il controllo delle cose» canta il Duca) e che lo stesso serial killer è una sorta di popstar (Mr. Sophistication diventa un personaggio delle cui gesta - e performance fotografiche - Jack è molto fiero), un po’ perché (suppongo arditamente) nell’album 1.Outside uno degli alter ego di Bowie è Nathan Adler, detective della divisione Crimini Artistici che indaga sull’omicidio rituale come forma d’arte.
I'LL BE YOUR MIRROR

Jack è dunque un autoritratto. Ed è un catalogo. Il che mi riporta (ebbene sì) a Le valigie di Tulse Luper di Peter Greenaway, film che andrebbe davvero rivisto per comprendere quanto, dopo quasi un ventennio, abbia precorso i tempi da moltissimi punti di vista: altro identikit di un alter ego in cui un regista si specchia, denuda il suo modus operandi e lo fa sotto forma di saggio raffinatissimo e volgarissimo (gli esperti che sezionano la figura del protagonista, la commentano, la confutano), ammiccando ai generi (l’avventura, il dramma, la pornografia, la commedia), scandendo la narrazione in episodi (qui corrispondenti agli incidenti, lì alle prigioni del protagonista), mescolando materiali di repertorio a racconto di spudorata finzione (anche lì c’è un riferimento a Le mille e una notte), oscillando tra realtà e simbolo, richiamando i propri vecchi film, mostrandone stralci. Come fa Lars che non solo riguarda e ripropone il suo repertorio, ma ne esplora anche mitologia e chiacchiera applicate: la misoginia, la perversione (l’infanticidio è un bel modo per aggiornarla), la supponenza. E chiaramente il discorso sul nazismo è ancora un riferirsi a sé, all’episodio cruciale della conferenza stampa di Melancholia che fece di lui, per un po’, persona non grata alla Croisette. Il regista ci torna su, parla dell'Olocausto, fa riferimento ad Albert Speer, fa interpretare Verge da Bruno Ganz, l’ultimo memorabile Hitler del grande schermo. Si diverte così il danese, tra sé e sé, dicendo e non dicendo, e, come Greenaway, cinematografando tutto, risignificando il suo percorso creativo in forma di cinema.
LA CASA DI LARS

E il piano suonato da Glenn Gould farà da sottofondo e leit motiv della narrazione. «Cosa c’entra quest’uomo ridicolo?» chiede Verge. Jack risponde che è Glenn Gould, uno dei massimi pianisti del nostro tempo e che «rappresenta l’arte». E così le dita di Gould ci portano alle dita insanguinate di Jack, ché gli omicidi sono i suoi capolavori, sempre più azzardati, arrischiati, estemporanei (sfide, ostacoli, obstructions - l'ultima impresa prevede dogmaticamente l'uccisione di più persone con una sola pallottola - ). Lars costruisce la sua opera e spiega pezzo per pezzo (cfr. Epidemic) cosa sta facendo.
E la discussione sui lampioni e l’ombra da essi proiettata non nasconde anch’essa, dietro la questione dell’istinto a uccidere, il più comprensibile demone del cinema che puntualmente, contro lo stesso autore, finisce per ripresentarsi e per indurlo a creare? Di come al piacere dell’invenzione succeda il dolore dello squartamento interiore? Non è un caso che Verge la riformuli in termini di dipendenza (e a proposito di dipendenza: l’alcolismo è quella di Lars).
E la virata dantesca (la immaginiamo calcata con un segno ben visibile sulla solita linea che Lars avrà tracciato sul muro e che schematizza l’andamento del film) che cita Delacroix come in un tableau vivant di David LaChappelle, non è anch’essa una finale richiesta di assoluzione? Che si chiude con la sua negazione?
E quella casa che continuamente si riprogetta non è una metafora di sé e della propria opera? In continuo mutamento, ogni volta rasa al suolo e rimeditata, di manifesto in manifesto (il cinema eterosessuale, la Bazzecola, la masturbazione dello schermo, il Dogma eccetera eccetera), alla ricerca del materiale giusto, fino alla conclusione che sarà una sorta di magione stilizzata, un’installazione museale composta di omicidi (le sue opere d’arte, tutte differenti, cadaveri surrealmente “squisiti”): La casa di Jack, per l’appunto, questo film a suo modo assemblativo, riassuntivo, finale.




