
TRAMA
Negli anni Trenta, una donna braccata da malfattori ripara in un villaggio di campagna. Quando la popolazione locale viene a conoscenza di un avviso di ricerca contro la fuggitiva, il clima diventa teso…
RECENSIONI
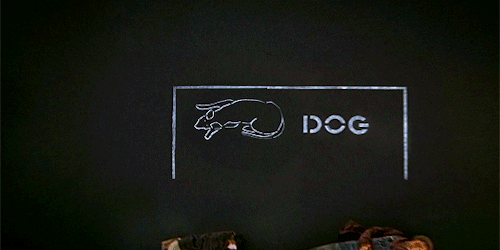
Tra Beckett e il Brecht più estraniato, la nuova opera di Lars von Trier è tanto terribile quanto commovente. Nella spietata analisi dei rapporti umani, il regista prende il microcosmo di Dogville come topos immaginario ed assoluto nel quale giungono in superficie le logiche che sono alla base di ogni sistema sociale: quelle della sopraffazione e del dominio. Non è solo la società capitalista ad essere crudelmente descritta, ma è l’umanità tout court, nel suo impenetrabile impasto di animalità e ragione. Grace, nome che rimanda ironicamente al giansenistico “Tutto è Grazia” (e, ovviamente, all’idea della predestinazione), è la coscienza critica di un’America senza speranza, chiusa nel suo ordine apparente, cinica e popolata di reietti regrediti o “regredendi” allo stadio animale, senza nemmeno la purezza di un animale domestico invisibile ai più. La donna, fuggita dal potere del padre (Il Padrone), ripara nel villaggio con la speranza di ritrovare, tra i disperati, una purezza altrove annegata nel sangue. Con un scrittore idealista vive un amore platonico che le ridà forza e fiducia; con i paysans riscopre la vita, scopre per la prima volta il piacere dell’attività manuale. I personaggi che costellano il microcosmo di Dogville rappresentano le tipologie umane più differenti, accomunate dall’appartenenza al medesimo gruppo sociale: ci sono il cieco finto-vedente (una bella figura triste interpretata magistralmente da Ben Gazzarra) e il rozzo agricoltore (Stellan Skarsgaard, coprotagonista de Le onde del destino); il già citato scrittore idealista, personaggio che conosce una metamorfosi repentina spiazzante ma credibile (da idealista quasi-roosveltiano a cinico difensore della comunità) e la commerciante con l’orticello, piccola proprietaria pronta a tutto pur di difendere il proprio lembo di terra; la paralitica e la maestrina elementare repressa e lassista. La Grazia sconvolge gli equilibri di questa realtà fissa e chiusa. Solo grazie ad un savoir faire miracoloso, la giovane riesce ad essere, almeno in un primo momento, accettata ed amata. Col tempo, la povera Grace viene sottoposta ad uno sfruttamento sempre più crudele ed insostenibile: tiranneggiata dai più, finisce col regredire allo stadio animale, prigioniera di un mondo di poveri non più (o forse mai stati) umili. La sguattera, donna mossa da sentimenti contrastanti – un misto di rassegnazione e rabbia repressa –, accetta passivamente ogni forma di sopraffazione. Come la Watson de Le onde del destino e la Björk di Dancer in the dark, è una vittima sacrificale cui tuttavia viene concesso di sopravvivere e, addirittura, di vendicarsi. Solo un cane, unico esemplare di una purezza, di un candore ormai definitivamente cacciati oltre i confini del mondo, sarà risparmiato alla carneficina finale.
La scelta, spavaldamente antinaturalistica, di ridurre al minimo il décor ed abbattere le pareti delle case non è né un vezzo intellettualistico, né una provocazione fine a se stessa: la scelta di trasformare il villaggio in un panopticon è frutto di una necessità morale oltre che estetica. Abolendo ogni orpello, il regista costringe lo spettatore a concentrarsi sui volti e le azioni dei personaggi, sul rapporto tra i vari membri della comunità e tra gli uomini e le cose (non a caso queste ultime non scompaiono con le pareti ma giocano un ruolo importante in quella dialettica del reale che il regista mira a trasferire sullo schermo in una forma insieme scabra e diretta). Von Trier, facendo propria la massima sull’impossibilità di sfuggire all’alternativa di far torto o patirlo, mostra come, nella società di ieri come in quella di oggi, il sopravvivere equivalga a perpetrare violenza. Grace, fuggita dal carcere impostole dai paesani, ordinando di sterminarli tutti senza pietà, commette un gesto, tra il brechtiano e il surrealista, assolutamente spiazzante, sia per lo spettatore, sia per i personaggi (a cominciare dal padre interpretato da James Caan).
Continua...


Strano che qualcuno abbia ancora voglia di leggere nei film di von Trier delle weltanschauung disperate, metafore della decadenza della civiltà, spietate indagini sulla natura umana, recupero del Tragico. Se pessimismo c’è, nei suoi film, è davvero comico più che cosmico, da tutti i punti di vista. Come conclusione dell’ipotetica trilogia delle “donne sfortunelle che poveracce tutte a loro vanno a capitare”, il Lars ha infatti confezionato un film decisamente stanco, regressivo, regredito ed involuto, dove nessuno slancio/guizzo genialoide riesce a salvarlo in corner com’era successo in passato: l’idea scenografica caratterizzante di Dogville stufa quasi subito e sa di giochino prolungato oltre i suoi tempi fisiologici (a meno che non si voglia leggere l’assenza di pareti come la rappresentazione del regista-demiurgo-dio onnipotente “visivo” che tutto vede, tutto sa, tutto giudica... mah); la camera a mano è ormai un ingiustificato partito preso, ossia metafora di quello che è ormai tutto il cinema di von Trier (e non basta certo a rivitalizzare tale non-scelta una appropriata grammatica filmica povera, con abbondanza di carrellate ottiche, che nella fattispecie fa molto “ripresa live di uno spettacolo teatrale”); l’impostazione letterario-romanzesca è decisamente pesante, specie nell’uso smodato della voce narrante che si fa ben presto troppo insistita, insistente ed invasiva; l’uso degli attor(on)i spogliati della loro componente divistica è esattamente quello che ci si aspetta da von Trier, dunque di interesse prossimo al nullo (a meno che non ci si perda in sciocchezzuole tipo “guarda, la Kidman disposta a ‘sporcarsi le mani’ pur di lavorare con un grande Autore europeo”, ma per piacere); la progressione drammatica e la scansione crudele degli eventi è ormai un personale topos (o così crede immodestamente il Nostro) da riproporre pedissequamente omolog(ata)o da film a film sperando che la gente se lo beva come attestato di autorialità; il finale è la prevedibile, nella sua presunta imprevedibilità, provocazione nella provocazione, con Lars che deve essersi detto “sì, però se chiudo con un altro martirio forse è davvero troppo, magari stavolta ci metto una vendetta, tanto sono o non sono un provocatore? poi qualcuno ci leggerà chissà cosa (mi devo ricordare di metterci anche qualche dialogo pseudoprofondo ma poco chiaro verso la fine, anzi mo’ me lo segno proprio) e così sono apposto anche stavolta... mmm... cazzolina, però, comincia a essere difficile fare me”. Non contento, sui titoli di coda ci sono anche delle istantanee di americani depressi su Young Americans di Bowie: un po’ di critica “sociale” tanto per gradire ma buttata lì, di sorpresa, da prendere sul serio come no, tanto fa lo stesso. Un Lars von Trier, insomma, decisamente alla frutta, schiavo di una pallida caricatura di se stesso (e dire che fino a non molto tempo fa era capace di provocazioni “vere” e inattaccabili come Idioti). Confermano la disfatta le strategie promozionali dietro a Dogville, capaci di confezionare un trailer che, è proprio il caso di dirlo, “è tutto un programma”: gli attori disperati che maledicono la folle, malata genialità di von Trier (compresa la povera Lauren Bacall) parlano da soli e sanciscono, ipso facto, la morte clinica di quella stessa folle genialità, ridotta a triste specchietto per le allodole.


«lo stesso vedere non è forse vedere abissi?»
F. W. Nietzsche, Così parlò Zarathustra
Nel cinema del tempo dell’indigenza tutta la volontà di provocazione di Lars von Trier non viene decisamente a cadere nel vuoto. Il cinema di von Trier nella pur apparente eterogeneità di situazioni si annuncia sempre come dis-corso inevitabilmente autoreferenziale, parla cioè di se stesso, e lo fa nell’unica maniera che il danese conosce ovverosia attraverso la macchina da presa, cinicamente, “dogmaticamente”. Non esiste percorso filmico vontrieriano che non si dia parallelamente anche come riflessione sul cinema. L’esemplarità dell’inquietante finale di Epidemic con il virus-cinema che si diffondeva endemicamente su tutta l’Europa (in quella che si proclamava come predefinita e presunta trilogia europea) prediceva le sorti di un cinema come epidemia necessaria, una sorta di kranckheit zum tod che presto avrebbe invaso altri territori, altre latitudini. In tal senso esiste manifestamente una dichiarazione di intenti da parte di von Trier nel voler inaugurare una trilogia americana e tuttavia non sembra possibile non concepire Dogville nella sua epocalità, vale a dire nel suo (in)temporaneo sospendersi per offrirsi come opera in sé e per sé compiuta, e in certo qual modo a sé stante, anche se poi le sequenze finali ci attendono per nuove ed inattese aperture, ma su questo dovremo tornare più diffusamente.
Il primo elemento che si mostra nella sua problematicità è proprio quello topologico, c’è un interrogativo che già subito reclama il suo porsi: qual è il senso dell’America vontrierana, ovvero, più semplicemente, di quale America sta parlando von Trier se davvero sta parlando dell’America?
Si ha la netta impressione che Dogville si innalzi metaforicamente sorvolando ogni tentativo di fornire una mappatura topologica attraverso coordinate geografiche, storiche, sociologiche, politiche e filosofiche, proprio sulla scorta dell’ignoranza dichiaratamente esplicitata dall’autore stesso in merito al “territorio” statunitense. Sotto questo aspetto l’America potrebbe tranquillamente metaforizzare universalmente una sorta di indefinita zona dell’altro(ve) in cui la catastrofe del cinema epidemico deve compiersi. Si impone con una certa evidenza il fatto che Dogville non abbia nulla di americano se non filtrato dai paradigmi concettuali vontrieriani fin troppo manifestamente europei (anche il becero quaccherismo delle origini degli abitanti di Dogville appare come topos evidente di un sapere sommario da parte del cineasta, per non parlare del ludus puerorum attraverso il quale affronta, deridendolo tragicamente, il riferimento gangstermovieristico) in cui i referenti più prossimi siano Samuel Beckett, Brecht, Bernhard, Dostoevskij e (soprattutto) Nietzsche, autori dichiaratamente (predi)letti e frequentati da von Trier. Anzi, proprio l’ultimo tra questi, Nietzsche (almeno un certo Nietzsche vista e considerata una storia degli effetti talmente conflittuale che sembra non dover/poter cessare) riteniamo possa fornire una chiave di lettura non fuorviante che sia in grado introdurci nei meandri teorici di Dogville.
Incipit tragoedia
L’epidemia (del/-) cinema si annuncia come evento tragico e la tragedia ha sempre, costitutivamente, a che fare con la rappresentazione. E’ in questo solco che si insinua il discorso estetico di Lars von Trier. Le frequenti plongée sulla cittaduzza di Dogville, questa improbabile planimetria del non-luogo che somiglia a una sorta di monopoli dell’assurdo (in cui ogni tappa, ogni spostamento sono vengono pagati con l’obolo di un lacerante soffrire), in virtù delle quali von Trier sembra lanciarsi, più che un mallarmeano coup de dés, in un creativo coup de idée, ci costringono a riflettere sul senso dello spazio rappresentato (/rappresentante) come eminente luogo della finzione.
È innegabile che in von Trier, oltre alla supponenza della proclamazione di un “voto di castità” come infinito amore per il cinema e dunque come volontà di purezza e necessità, esista anche una irridente volontà di falsità, di finzione. In questi termini diviene comprensibile la sua volontà di concepire il set come tavolo da gioco, come spazio teatralmente ludico, o ludicamente teatrale su cui vanno un po’ giocate le sorti del cinema. E chi abbia una qualche dimestichezza con le considerazioni huizingaiane (Homo Ludens) e gadameriane (Verità e metodo) sa benissimo che il gioco è una cosa seria (forse la più seria di tutte): si gioca mediante regole (il Dogma ’95, tanto per intendersi).
Attraverso una delegittimazione del privilegio dell’occhio, del vedere (pur non essendone destituita di valorel’istanza scopica), che sembra provenire da e prolungare il discorso di Dancer in The Dark, Von Trier lavora non esattamente per sottrazione ma piuttosto per astrazione affidandosi ad un discorso semiotico che fa leva sulla disseminazione dei significanti. La sottrazione degli elementi spaziali danno luogo alla funzione attanziale del segno: più lo si “spoglia” del significante e più lo si carica di senso rivestendolo di simbolicità.[1] Il gioco del denudamento si avvicina moltissimo al paradosso dell’assenza (la nostra at-tenzione si rivolge a cio che è assente proprio per il suo essere assente, presentificandolo in modo ancor più esemplare della semplice presenza, in questo senso il dominio del simbolico che cade sotto le figure retoriche dell’allegoria e della metafora si pone come esatto contrario del fattuale, dell’evidente che ha la litote come topos retorico). Allora è sufficiente un (di)segno a costituire un set, un espace theatralizé, per (de)costruire mediante il senso della mise en scène un discorso di rappresentazione filmica, in cui vengono rappresentati, ovvero ri-presentati aristotelicamente gli umani accadimenti attraverso una mimesi estetica: la filmicità presenta gli stessi limiti spaziali che appartengono al set, come lavagna concettuale in cui von Trier disegna la realtà. Non ha più senso dunque parlare di confine tra realtà e finzione, ed è questa poi la posta rimessa continuamente in gioco della cinematografia vontrieriana, neanche in termini dialettici. Il cinema (non) è il cinema. Questo è l’approdo teorico godardiano tautologico, paradossale e che comunque sintetizza le già avvenute conclusioni di Vertov, Wells, Hitchcock e Carmelo Bene.
Dogville si pone come estremo ribaltamento di qualsiasi “città ideale”, come antitesi antipodica della agostiniana civitas Dei. E’ la città del cane, o dei cani, il finis terrae in cui non si può neanche più accedere (c’è il ringhio di un cane, e cioè un cane che ringhia a sorvegliarne la soglia d’ingresso) perché le sorti di un’umanità verso il baratro sono già tutte lì, e da cui non si può evadere poiché il limite delle montagne rocciose ne sottolinea l’insormontabilità. D’altronde, non occorre neanche spendere troppe parole sul fin troppo evidente intento vontrieriano nell’inseguire una metonimica del cane nelle sue derive semantiche e simboliche più deteriori (il cane come simbolo della bestialità in genere).
La Erfahrung di Grace
Uno dei primi percorsi che Dogville (ci) costringe a compiere è quello che mette in opera l’esperienza diegetica, l’esperire cioè una testualità disomogenea e frammentaria, un senso narrativo f(r)atto dalla scansione in capitoli del racconto. Tutto ciò contribuisce a creare quella che a ragione potremmo chiamare la fabulizzazione del contingente in cui, come si è visto, il senso filmico tende a sfumare i confini tra realtà e finzione, ove quest’ultima costituisce comunque il modo per rendere esemplare il reale (lo spazio, il tempo, il moto, i caratteri), per raccontarlo, ri-presentarlo e ri-figurarlo sotto altra forma. A tal proposito seguiamo Klossowski: “Favola, fabula, deriva dal verbo latino fari, che significa sia predire, che divagare, predire il destino e divagare, perché fatum, il destino, è anche il participio passato di fari. […] Così, quando si dice che il mondo è divenuto favola, si dice che esso è il fatum, si divaga, ma divagando si vaticina e si predice il destino…”[2]. Von Trier vaga e divaga molto su un personaggio, Grace, che ha già (in)scritto il suo destino (nella pellicola). Esiste un passo decisivo nello Zarathustra nietzscheano in cui, tra l’altro, si parla, guarda caso, di sciocchi cani che latrano, che ci aiuta a comprendere questa figura centralissima nell’economia dell’opera vontrieriana: “La compassione è l’abisso più profondo: quanto più a fondo penetra l’uomo nella vita, tanto più a fondo penetra nel dolore.”[3]. Il termine chiave su cui soffermarsi è “abisso” che rimanda ad un percorso in discesa (ab-ire) dove ciò che più ci interessa è comunque l’andare, il senso di uno spostamento dell’essere che a sua volta ci richiama molto da vicino alla tematica romantica e precisamente novalisiana del fremde (Heinrich Von Hofterdingen) il quale ci suggerisce che occorre subire uno sbalestramento esistenziale, attraverso una dislocazione spaesante (unheimlichkeit) per potersi riappaesare presso di sé, per poter riacquistare l’intimità della propria heim. Grace deve attraversare un percorso esperienziale dislocante/espropriante per poter tornare a se stessa. Questo è il senso della sua erfahrung (termine tedesco di matrice teutonica che traduce il latino eundo assequi). Un’ esperienza dolorosa (erfahren significa anche, in una delle accezioni più feconde di senso, soffrire, patire) che si compie (er) necessariamente attraverso un viaggio (fahren). Si preannuncia per Grace (una Kidman rivestita di divo fulgore) una lunga , perigliosa, lenta e lancinante discesa negli inferi di questo non-luogo (a procedere) che è Dogville e che parallelamente coincide con un abissale sprofondamento nei tortuosi anfratti della psiche (lo spazio, oltre alla sua connotazione topografica, si fa mentale – ulteriore elemento di con-fusione nel sublime gioco tra realtà e finzione), con la traballante, sapiente, studiata invasività della macchina da presa, a-mano troppo a-mano, pronta a pedinarne ogni passo, a seguirne ogni espressione a registrarne ogni fremito, ogni afflato, ad intermittenze, incessantemente quasi a volerne smorzare i lacera(n)ti singulti dell’anima. Von Trier riesce a giungere a tali livelli di astrazione espressiva tanto da rendere tutta la straniata corporeità deambulante dello spazio finzionale nient’altro che diafani spettri concettuali i quali, quasi simboli di se stessi, avvolgono lentamente, con le loro mefitiche presenze la femminilità umiliata e offesa di Grace, ammantandola di oscura e subdola malignità. In quello che si configura come il suo iter catabatico, la sua discesa nello schattenreich (il regno delle ombre) Grace ha bisogno di simulacri più tangibili (le statuette che Vera in una delle sequenze più crude(li) del film le romperà a una a una) per l’angoscia di non essere assalita dall’abisso del male metafisico in cui vigila il principio dell’homo homini canis di quelle inquietanti figure: il “malologo” Chuck che non ammette che chi ama le mele non debba per ciò stesso amare anche lui, sua moglie Vera, i loro bambini che recano tutti nomi omerici e che dunque dovrebbero rimandare alla nobiltà di sentimenti eroici e che invece si rivelano piccole figure cacodemoniche, giovani carogne dalle psicologie polimorfe e perverse pronte a ricattare e percuotere moralmente Grace che di loro si prende cura, la bieca meschinità del trasportatore del villaggio, il cieco che a una eterea metafisica della luce finisce col preferire il libertinismo del “tocco”, l’insignificanza fatta persona di Thomas Edison padre, e il figlio che tradirà il suo amore, la cosa che fino ad allora l’aveva salvata dalla morte interiore e dalla rovina psichica, per sordidi interessi personali, denunciando la non appartenenza di Grace a Dogville, straniera in terra straniera, e infine il cane Mosè, bestia idiota che continua incessantemente ad abbaiare (d)al nulla.
Dell’oltrepassamento come destino dell’essere (umano)
È nelle strazianti sequenze del finale che si compie tutta la destinalità di Grace, ma non senza l’avvento salvifico della assai rilevante figura paterna, l’unico uomo che si(/ci) illude di aver compreso il senso dell’oltrepassamento così come lo übermensch nietzscheano. Le parole del padre gangster (“Tu sei l’essere più arrogante di questo pianeta”) sono rivelatrici come quelle di Nietzsche quando sempre nello Zarathustra parla del “morso della vipera”: “Se avete un nemico, non ripagategli il male col bene: poiché farebbe vergogna. […] Ed è meglio che colpiate con l’ira piuttosto che con la vergogna! E quando vi si maledice, non mi piace che vogliate benedire. Meglio che malediciate un po’ anche voi. E se vi fu fatto un grande torto, subito voi fatene cinque piccoli! Orribile a vedersi è colui che solo torti opprimono. […] Una piccola vendetta è più umana di nessuna vendetta.”[4]. L’arroganza più grande è quella del perdono poiché presuppone uno status ontologico differente, cosa che non si dà negli esseri umani. In questi passi si gioca tanta della cosiddetta “immoralità” di Nietzsche e che il padre di Grace sembra invece accogliere molto candidamente tanto che il pensatore tedesco potrebbe addirittura sentenziare attraverso questa figura zarathustriana inventata da von Trier proprio sul finale: “ […] dove non si può più amare, là si deve passare oltre!”[5]. Questa überwindung epocale deve avvenire mediante una decisione. Una decisione che presuppone coraggio come suo elemento fondante.[6]
La decisione, qualsiasi decidere, ha qualcosa a che fare, anche semanticamente, con un accadere e questo accadere si decide nell’istante dello sparo, quando Grace uccide Tom e quando un grande evento si compie: l’e-venire dell’oltrepassamento. Lo stoicismo deriso da Vera ma, beffardamente, eternamente ritornante sancisce l’amor fati del “santo dire sì” da parte di Grace alla decisione che deciderà di lei. Il suo destino di oltrepassamento è finalmente compiuto. Di Tom e di tutti gli strani abitanti di Dogville ne resta una bruciacchiata memoria fotografica.
L’unica cosa che Grace in tanto cuore di tenebra non può compiere è una danza, foss’anche una totentanz, poiché solo la Selma di Dancer in The Dark poteva danzare dentro la propria oscurità.



