TRAMA
Venticinque anni dopo l’agente speciale Dale Cooper è ancora intrappolato all’interno della Loggia Nera. Il suo doppelgänger è invece libero nel mondo reale, ed è invischiato in diverse attività criminali.
RECENSIONI
TWIN PEAKS EMPIRE

«I don’t know where I am»
Jerry Horne
Los Angeles. 3 ottobre 2014. Ore 8.30.
Dear Twitter Friends: That gum you like is going to come back in style. #damngoodcoffee
David Lynch e Mark Frost annunciano con un tweet il ritorno di Twin Peaks. Non è uno scherzo, Laura Palmer ha mantenuto la promessa che ci saremmo rivisti dopo 25 anni. Un sogno che prende lentamente forma dopo numerose contrattazioni con l’emittente Showtime e dà vita a una serie di 18 parti, tutte rigorosamente dirette dal regista di Missoula che esorcizza con decisione le difficoltà incontrate in passato.
Torniamo un attimo indietro. È evidente come Lynch abbia in parte rinnegato le prime due stagioni di cui, per motivi produttivi, non riuscì a controllare fino in fondo lo sviluppo. Ma qualcosa era rimasto in sospeso, troppi misteri aleggiavano ancora su Twin Peaks. Ecco quindi la nascita di Fuoco cammina con me, il prequel sugli ultimi giorni della vita di Laura Palmer, presentato in concorso al 45° Festival di Cannes e massacrato tanto dalla critica tanto dal fandom della serie. Riguardo all’accoglienza negativa rimane indimenticabile lo sfogo di Quentin Tarantino che promise di non vedere mai più un film di David Lynch se non avesse deciso di raccontare una storia diversa da questa.
Col tempo però Fire Walk with Me è diventato un piccolo oggetto di culto, l’oscura e libera rilettura di un immaginario che aveva ancora molto, troppo da dire. Perché se c’è un aspetto del cinema di Lynch su cui (credo) siamo tutti d’accordo è che non c’è mai fine al mistero; quello che conta infatti è l’inner voyage, il suo valore esperienziale indipendentemente dal punto di arrivo. L’arte può essere indubbiamente un mezzo, una soglia da attraversare e dove perdersi meravigliosamente, ma sempre con la consapevolezza che non potrà mai dare delle risposte che sono, per fortuna, dentro di noi.
Torna alla mente l’ironico sberleffo nei confronti dello spettatore in Fuoco cammina con me. Desmond è insieme al suo partner e, guarda caso, a Gordon Cole prima di intraprendere le indagini sul caso Teresa Banks. Appare Lil, una donna completamente in rosso, che recita come un mimo e fa strane smorfie, tutti segni in codice che il detective prontamente interpreta. Ma c’è un dettaglio che colpisce l’occhio, una rosa blu, l’elemento estraneo che risucchia ogni forma di interpretazione logica, di cui non viene data una risposta. Ritengo da sempre questa sequenza la ghignante presa di posizione di David Lynch nei confronti di chi è ossessionato dal senso, che cerca sempre delle risposte definite invece di abbandonarsi alle domande.
Ora arriva la patata bollente. Come affiancarsi a questa opera fondamentale e seminale che è Twin Peaks: The Return, dopo quanto scritto?
Cercherò di creare suggestioni passando da un universo all’altro interno alla serie che, mai come in questo caso, è l’INLAND EMPIRE della filmografia del regista.
Diane, I’m entering the Twin Peaks EMPIRE.
«I can't seem to remember if it's today, two days from now, or yesterday. I suppose if it was 9:45, I'd think it was after midnight! For instance, if today was tomorrow, you wouldn't even remember that you owed on an unpaid bill. Actions do have consequences. And yet, there is the magic. If it was tomorrow, you would be sitting over there.»
(Neighbor – INLAND EMPIRE)
Home
 Un ritorno a casa. Nel proliferare di sottotrame, nel riavvicinamento emotivo ai personaggi a noi familiari, nell’introdurre nuovi volti, nuove eredità generazionali, Twin Peaks crea un mondo corale, fatto di tasselli che piano piano iniziano a legarsi gli uni con gli altri, ricuciono lo strappo con il passato, l’ellissi di 25 anni.
Un ritorno a casa. Nel proliferare di sottotrame, nel riavvicinamento emotivo ai personaggi a noi familiari, nell’introdurre nuovi volti, nuove eredità generazionali, Twin Peaks crea un mondo corale, fatto di tasselli che piano piano iniziano a legarsi gli uni con gli altri, ricuciono lo strappo con il passato, l’ellissi di 25 anni.
Ma dove è Twin Peaks? E’ ancora possibile ricongiungersi a quell’immaginario così lontano nel tempo?
Lo scorrere degli anni è spietato, la vecchiaia è incisa nella pelle dei suoi abitanti, ma contemporaneamente è come se fossimo rimasti sempre lì, nell’attesa che qualcosa potesse accadere di nuovo.
Is it the future or the past? Il tempo è tiranno, ma insieme allo spazio rivelerà presto se stesso, la propria natura relativa e illusoria, per aprirsi alla sincronicità di mondi paralleli, per riavvolgersi e nuovamente distendersi. Siamo dentro sì imbrigliati, dobbiamo sì svegliarci, ma non ha molta importanza il punto di arrivo, quanto il cambiamento di stato che permette alla visione di rileggere, infinite volte (?), un universo che funziona come la nostra mente.
Perché Twin Peaks è dentro di noi e la memoria cerca gradualmente di riconnettersi a quella fonte.
Lo spettatore percepisce quasi da subito che l’errare di Dale/Dougie e il suo doppelgänger ha come meta la cittadina, il luogo dove tutto è iniziato e dove potrebbe esaudirsi il sogno di rivivere, ancora una volta, quell’unicità di tanti anni fa. La sensazione però è che la presenza di Twin Peaks sia immanente, nei dettagli, nei rimandi, nelle suggestioni sonore, è intorno a noi, ma allo stesso tempo avvolta dal velo dell’oblio.
Ed ecco che Dougie, privo di ego, in una regressione sia infantile che senile, combacia pienamente con questo stato d’animo. Uno sguardo che subisce le situazioni, l’incarnazione perfetta della mediocrità umana, che vive intrappolato nella routine ed è paradossalmente costretto a esperire la realtà che lo circonda in maniera diversa. Dougie sente, non agisce, non vuole come Bad Cooper, ma ha realmente bisogno dell’altro, è patologicamente dipendente. E per sopravvivere ha bisogno proprio di Twin Peaks che, mediante l’apparizione di Mike, lo guida nel districarsi dagli ostacoli di volta in volta incontrati.
Poi, all’improvviso, mentre si sta gustando la sua amata cherry pie, giunge l’epifania che lo libera.
Un cortocircuito teorico oltre che fisico. Il risveglio di Dale, infatti, avviene durante la visione in TV di Sunset Boulevard di Billy Wilder, quando viene nominato Gordon Cole, personaggio minore della pellicola dal quale il regista ha preso il nome per interpretare il Direttore dell’FBI.
L’immaginario feticizzato della Loggia Nera termina così di fare da tramite per Dougie, non lo guida più.
Lynch ci riporta a Twin Peaks, facendoci dimenticare Twin Peaks stessa, abbandonando quell’impianto fatto di aspettative, memorie, leit motiv, che ci ha congelati in una beckettiana attesa. E tutto questo grazie al cinema, in un dialogo impossibile tra mondi, dove per l’ennesima volta è un tramonto a segnare un nuovo inizio.
Dreams
 Quanto sognano i personaggi di David Lynch. Il sogno è quasi sempre l’anticamera di un risveglio, di una nuova comprensione della “realtà”. Parlare però di realtà è assai fuorviante, soprattutto rapportandoci a un universo dove non esistono vere e proprie dicotomie, ma piuttosto stati diversi di consapevolezza in quell’angosciante e misterioso percorso che vive di continui superamenti di soglie, di porte che si aprono, di nuovi stadi di un viaggio destinato a non fermarsi mai.
Quanto sognano i personaggi di David Lynch. Il sogno è quasi sempre l’anticamera di un risveglio, di una nuova comprensione della “realtà”. Parlare però di realtà è assai fuorviante, soprattutto rapportandoci a un universo dove non esistono vere e proprie dicotomie, ma piuttosto stati diversi di consapevolezza in quell’angosciante e misterioso percorso che vive di continui superamenti di soglie, di porte che si aprono, di nuovi stadi di un viaggio destinato a non fermarsi mai.
Ed è proprio Gordon Cole a spingerci verso una suggestione che invece di dare una risposta ci mette di fronte a un quesito insuperabile. Who is the dreamer?
La sequenza è a dir poco bizzarra: l’apparizione di Monica Bellucci fuori da un caffè parigino, in una situazione familiare (Gordon Cole sta forse sognando di essere proprio David Lynch?), contempla la natura stessa di questo intricato gioco di scatole cinesi [1]. Se viviamo dentro un sogno, come ci dice Philip Jeffries in Fire walk with Me, chi è che realmente sta sognando?
Ecco quindi che quello sguardo in macchina di Cole sembra dirci che facciamo parte del gioco e forse siamo proprio noi la fonte di questo flusso magico. Certo, potremmo lanciarci in terreni complessi, molto più pericolosi di queste probabili sovrainterpretazioni e trarre spunto dagli interessi del regista nei confronti delle tradizioni orientali (The Mandyuka Upanishad?), ma meglio restare dentro la serie e perderci nuovamente nel vortice di interrogativi.
Di sicuro il sogno è un piano in cui i personaggi riescono ad anticipare qualcosa del futuro, riconfermando per l’ennesima volta quel cortocircuito temporale, che ci impedisce realmente di stabilire una sequenzialità tra gli avvenimenti messi in scena.
Ma probabilmente è solo attraverso questo stato che si può entrare un pochino più in profondità. Pensiamo a Freddie, un cockney che proprio grazie all’apparizione di Cooper diventa un bizzarro supereroe (l’ironia, come in tutto il cinema di Lynch, è abbagliante) e incarna la nuova generazione come mezzo per superare le stasi del passato. Ed è tutto fondato sul credere, credere fermamente ai segni, cercare di andare oltre all’apparenza e alla banalità letterale. Alla faccia di quello zoticone di Chad!
I personaggi che dicono di aver sognato e hanno un’interpretazione di quello che sta per accadere sono tanti, ma a colpire è come tutta la rappresentazione sia strutturata a mo’ di lavoro onirico. Non si tratta infatti solo di sognare, quanto di vivere dentro un sogno, in una maglia, una tela che unisce tutto Twin Peaks.
E proprio lì, nell’ufficio dello Sceriffo[2], che Cooper dopo la sconfitta di Bob comprende che siamo vicini all’ennesimo risveglio. La splendida sovraimpressione del suo primissimo piano con la famiglia nuova e vecchia di quel luogo ci suggerisce già il passo successivo.
Richard o Cooper? La televisione è spenta, I’m deranged. Ci siamo però svegliati o siamo nuovamente dentro l’ennesimo sogno?
Non si discute quanto l’ultimo episodio della serie crei un forte stato di disagio e frustrazione allo spettatore.
Indipendentemente dalla lettura narrativa più “logica”(Judy ha creato un mondo parallelo e ha intrappolato, di nuovo, il protagonista), ci colpisce questa uscita brusca e non appagante dall’immaginario a noi familiare.
È però lì che la poetica del regista mostra un grande coraggio. Una stagione di 18 puntate che ti ammalia con i live al Roadhouse [3], che evita chiusure sospese, trova il suo cliffhanger definitivo nel season finale.
Un urlo che riecheggia, la constatazione dolente che l’unico happy ending possibile è un tulpa che riabbraccia una famiglia ritrovata. Essendo però Laura the one, è inevitabile che la ricerca continui, che non possa mai fermarsi. Siamo usciti da Twin Peaks ed è lì il cuore della serie che è ben riflesso nel personaggio di Cooper. Nell’incessante movimento verso la verità, l’abbandono e la rinuncia di ciò che ci lega è molto spesso necessaria, ma non sarà certo l’arte a dare una risposta. Perché se c’è qualcosa che Lynch non vuole è prendersi l’arroganza di esaurire il mistero. Tutt’altro. Il suo sguardo rivendica come la ricerca non debba mai finire. Probabilmente, non siamo ancora pronti per un vero risveglio.
[1] Nell’intro della sequenza che vede l’apparizione di Jeffries (Fire Walk with Me), Lynch ci mostra questo aspetto in modo subliminale.
All’esterno della sede dell’FBI c’è una campana. Un movimento di macchina ne inquadra subito l’ombra sottostante, per poi trovare un’ulteriore corrispondenza nello stacco di montaggio all’interno dell’ufficio di Cole. La prima cosa che vediamo, infatti, appesa su una colonna è il disegno incorniciato della campana stessa.
[2] Si noti come il ritorno a Twin Peaks inizi con un’alba che filtra. Anche questo è un suggestivo risveglio.
[3] Sarà Audrey a risvegliarci/si.
.....
Meditation ...

... in love
....
- I tuoi quadri sembrano raffigurare il mondo dalla prospettiva di un bambino in preda al terrore; è una descrizione plausibile?
- Direi proprio di sì. Amo ciò che riguarda l'infanzia perché quando si è bambini il mondo è così ricco di mistero. Persino una cosa semplice come un albero è inspiegabile. Lo vedi da lontano e sembra piccolo, e invece man mano che ti avvicini pare che cresca; da bambino non riesci ad afferrare le regolE. Noi crediamo di capirle quando diventiamo adulti, ma ciò che sperimentiamo in realtà è un restringersi dell'immaginazione. –
Childish squiggles
 Dougie fa un po’ il pappagallo, ma molto spesso nella ripetizione dell’ultima frase del suo interlocutore apre uno spiraglio di senso. E’ il caso della consegna dei file cases a Bushnell, con questo che si lamenta dei disegni infantili presenti sui documenti. Dougie col suo sguardo perso sussurra: Make… sense of it.
Dougie fa un po’ il pappagallo, ma molto spesso nella ripetizione dell’ultima frase del suo interlocutore apre uno spiraglio di senso. E’ il caso della consegna dei file cases a Bushnell, con questo che si lamenta dei disegni infantili presenti sui documenti. Dougie col suo sguardo perso sussurra: Make… sense of it.
Si tratta di un vero manifesto di come Lynch guarda alla rappresentazione. E mai come in Twin Peaks: The Return abbiamo potuto godere di una libertà espressiva che rielabora la propria filmografia e la sua profonda passione per la pittura. Un’esperienza visiva tanto virtuale quanto tattile, che innesta registri diversi, che rielabora l’iconografia vintage della serie come ce la ricordavamo e irrompe con suggestioni pittoriche, evoluzioni infantili dei personaggi (The Arm e Jeffries), che usa i dispositivi 2.0 come nuove traiettorie mentali, che non ha paura di forzare le immagini, ma le filtra attraverso gli occhi di un bambino giocoso nello sfidare la sicurezza della verosomiglianza.
Twin Peaks è inoltre un’opera divertita nel dialogare con i film precedenti di Lynch. Mai come in questo caso, infatti, l’autore riesce a integrare il passato del suo cinema dentro questo nuovo impero seriale, da Eraserhead fino a INLAND EMPIRE.
Un approccio a dir poco radicale, che tuttavia si presta a gestire i misteri, le svolte narrative, con un’inaspettata semplicità. Certo, stiamo sempre parlando di un cinema tutt’altro che a tesi. Gli enigmi però di volta in volta vengono inquadrati, svelati nel loro funzionamento. Rispetto alle opere precedenti Lynch ha molto a cuore che lo spettatore si agganci alla/alle storia/storie e inizi a decifrare i tanti interrogativi lasciati in sospeso 25 anni prima.
Probabilmente la sensazione è quella di voler chiudere un cerchio, una fase, un immaginario per poi andare oltre e deragliare in un Texas pronto a distruggere tutte le nostre nuove “certezze”.
Pensiamo solo alla spiegazione della rosa blu, dei tulpa, dell’origine del Male, etc.
Lo spettatore si interroga, ma contemporaneamente può inserirsi nel discorso senza precipitare nei vicoli ciechi con cui il regista ci ha abituato in passato.
Non sto parlando di semplificazione, attenzione, quanto della lucida capacità di un autore che vuole portare il suo spettatore oltre la banale decodifica. Questo perché pur con tutte le spiegazioni suggerite da Cole e compagnia, il nuovo mistero è pronto a emergere e a rompere una glass box
Sex
“Tu non mi avrai mai!”
(Alice – Strade Perdute)
 Nel cinema di David Lynch il sesso ha un ché di alchemico.
Nel cinema di David Lynch il sesso ha un ché di alchemico.
Quasi sempre l’unione intima crea una trasformazione nel mondo circostante o, il più delle volte, è causa disfunzionale dei rapporti.
Guardando al passato gli esempi sono tantissimi. Henry, in Eraserhead, ha rimosso l’amplesso con la sua ex fidanzata, ma è proprio attraverso il sogno di un amplesso con la vicina di casa che sprofonda (in tutti i sensi) dentro la propria follia. In Velluto Blu e in Cuore Selvaggio la sessualità brucia ed è indissolubilmente legata con la violenza. Si pensi solo al killer interpretato da Grace Zabriskie che uccide il povero investigatore dopo un rapporto sessuale animalesco con il suo partner. In Strade Perdute la sequenza di sesso nel deserto, fortemente metacinematografica, toglie il velo all’illusione a Pete. L’unione fisica di Betty e Rita in Mulholland Drive prepara al risveglio dentro l’incubo, mentre Nikki inizia a perdersi nel ruolo proprio durante una (messa in) scena di sesso con Devon/Billy.
Questa veloce panoramica introduce le tre scene presenti in Twin Peaks: The Return.
L’ingenuo giovane della glass box baconiana, è tutto fuorché uno sguardo attivo. Un oggetto, parte integrante di un sistema di telecamere a circuito chiuso che registrano 24 ore su 24 l’invisibile (cfr HAL 9000).
Nella gelida operazione meccanica è proprio il sesso clandestino con la sua compagna a canalizzare Judy e a scardinare, in tutti i sensi, questa logica di controllo e lontana da qualsiasi partecipazione sensoriale.
Discorso diverso per il nostro Dougie, il quale non nasconde con un primo piano grandangolare il piacere di essere, anche in questo caso, totalmente alle dipendenze di qualcun altro.
Ma è senza dubbio l’angosciante sequenza d’amore (?) tra Cooper e Diane a rimanere impressa e a confermare nuovamente come ci sia tra un uomo e la donna un enorme difficoltà a vivere pienamente, spiritualmente, un atto fisico.
L’incontro tra i due, che poteva esorcizzare il trauma della violenza inflitta dal Bad Cooper, si rivela invece un dolorosissimo addio, uno sprofondamento nel buio che ricorda quell’oscurità, riscontrabile pure nel nero delle lenzuola, tra Renee e il marito in Strade Perdute.
E guarda caso proprio dopo questo amplesso che avviene il risveglio, portando il protagonista in una realtà nuova, nella quale a cambiare sono persino le identità.
Electricity.
 Nell’universo lynchano tutto è interconnesso, le varie realtà convivono e dialogano grazie a un campo (unificato) elettrico. Anche qui le suggestioni che vengono dall’Est sono abbastanza evidenti. Ciò che però colpisce di questa Legge è il modo in cui il regista la manifesta.
Nell’universo lynchano tutto è interconnesso, le varie realtà convivono e dialogano grazie a un campo (unificato) elettrico. Anche qui le suggestioni che vengono dall’Est sono abbastanza evidenti. Ciò che però colpisce di questa Legge è il modo in cui il regista la manifesta.
Prese a parete, accendisigari delle auto, cavi. Oggetti a noi familiari assumono un’aura perturbante e diventano canali che deformano lo spazio e il tempo.
Questa suggestione giunge da lontano. Già in Eraserhead, infatti, la mente di Henry veniva paragonata a circuito elettrico, con tanto di demiurgo che ne controllava il corretto (?) funzionamento. Quello che però colpisce è come gli oggetti quotidiani, così vicini a noi, non sono mai quello che sembrano e trascendono il loro significato prettamente letterale.
E se ci pensiamo bene, la sensazione è simile quel tipo di incertezza che viviamo nei sogni, dove molto spesso elementi quotidiani slittano di senso e sfuggono alla nostra comprensione immediata.
Chi ha ucciso Laura Palmer?
“Find Laura”
Leland Palmer
 Il Fireman vive dentro un cinema, interagisce con i mondi attraverso uno schermo quasi si trattasse di un touchscreen, postproduce, modifica, ritaglia, porta avanti la sua regia per ostacolare il Male.
Il Fireman vive dentro un cinema, interagisce con i mondi attraverso uno schermo quasi si trattasse di un touchscreen, postproduce, modifica, ritaglia, porta avanti la sua regia per ostacolare il Male.
La magia di poter manipolare il tempo è l’occasione perfetta per un atto eroico che allo stesso tempo dà la sensazione di infrangere un tabù: salvare Laura Palmer.
Ebbene sì, Cooper torna indietro. Twin Peaks: The Return entra dentro Fire Walk with Me (che è in b/n!), si crea l’impossibile riscrittura filmica che permette alla giovane ragazza di sfuggire dal proprio destino.
E’ l’atto iconoclasta definitivo, la sovversione totale del cuore della serie. E ora? Chi ha ucciso Laura Palmer? No, Laura Palmer non è stata uccisa, è sparita, in un’altra dimensione, con un altro nome, 25 anni prima.
Il lieto fine però non è da contemplare, perché Lynch ci ha dimostrato più volte come il Bene (rappresentato proprio dalla martire Laura) non è al sicuro. Viviamo dentro un sogno, ma forse è più vicino a un terribile incubo, dove i nuovi pagano il karma dei genitori (si guardino le varie sotto trame della serie).
In questo magnifico viaggio dentro le immagini, si formalizza una volta per tutte l’allontanamento da Twin Peaks, dalle coordinate che poco prima avevamo ritrovato. Siamo usciti da una televisione, che adesso è spenta, come ci fa ben capire la soggettiva di Richard al risveglio. Il viaggio però continua e dentro di noi, il nome di Laura può riemergere, portandosi con sé la paura di un tempo.


Di cosa parliamo quando parliamo di Lynch (?)
Se, qualche anno fa, mi avessero chiesto di legare David Lynch a un elemento, avrei risposto «aria».
Esiste però, a mettere almeno in parte in dubbio le mie convinzioni, un volume, pubblicato nel 2017 da Mondadori, dal titolo In acque profonde. Meditazione e creatività (il titolo originale è Catching the Big Fish: l’immagine resiste, rimandando anche all’onirismo burtoniano). Il testo raccoglie numerosi pensieri del regista di Missoula – si spazia da Kubrick, autore amatissimo, alla musica, dal dolore fino alla solidarietà –, compatti sotto l’egida della meditazione trascendentale. Su quest’ultima il regista afferma: «la meditazione trascendentale è appunto il tramite che ti conduce alla beatitudine. La cosa essenziale, però, è vivere in contatto con l’oceano di pura coscienza di beatitudine.» La densità del fluido – l’oscurità degli abissi, per la precisione – non l’impalpabilità e l’evanescenza del soffio. O forse, a voler essere un po’ indulgente con le mie sensazioni, una crasi eletta fra i due; per dirla con l’epigrafe di John Keats: un regista la cui arte è scritta sull’acqua. Poiché Lynch stesso, con quel suo ciuffo che sfida la forza di gravità e una leggerezza che è davvero quella dell’oiseau, rappresenta la fusione di mondi di un altro mondo, e il suo immaginario è come un dipinto di Claude Monet: quante ninfee ci sono dietro le ninfee, dove l’acqua si congiunge con il cielo?
E poi c’è il fuoco, associato, come simbolo, alla conoscenza, in almeno due valenze: quella più eminentemente platonica, con il dualismo fra opinioni e verità, e quella lynchiana della frammentazione, del rispecchiamento, dell’accettazione di un mistero, insolubile, primordiale, che non è un limite, ma un’illuminazione.
David Lynch è un mistero che non può essere svelato e che costringe un mondo che ama definirsi post-ideologico, pur restando intrinsecamente permeato di dogmatismo critico, ad accettare la polisemia, anche e soprattutto percettiva, dell’opera d’arte. Il regista fonda la propria idea cinematografica – ma anche pittorica, per citare un’altra forma espressiva che gli è cara – sul concetto di campo unificato e giunge poi a postulare in modo non così dissimile dalle teorie gestaltiche di Kurt Lewin: l’opera si restringe alla lunghezza di Planck, diventando tutt’uno con coloro che la osservano, modificando e lasciandosi modificare dagli spettatori a ogni visione, stabilendo una connessione con la coscienza più che con la materia. Nella sua Teoria del Campo, Lewin poneva l’accento sull’interconnessione fra bisogno – soggettivo, momentaneo – e significato; i gufi, che non potevano essere (solo) ciò che sembravano, a questo punto della maturazione artistica di David Lynch, non sono ciò che sono e sono sempre anche ciò che non potrebbero essere. Non fa eccezione il cinema, salvifico nella sua essenza fatalmente incoerente e mutevole, alienante come dispositivo convenzionale (Mulholland Drive, INLAND EMPIRE).
 Nel 2002, sulle pagine di Filmcritica, Bruno Roberti spiegava: «In Lynch è come se le articolazioni macchiniche, gli ingranaggi e le sinapsi, gli snodi e le vie di comunicazione, le tubature di un sistema che fa corpo con le apparizioni e le storie, si manifestassero in quanto liberazioni di stati d’essere, di flussi energetici che si sprigionano in quanto inerenti al cinema come luce e suono, come pensiero che imprime movimento.»
Nel 2002, sulle pagine di Filmcritica, Bruno Roberti spiegava: «In Lynch è come se le articolazioni macchiniche, gli ingranaggi e le sinapsi, gli snodi e le vie di comunicazione, le tubature di un sistema che fa corpo con le apparizioni e le storie, si manifestassero in quanto liberazioni di stati d’essere, di flussi energetici che si sprigionano in quanto inerenti al cinema come luce e suono, come pensiero che imprime movimento.»
Non è dunque una excusatio non petita l’ammissione di non saper scrivere della terza stagione di Twin Peaks se, per saper scrivere, si intende la ricerca di un significato o più plausibilmente di molti significati inscritti nelle diciotto ore in cui si dispiega la narrazione. Quest’opera magniloquente che è televisione, cinema (non perché vi sia una preminenza ontologica del secondo rispetto alla prima, ci mancherebbe, è piuttosto il linguaggio a presentarsi come ibrido), pittura, filosofia, neurobiologia non tollera di essere indagata perché, per sopravvivere, non può esistere uguale a se stessa per più di qualche istante; è evanescente come i sogni sui quali si forgia, è impalpabile come la sensazione di calore quando si avvicina il dito a una fiamma. Nel momento in cui la si esplicita, la sensazione è già passata, non c’è più, è mutata in altro; permane solo la sua verbalizzazione che non potrà però mai rendere l’idea vera – semmai verosimile – di ciò che è stato, indipendentemente dall’accuratezza del resoconto.
Non abbiamo tuttavia molte altre modalità per cristallizzare un ricordo, pur nella consapevolezza che Lynch si rivolga, da sempre, anche nei lavori considerati più narrativi come The Straight Story, al cosiddetto secondo cervello – quello collocato nell’intestino – oltre che al cervello vero e proprio. Michael D. Gershon in The Second Brain (Perennial, 1999) scrive: «Sappiamo che, per quanto il concetto possa apparire inadeguato, il sistema gastroenterico è dotato di un cervello. Lo sgradevole intestino è più intellettuale del cuore e potrebbe avere una capacità emozionale superiore. È il solo organo a contenere un sistema nervoso intrinseco in grado di mediare i riflessi in completa assenza di input dal cervello o dal midollo spinale.»
Quindi, ferma restando la premessa, mai così doverosa, circa la soggettività di questo scritto, ciò che sto provando a mettere su carta – o su schermo – non è la mia interpretazione – non ne ho una univoca o abbastanza convincente – della serie evento, trasmessa nel 2017 dall’emittente Showtime. Il lavoro è così pulsante che qualsiasi esegesi mi parrebbe profanatoria, quasi il tentativo di dissezionare un presunto cadavere che invece è una creatura fervente di vita (qualunque cosa significhi, nell’alfabeto lynchiano, questo termine).
C’è poi, in ultimo, il ritorno all’impressionismo cui accennavo all’inizio, per quanto questa tecnica possa sembrare distante dai tagli angolati, espressionisti, e dalla violenza surrealista dell’indagine cinematografico-pittorica di David Lynch; vi è senza dubbio la tela dipinta con vecchi e nuovi personaggi, connessi in maniera più o meno intelligibile. Ma vi è inoltre, o soprattutto, ancora una volta, un’immagine a onde infinite, oscillante, peculiarità stilistica sottolineata già da David Foster Wallace nel suo David Lynch Keeps His Head, datato 1996. Lo stesso processo creativo del regista si conferma come spiraliforme, improntato all’impressione personale rielaborata (e rielaborata e rielaborata secondo teorie che vanno dall’animismo alla cultura indiana americana): «Posai la mano sul tettuccio ed era caldo, molto caldo: non bollente, ma piacevolmente caldo. Stavo lì con la mano poggiata sul tettuccio quando – puf! – apparve la “stanza rossa” […] “Aspetta un attimo”, dici “le pareti sono rosse, ma non solide”. Allora continui a pensare. “Sono tende. Non opache, ma traslucide”» (David Lynch, In acque profonde. Meditazione e creatività).
 Il regista elude di rado le domande, ma, se parliamo delle risposte che fornisce, be’, quella è un’altra storia. Eppure, se non si ricerca la Verità – e non avrebbe senso farlo, dato che non esiste – ma un suo frammento, qualche scintilla che scuota un concetto, là, tra il significante e il significato, David Lynch è una miniera. Riferendosi a Velluto Blu – una storia d’amore, parole sue – per esempio ha detto che si tratta di «un incrocio fra Norman Rockwell e Hieronymus Bosch» (riportato in Perdersi è meraviglioso, edito da Minimum Fax nel 2017). Il protagonista era Kyle MacLachlan alias Dale Cooper: il regista anche adesso storpia il suo nome in «Kale» perché in questo modo Dino De Laurentis si rivolgeva al giovanissimo attore sul set di Dune, non riuscendo a riprodurre la pronuncia corretta.
Il regista elude di rado le domande, ma, se parliamo delle risposte che fornisce, be’, quella è un’altra storia. Eppure, se non si ricerca la Verità – e non avrebbe senso farlo, dato che non esiste – ma un suo frammento, qualche scintilla che scuota un concetto, là, tra il significante e il significato, David Lynch è una miniera. Riferendosi a Velluto Blu – una storia d’amore, parole sue – per esempio ha detto che si tratta di «un incrocio fra Norman Rockwell e Hieronymus Bosch» (riportato in Perdersi è meraviglioso, edito da Minimum Fax nel 2017). Il protagonista era Kyle MacLachlan alias Dale Cooper: il regista anche adesso storpia il suo nome in «Kale» perché in questo modo Dino De Laurentis si rivolgeva al giovanissimo attore sul set di Dune, non riuscendo a riprodurre la pronuncia corretta.
Piuttosto bizzarro è il modo in cui dirige questo suo attore ricorrente, quasi un alter ego dalla bellezza antica, alla Cary Grant, scrutato dalla camera, in quel suo aspetto altero e un po’ svagato, con l’affetto e l’ammirazione che Fellini riservava a Marcello Mastroianni; ciò che il regista gli affida, attraverso richieste quali «give me a little more Elvis» o «a wind, think of a wind» (ce lo riferisce lo stesso MacLachlan, ospite da Stephen Colbert), non è dissonante rispetto a ciò che domanda a noi. Ci concede, se siamo pronti a rischiare qualche certezza, di cadere dall’alto, tenuti per mano, con l’audacia fatata (o stregata) di chi prova a riempire i vuoti di un mezzo saturo, caldo, e di un linguaggio insaturo, tali da farmi ritenere che si possa parlare di cinema senza fare torto a nessuna istanza critica né alla natura intrinseca di un progetto che nasce per la trasmissione televisiva. A proposito della sfida a cui Il ritorno lo metteva di fronte, l’interprete, originario di Yakima, nello Stato di Washington, ha confessato, durante il FYC panel: «I don’t think [David Lynch] ever doubted that I could do what he was asking me to do. I doubted that I could. But I know what I needed to do and I wanted to do that, of course for myself, but even more for David». Sentito per la realizzazione de Lo spazio dei sogni (David Lynch, Kristine McKenna, Mondadori, 2018), un libro definito come «la conversazione di una persona con la propria biografia», MacLachlan aveva specificato: «Per me le scene più difficili furono quelle in cui il Cooper cattivo affronta David e Laura Dern. Insieme, io e David facciamo sempre un po’ gli scemi, ed essere il personaggio dominante in una scena con lui fu complicato. Con lui e Laura ho un legame d’affetto così intenso che non fu affatto facile metterlo da parte».
In molti hanno detto tantissimo, con maggiore competenza di quanta mai ne potrò avere io, sulla filmografia del più geniale artista (o uno dei più geniali, per non incorrere nel peccato di idolatria!) della nostra epoca; questo vorrebbe essere una dichiarazione d’amore rispettosa verso l’autore che, più di tutti, ha messo in ginocchio ogni pretesa di dominio della razionalità e ha schiacciato la protervia dell’oggettivo sacro in un caleidoscopio di rifrazioni. Questo è solo un racconto, perché altro, almeno per quanto mi riguarda, non potrebbe essere, se non, forse, il racconto di un sogno.
Perché proprio di questo, alla fine, si parla; il sogno, per Lynch, qui di nuovo col fido Mark Frost, al quale dobbiamo un final dossier che ho preferito non consultare, è la materia grezza che si plasma sotto le mani dell’artista, è Il ritratto di donna di Degas, che cela Emma Dobigny nell’ombra di altri lineamenti.
È come il David-Apollo di Michelangelo: infinito (o mai finito-indefinito) come lo spazio, enigmatico, imperscrutabile, bellissimo.
Demiurgo di copie e di simulacri, nella definizione post-platonica di Deleuze e in quella di Jean Baudrillard nel suo La Précession des simulacres («Il simulacro non è mai ciò che nasconde la verità; ma è la verità che nasconde il fatto che non c’è alcuna verità.»): lui è Jimmy Stewart from Mars, benedetto da un’ironia che ha pochi eguali, e noi solo esseri umani caduti per caso sulla terra.
Insomma, parafrasando Audrey Horne che, in tempi non sospetti, ci forniva un indizio sul fascinoso agente dell’FBI e sulle sue nature: «There's only one problem with David Lynch. He’s perfect».
«What we see and what we seem are but a dream, a dream within a dream»
 Sui titoli di testa delle prime due stagioni di Twin Peaks, gli spettatori erano posti di fronte a un’immagine riflessa (non lo era costituzionalmente, solo a livello figurativo) che trovava il suo asse mediano in un palo dell’alta tensione. Di qua e di là, si notavano due abeti di Douglas – legno amato dal regista poiché, a suo dire, offre possibilità quasi prodigiose di lavorazione – assai simili fra loro. In pochissimi secondi, fin dal titolo gemellare, Lynch comunicava alcuni dei temi fondanti di questo suo lavoro lungo trent’anni (e della sua ricerca cinematografica in generale, nata come tentativo di far muovere i quadri che dipingeva): la dualità e lo specchio, così vitale nella riflessione di Cocteau.
Sui titoli di testa delle prime due stagioni di Twin Peaks, gli spettatori erano posti di fronte a un’immagine riflessa (non lo era costituzionalmente, solo a livello figurativo) che trovava il suo asse mediano in un palo dell’alta tensione. Di qua e di là, si notavano due abeti di Douglas – legno amato dal regista poiché, a suo dire, offre possibilità quasi prodigiose di lavorazione – assai simili fra loro. In pochissimi secondi, fin dal titolo gemellare, Lynch comunicava alcuni dei temi fondanti di questo suo lavoro lungo trent’anni (e della sua ricerca cinematografica in generale, nata come tentativo di far muovere i quadri che dipingeva): la dualità e lo specchio, così vitale nella riflessione di Cocteau.
A partire dalla nostra prospettiva di osservatori, ignari di stare guardando la realtà e/o un doppio quasi identico, ogni elemento si biforcava – e continua a biforcarsi – in un suo simbolo, con valenza non di rado straniante rispetto al significato originario, e il simbolo a sua volta poteva – e può – assumere natura duplice, e così via fino a un n grado di scomposizione. Emblematica è la figura del coniglio (cottontail o snowshoe?), uno degli elementi che fanno da trait d’union fra la prima stagione e la terza, e fra l’intera saga e la filmografia lynchiana che alla cosmologia di Twin Peaks si connette inestricabilmente. I coniglietti di cioccolato, repertati nel fascicolo sull’omicidio di Laura Palmer e ritrovati da Hawk quando ormai di Dale Cooper non vi è più traccia da molti anni, fanno pensare alla Pasqua, a una riconciliazione e a una rinascita. Noi sappiamo però che l’agente speciale dell’FBI giunge in città in una data antecedente alla festività pasquale (nel 1989, cadde il giorno 26 marzo), come ci comunica lui stesso attraverso il registratore-Diane: «Diane, 11:30 a.m., February 24th. Entering the town of Twin Peaks, five miles south of the Canadian border, twelve miles west of the state line. I've never seen so many trees in my life. As W.C. Fields would say, I'd rather be here than Philadelphia». Ci si discosta, anche a livello temporale, dal riferimento che, per primo, poteva aver colpito la nostra attenzione, e i conigli, come per incanto, assumono valori/voleri difformi dalla loro apparente tenerezza e dal concetto di fragilità a cui di norma vengono assimilati. L’animale infatti, nei marginalia medievali, viene spesso ritratto come vendicativo e sanguinario, surreale ribaltamento del ruolo di preda di solito ascrittogli. Il coniglio è però anche colui che conduce Alice nel mondo sotterraneo in Alice in Wonderland di Lewis Carroll; un personaggio stravagante proprio per le congetture sull’espansione/compressione che applica al concetto di tempo: «Povero me! Povero me! Arriverò in ritardo!»/ Alice: «Per quanto tempo è per sempre?»
Bianconiglio: «A volte, solo un secondo». Nella fattispecie, la dimora di Jack Rabbit, conosciuta da Bobby Briggs, divenuto ormai solerte poliziotto, grazie al padre Garland, corrisponde al luogo di formazione di una sorta di cunicolo spazio-temporale di collegamento con un mondo altro, quello della Loggia Bianca. La memoria torna al nome dell’unico coniglio di Rabbits capace di uscire dalla stanza e dunque di attraversare la linea di demarcazione fra il noto e l’ignoto: proprio Jack.
Se Lynch riesce a fare questo con un McGuffin, è solo intuibile cosa possa creare con il resto del materiale che ha fra le mani.
La posizione che ci spetta, in questo ritorno che è tale da più di un punto di vista, è però diversa da quella che il regista ci aveva affidato tanto tempo fa. Adesso un 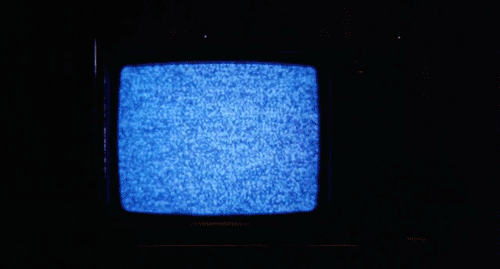 ragazzo di nome Sam fa bingewatching di una glass box misteriosa. Il cubo è uno dei cinque solidi platonici e il suo duale è l’ottaedro (il primo si compone di sei facce e otto vertici, il secondo di otto facce e sei vertici): sei e otto sono due numeri che ritroveremo. Anche l’apparecchio televisivo, in una raffigurazione un po’ primitiva, potrebbe essere avvicinato alla forma di una scatola e, proprio su un vecchio televisore senza segnale (e subito dopo esploso), vedevamo scorrere i titoli di testa di Fuoco cammina con me. Il nostro omologo subirà una sorte più ingenerosa di quella che toccherà a noi, lost girls and boys – per assumere il concetto da INLAND EMPIRE – inglobati nella narrazione, nel sogno/incubo, nella rappresentazione filmata del processo creativo che nasce, in prima istanza, come trasmissione dell’impulso nervoso. Ritorna la dualità nella differenza di potenziale elettrico, con cariche positive all’esterno della cellula e cariche negative all’interno, fino all’arrivo dello stimolo e dunque all’inversione repentina di polarità: c’è un processo legato all’elettricità alla base del processo creativo (e di ogni processo cognitivo). Ho pensato così alla Loggia Nera e alla sua particolarità: la chiave per accedervi è la paura. Da un punto di vista neurobiologico, la paura e la creatività (ma anche gli stati maniacali; si legga, a tal proposito, un testo dal titolo abbastanza emblematico: Touched with Fire: Manic-Depressive Illness and the Artistic Temperament di Kay Redfield Jamison, Free Press, 1991) sono inversamente legate dal neuromediatore dopamina. Da una carenza di quest’ultima potrebbe scaturire il linguaggio ripetitivo e a scatti di coloro che popolano la Loggia.
ragazzo di nome Sam fa bingewatching di una glass box misteriosa. Il cubo è uno dei cinque solidi platonici e il suo duale è l’ottaedro (il primo si compone di sei facce e otto vertici, il secondo di otto facce e sei vertici): sei e otto sono due numeri che ritroveremo. Anche l’apparecchio televisivo, in una raffigurazione un po’ primitiva, potrebbe essere avvicinato alla forma di una scatola e, proprio su un vecchio televisore senza segnale (e subito dopo esploso), vedevamo scorrere i titoli di testa di Fuoco cammina con me. Il nostro omologo subirà una sorte più ingenerosa di quella che toccherà a noi, lost girls and boys – per assumere il concetto da INLAND EMPIRE – inglobati nella narrazione, nel sogno/incubo, nella rappresentazione filmata del processo creativo che nasce, in prima istanza, come trasmissione dell’impulso nervoso. Ritorna la dualità nella differenza di potenziale elettrico, con cariche positive all’esterno della cellula e cariche negative all’interno, fino all’arrivo dello stimolo e dunque all’inversione repentina di polarità: c’è un processo legato all’elettricità alla base del processo creativo (e di ogni processo cognitivo). Ho pensato così alla Loggia Nera e alla sua particolarità: la chiave per accedervi è la paura. Da un punto di vista neurobiologico, la paura e la creatività (ma anche gli stati maniacali; si legga, a tal proposito, un testo dal titolo abbastanza emblematico: Touched with Fire: Manic-Depressive Illness and the Artistic Temperament di Kay Redfield Jamison, Free Press, 1991) sono inversamente legate dal neuromediatore dopamina. Da una carenza di quest’ultima potrebbe scaturire il linguaggio ripetitivo e a scatti di coloro che popolano la Loggia.
Le immagini sembrano seguire la suggestione di una volontà immersiva rispetto al processo di creazione artistica e, da frontali, quasi schiacciate, diventano avvolgenti: una tridimensionalità distorsiva che Lynch condivide con Francis Bacon e Kienholz. Così le cascate dinnanzi al Great Northern Hotel, inquadrate da sopra, nel loro scrosciare, così le famose tende della Loggia Nera o lo stesso pavimento, dalla geometria analoga a quella della casa di Henry Spencer in Eraserhead (ispirata magari a L'inhumaine), più escheriano, nella deformazione; oppure ancora la nebbia che sembra avvolgere in modo permanente il bosco di Ghostwood e che ricorda il vapore emesso dalla nuova sembianza (un bollitore o il Brucaliffo? O, chissà, l’amata caffettiera…) di Philip Jeffries, colui che decritterà per Cooper il simbolo inciso sull’anello. Questa scena, prodromo dei finali di stagione, e di serie, per quel che ne sappiamo, si ricollega all’ora più iconica del ritorno all’universo di Twin Peaks e lo fa attraverso alcuni precisi riferimenti: il numero otto, la sua scomposizione in segni e la conseguente risemantizzazione simbolica. Nell’ottava parte della serie, assistiamo a una particolare genesi laica che può essere riferita, in modo generico, alla creazione dei concetti di Male e di Bene, ma che, a ben vedere, riguarda di più un’idea di equilibrio primigenio, insito nell’Universo e violato in modo artificiale.
Ci vengono mostrate due date: la prima è il 1945, per la precisione il 16 luglio, la seconda è il 5 agosto del 1956. Sopra lo stridore dei violini di Threnody for the Victims of Hiroshima di Krzysztof Penderecki, ad Alamogordo, nel New Mexico, gli Stati Uniti sperimentano il primo ordigno nucleare. Si tratta del cosiddetto Trinity Test, condotto infatti proprio il 16 luglio del 1945. La nostra posizione resta quella di osservatori inglobati nel flusso e l’esplosione stellare che segue la deflagrazione (o la precede?), un vero e proprio Big Bang, assume i connotati inquietanti della Madre (una creatura simile a quella dell’Esperimento), intenta a creare – o vomitare, si dovrebbe dire, producendo una sostanza densa e corpuscolata che ricorda la garmonbozia - uno dei propri mostri, Bob, ma anche i colori di una festa pirotecnica. Ancora nel New Mexico, l’uovo-Bob si schiude e una sorta di grosso insetto ranoide può giungere a quello che sembra essere il suo primo ospite: Sarah Novak, una ragazza che la sera stessa aveva raccolto da terra un penny, rivolto dalla parte della testa. Quest’ultimo particolare rievoca in modo abbastanza immediato uno degli woodsmen (altri neutroni, scaturiti da reazioni secondarie, che desiderano una carica elettrica?) in fuga dal Convenience Store. La faccia della moneta e la creatura, che ripete ossessivamente la frase «gotta light?» (l’imponente sacralità della locuzione fiat lux si incrina), prima di schiacciare i crani dei malcapitati in cui si imbatte, presentano infatti il medesimo sembiante, quello di Abrahm Lincoln, il sedicesimo presidente degli Stati Uniti d’America (1 + 6 = 7). Provando a sfuggire al didascalismo, come le immagini sembrano suggerirci di fare, si arriva alla figura di Roberto Grossatesta (1175-1253), uno dei principali esponenti della metafisica della luce, espressione coniata da Clemens Baeumker nel 1916 e che indica, non in modo unanime, la dottrina che considera la luce come la prima forma corporalis (si legga Miriam Savarese su disf.org). Savarese chiarisce: «Bisogna segnalare una differenza tra lux e lumen nel pensiero grossatestiano, laddove con lux si indica la luce pura, che si ha sin dall’inizio della creazione, mentre con lumen la luce derivata, prodotta dal primo cielo (composto sempre di materia e forma: è il primo corpo), che riflette la lux, permette all’intelligenza celeste di muovere le sfere e giunge ad operare fin nel mondo sublunare». Grossatesta, dopo essere stato maestro all’università di Oxford, è divenuto vescovo di Lincoln, città inglese delle Midlands orientali.
Da notare che la parola Lincoln era presente anche come marca dell’orologio nell’automobile con cui Mr. C si schianta, durante la prima rinascita elettrica di Cooper. C’è un altro sinistro mantra che l’essere ripete: «This is the water, and this is the well. Drink full, and descend. The horse is the white of the eyes and dark within». Sembra di trovarsi in presenza di una simbologia biblica, ma un percorso di discesa e di risalita dal pozzo è lo stesso che affronta il personaggio di Kevin Garvey in The Leftovers. Il secondo verso in qualche modo chiude una questione dibattuta in teologia, a proposito della valenza del cavallo bianco dell’Apocalisse; questo è sia una figura positiva che una figura negativa poiché, come nel Taijtu, vi è complementarietà necessaria e naturale fra Yin e Yang, fra Logos e Eros. Anche il cognome dell’ospite parrebbe suggerirci qualcosa anche se, in questo caso, occorre pescare in cassetti un po’ più reconditi della nostra memoria; il nome proprio è quello della madre di Laura Palmer, mentre Novak è il cognome dell’attrice Kim che interpreta il ruolo di Madeleine in Vertigo di Alfred Hitchcock. Madeleine Ferguson (Ferguson è il cognome di James Stewart nel capolavoro hitchcockiano) è il nome della cugina di Laura, con le fattezze della stessa Sheryl Lee. Un’esplosione atomica e uno scarafaggio-anfibio simbionte, quindi, e Prospero/Gordon Cole sembra saperne qualcosa, dato che nell’ufficio che occupa al Federal Bureau of Investigation sono poste, l’una di fronte all’altra, la raffigurazione del fungo atomico e la foto di Franz Kafka, ovvero colui che ha sublimato nella rappresentazione artistica la possessione mutante. E se fosse proprio l’imperturbabile Gordon il magician (who) longs to see di cui parla MIKE? Una curiosità sul supervisor: il suo nome è ispirato a quello di un personaggio minore di Viale del tramonto, di Billy Wilder; si tratta di un assistente di DeMille che contatta Norma Desmond, non per offrirle un ruolo, ma per chiederle di poter noleggiare la sua automobile per un film. Lynch ha notato che, muovendosi dal Sunset Boulevard verso gli studi della Paramount Pictures su Melrose Avenue, si possono incontrare sia la Gordon Street che la Cole Avenue: non happy accidents, di quelli così amati dal regista (uno su tutti, nella storia della serie, il vis-à-vis fra Cooper e il lama, nell’ambulatorio veterinario del dottor Lydecker), ma nomi parlanti e ponti invisibili tra le realtà – d’obbligo il plurale nell’articolo – e la celluloide.
Facendo cenno, benché in accezione impropria, ai nomi parlanti e sconfinando nella biografia del regista, non si può non citare Bushnell Mullins, chief executive della Lucky 7 Insurance, la compagnia assicurativa per la quale lavora Dougie Jones. L’uomo, a cui il rinato Coop dice «you're a fine man, Bushnell Mullins. I will not soon forget your kindness and decency», ha lo stesso nome proprio di Bushnell Keeler, scomparso nel 2012, la prima persona ad aver creduto nelle capacità pittoriche del giovane David, ad aver dunque compreso una sostanza non immediatamente visibile: «All’epoca Bush fu l’unico a capire ciò che gli altri stentavano a mettere a fuoco, e cioè che le ambizioni artistiche di David erano sincere e fondate». (David Keeler in Lo spazio dei sogni).
Quattro elementi – l’atomo, la rana (o qualcosa che le assomiglia), la rosa e il pesce, analogo a quello finito per sbaglio nel caffè di Pete Martell – richiamano le teorizzazioni di Bohm sull’universo olografico e l’olomovimento. Come illustra Augusto Sabbadini nella prefazione del volume Universo, mente, materia (David Bohm, Red Edizioni, 1996): «Nella teoria di Bohm la visione unitaria della realtà diviene ancora più radicale: i singoli sistemi, le particelle o gli insiemi di particelle non esistono affatto. Essi non sono pensabili come enti separati interagenti tra loro. Sono piuttosto simili a immagini che si formano e si disfano in un caleidoscopio, o a vortici che si formano e si disfano nella corrente di un fiume […] La sola realtà ultima è la corrente indivisibile del movimento universale […] Ma il flusso ininterrotto del movimento porta continuamente alcuni aspetti a dispiegarsi, a divenire “esplicati” o manifesti, percettibili, per poi tornare a immergersi nel tutto, mentre altri aspetti “implicati” emergono e divengono “esplicati”».
La parte otto di Twin Peaks – Il ritorno ha una peculiarità, sottolineata anche da Matteo Marino nel suo I segreti di David Lynch (Becco Giallo, 2018). Prima del lungo racconto creazionista, i Nine Inch Nails si esibiscono alla Roadhouse con un pezzo che recita: «I can't remember what she came here for/ I can't remember much of anything anymore/She's gone, she's gone, she's gone away». Il fireman, all’interno della loggia bianca, osserva l’ordigno che esplode su un grande schermo e forgia come espansione del proprio cranio una perla dorata sulla quale scorgiamo il volto di Laura. Una donna con l’aspetto di una diva del cinema muto (il sonoro viene introdotto a partire dagli anni Trenta), la Señorita Dido, bacia la gemma e la spedisce nel nostro mondo, all’altezza della famosa cittadina. In che anno siamo rispetto al Trinity Test?

Is it the future or is it the past?
L’otto ha inoltre un significato interno al racconto, come accennavo poc’anzi: Jeffries compone un «8», molto simile al simbolo dell’infinito, scomponendo e ricomponendo il simbolo presente sull’anello (verde, come di smeraldo era la capitale del regno di Oz) e sul petroglifo della Caverna dei Gufi. Il sei, il cubo, l’equilibrio, è qui anche il simbolo di energia (un’energia che al mantenimento di quell’ordine mira), tanto che in più di un’occasione ci viene suggerita la presenza di questo numero sui tralicci, lignei, nel caso specifico, dell’alta tensione. Tra i due c’è il numero sette, il totale dei chakra, che sembrerebbe riferirsi a una qualche entità traghettatrice: lo possiamo associare allo woodsman-Lincoln e allo stesso Jeffries. La cifra sette compariva infatti sull’ascensore dal quale usciva David Bowie (il Philip con sembianze umane benché già fantasmatico) quando si presentava, visto solo dall’agente Cooper, da Cole e da Albert, negli uffici dell’FBI in Fire Walk With Me. Lo stesso numero è anche la somma delle cifre che compongono i chilometri che Dale e Diane percorreranno su suggerimento del Fireman: 430.
Il sette, cifra cara a tutta la teosofia, disciplina studiata da Mark Frost, ricorre anche nella trattazione del filosofo e mistico armeno Georges Ivanovič Gurdjieff. Colui che ne ha tramandato il sapere, il suo allievo P.D. Ouspensky, in Frammenti di un insegnamento sconosciuto (Casa Editrice Astrolabio, 1976) riporta infatti: «Nel linguaggio di cui parlo, al posto della parola “uomo” sono usate sette parole, ossia: uomo n. 1, uomo n. 2, uomo n. 3, uomo n. 4, uomo n. 5, uomo n. 6 uomo n. 7 […] L'uomo n. 7 è giunto al più completo sviluppo possibile per l'uomo, e possiede tutto ciò che l'uomo può possedere, come volontà, coscienza, un “Io” permanente e immutabile, individualità, immortalità, e una quantità di altre proprietà che nella nostra cecità e nella nostra ignoranza noi ci attribuiamo».
Dentro un’immagine onirica ci si muove per intuizioni che potrebbero rivelarsi del tutto fallaci, una volta svegli, e l’andare raminghi è ancora più complesso, dal momento che non è sempre chiara la nostra collocazione spazio-temporale. Per gli spettatori esiste un limbo, una zona di decompressione – a la maniere de Lynch, si intende – non a caso collocata (se si eccettua l’infrazione della parte otto) alla fine di ogni episodio. La Roadhouse rappresenta una nowhere land che per certi versi richiama il Club Silencio di Mulholland Drive; qui giunge – se la definizione è corretta – Audrey Horne, la quale, ancora in un probabile stato di coma, sembra altrimenti intrappolata nella soap-opera Invitation to Love. Come nota anche Matteo Marino, la danza, la Audrey’s dance, invocata dal presentatore, è nota per noi, ma non dovrebbe esserlo per il personaggio, a meno, appunto, di non trovarsi in un mondo mediano senza quarte pareti né sospensioni dell’incredulità. Che si sia situati al cospetto di universi multipli, tangenti o contamina(n)ti è esplicato dal nome stesso del personaggio interpretato da Michael J. Anderson nelle stagioni precedenti e in Fire Walk with Me, qui presente come l’astrazione del Braccio: The Man from Another Place.
Proseguendo la sua riflessione sul mutamento, che è anche quello degli attori, fermi nel nostro ricordo a più di venticinque anni fa, Lynch innesta la compassione nella poetica. Alla figura – bellissima, nell’intuizione dello struggente commiato diegetico che il regista le tributa – di Margaret Lanterman (il nome non può non suggerire l’assonanza con lantern man, un atmospheric ghost light appartenente al folklore), scomparsa a ridosso della fine delle riprese, è donata, senza mai celarne le condizioni di salute, quella che forse è una delle più esplicite chiavi di lettura dell’intero racconto: «Watch and listen to the dream of time and space. It all comes out now, flowing like a river. That which is, and is not. Hawk, Laura is the one.» Margaret, già Mad Hatter, durante la prima stagione, racchiude in sé, ormai in modo compiuto e definitivo, lo spirito del marito, morto a causa del fuoco, che, attraverso il ceppo, ha continuato a vivere come essenza, dotata di una sua propria voce. Ciò rivela(va) – in un certo modo anticipa(va) – l’esistenza di quel doppio quasi speculare che adesso ci è palese per molti dei personaggi dell’universo di Twin Peaks. Il Cappellaio Matto, accusato di stare «murdering the time» dalla Queen of Hearts, è conosciuto con il nome di Hatta in Through the Looking-Glass. La contrazione di hatter, se si vuole, ricorda, in modo vago e giocoso, quasi in un rompicapo carrolliano, la pronuncia del vocabolo other. La forma della donna sta cambiando di nuovo natura, sta divenendo altro: questo e questo solo è il significato della morte.
A proposito di doppelgänger non si può non citare Dougie Jones. Il primo Dougie, «created for a purpose», viene sostituito da una specie di golem dell’agente Cooper, tornato in questo mondo dopo una lunga sequenza che richiama le sperimentazioni cinematografiche delle avanguardie e il pittoricismo dei primi lavori dello stesso Lynch, quali Six Figures Getting Sick o The Alphabet. Dougie-Cooper (per lui, per un lui, ci sarà il doveroso lieto fine), prima del risveglio nel vero Cooper grazie, ancora una volta, a una scarica elettrica, risulta il contraltare comico-grottesco di Mr. C e senza dubbio una delle intuizioni più memorabili della stagione. Capace (soltanto) di un pensiero laterale, secondo la definizione di de Bono, e di una fortuna, emanata direttamente dalla Loggia, Dougie Jones è la maschera di Buster Keaton, proveniente da un altro pianeta. L’involontaria comicità è infatti sempre velata dalla malinconia dello sguardo, quella di un essere, non vuoto – al contrario, capace di slanci commoventi – ma come svuotato. La sua sensorialità è distintiva e, in un parallelismo possibile solo con Gordon Cole, Dougie-Cooper non sente di più, ma sente molto meglio. L’uomo, compreso da tutti, pur versando in uno stato di apparente catatonia, viene accostato a un simbolismo di tipo assiale, proprio della cultura indiana: «l’Asse dell’Universo è come una scala sulla quale si effettua un perpetuo movimento ascendente e discendente» (Ananda Kentish Coomaraswamy, The Inverted Tree). Dougie è uno che resta, e che torna, ed è come se in lui si catalizzasse la ristrutturazione/eliminazione di ciò che Carlos Castaneda, in Viaggio ad Ixtlan (BUR, 2012), definiva come «importanza personale»: «Ti senti troppo maledettamente importante, ma dovrai cambiare! Sei così maledettamente importante che ti senti in diritto di irritarti di tutto. Sei così maledettamente importante che ti puoi permettere di andartene se le cose non vanno a modo tuo. Immagino che penserai che sia prova di carattere. È assurdo! Tu sei debole, e presuntuoso». Nell’impianto irresistibile che caratterizza tutta la storyline che lo vede protagonista, sono un paio di décolleté rosse (Oz, ancora Oz!), molto simili a quelle indossate da Audrey nel pilot, la leva di una nuova possibilità che fa da motore, a partire dalla sedicesima parte – il numero sedici ricorre –, al duplice finale, imbastito da David Lynch e Mark Frost, tenendo fede all’approccio complessivo di questo monumentale lavoro.

«We’re coming home»
Ci troviamo in una fase REM e ciò a cui assistiamo è il succedersi di immagini del cosiddetto sonno paradosso: ci ricordiamo cosa abbiamo visto, ci sembra addirittura di averlo vissuto, ma non è possibile risalire a un’interpretazione a-simbolica o univoca.
Come nascono i sogni provava a spiegarcelo l’agente Cooper molti anni or sono: «Acetylcholine neurons fire high voltage impulses into the forebrain. These impulses become pictures, these pictures become dreams, but no one knows why we choose these particular pictures». Una forma di censura a monte rispetto all’accesso a contenuti troppo scabrosi potrebbe essere rappresentata dai numerosi semafori rossi che scandivano la narrazione del vecchio Twin Peaks.
Anche in un approccio en abyme come quello attuale, va tuttavia tenuta a mente la natura del processo onirico, ben tracciata da Jacques Lacan in Il seminario, Libro II (Biblioteca Einaudi, 2006), quando fa parlare Freud sul senso del sogno dei sogni, quello dell’iniezione a Irma: «La mia ambizione è stata più grande di me. La siringa era senza dubbio sporca. Proprio nella misura in cui l’ho troppo desiderato, in cui ho partecipato a questa azione, in cui ho voluto essere, io, il creatore, non sono io il creatore. Il creatore è qualcuno più grande di me. È il mio inconscio, è la parola che parla in me, al di là di me».
Questo è dunque ciò che credo di essere riuscita a vedere, mentre l’opera-sogno, be’, come dire, mi guardava: nulla più.
Il Cooper che conosciamo raggiunge Twin Peaks per un inevitabile rendez-vous con Mr. C La distruzione di Bob, per mano di un giovane, dotato dal Fireman di un guanto magico dello stesso colore dell’anello – la tangenza col cinema fantastico sfiora qui la simpatica satira verso quello supereroistico – ferma il tempo sulla cifra del compimento: le 2.53, somma uguale a 10. Coop ha terminato in suo compito in quella particolare storia, ma c’è qualcos’altro che è necessario fare: salvare Laura dalla morte, causata da Leland-Bob. Lynch dedica la diciassettesima ora di questo suo ritorno a Jack Nance, ovvero Pete Martell, scomparso nel 1996. A ritroso, ci rendiamo conto che il percorso che il regista sta compiendo porta in nuce una necessità più intima, molto umana.
Grazie alle indicazioni di Jeffries, raggiunto tramite un passaggio dalla sua vecchia stanza al Great Northern (315, somma uguale a nove: no, questo non sarà IL finale), l’agente dell’FBI intercetta Laura Palmer nel bosco dove la attendono Leo Johnson, Jacques Renault e Ronette Pulaski. La ragazza, in sella alla moto di James, grida, e noi, per la prima volta dai tempi di Fuoco cammina con me, conosciamo il motivo: ha scorto Cooper tra la vegetazione. Il dialogo fra i due è conciso. L’agente la riporterà a casa, ovvero all’interno della Loggia Bianca, dove la perla d’oro è stata generata. Mentre, mano nella mano, camminano tra gli arbusti, dirigendosi verso il Jack Rabbit’s Palace, vediamo stravolgersi l’innesco drammatico dell’intera storia: Pete va a pescare, Josie si ammira allo specchio, ma il cadavere della Palmer viene risucchiato via dal sacco di nylon. Non c’è più, non è morta, Cooper è riuscito nel proprio intento. Solo in questo momento assistiamo a una scena che è diretta conseguenza della non-morte della giovane, versione più tormentata di Alice (attraverso lo specchio): Sarah Palmer tenta invano di distruggere la foto della figlia. La scena ha almeno una doppia valenza e ciò, arrivati a questo punto, non dovrebbe sorprendere affatto: la creazione di Laura aveva una finalità ben delineata in un disegno più ampio, inoltre quell’immagine è un simbolo, riconosciuto anche da chi non ha mai affrontato la visione di Twin Peaks. Il cinema, o la televisione, in questo caso, hanno un portato di eternità.
Nel bosco, Cooper comincia ad avvertire il ticchettio che il Fireman gli aveva fatto ascoltare nella parte 1. A qualunque cosa si riferisca – potrebbe persino avere a che fare, a livello simbolico, con la regolarità di un parametro vitale nella fase che precede il risveglio – l’evidenza è l’innesco di un loop, simile a molti altri incontrati in precedenza, il più inquietante dei quali è probabilmente quello proveniente dall’orsetto demoniaco di Johnny Horne: «Hello Johnny, how are you today?» Una domanda analoga, ancora una volta in sequenza ripetuta, chiudeva la seconda stagione: «How’s Annie?».
L’agente si volta e Laura non c’è più; può sentire solo il suo grido.
«Faster and faster. And for a long time, you wouldn't feel anything. And then you'd burst into fire. Forever. And the angels wouldn't help you…because they've all gone away»: con queste parole la ragazza rispondeva, in Fire Walk With Me, a una domanda di Donna che suonava come «Do you think that if you were falling in space…that you would slow down after a while…or go faster and faster?».
Come sempre dal Bang Bang Bar (aka Roadhouse) ci giungono le parole di un pezzo che ha profonda attinenza con le immagini dell’episodio: «Moving near the edge at night/ Dust is dancing in the space/ A dog and bird are far away/ The sun comes up and down each day/ Light and shadow change the walls/ Halley's comet's come and gone/The things I touch are made of stone/ Falling through this night alone.»
All’inizio della parte 18 – la stessa suddivisione di Picnic a Hanging Rock, se si include il capitolo fantasma, pubblicato postumo, nel 1987, in The Secret of Hanging Rock – vediamo Cooper di nuovo nella Loggia Nera. Con facilità guadagna l’uscita e, di fronte al cerchio di sicomori, incontra Diane che aveva lasciato nell’ufficio dello sceriffo Truman. I due si mettono in cammino per una località che dista 430 miglia dal luogo in cui si trovano: lì incontreranno Laura, e l’entità malvagia Judy, la Madre, potrà essere annientata. Subito dopo l’arrivo di Dale e Diane al motel, dove trascorreranno la notte, il regista ci pone di fronte, di nuovo, a un’immagine non orientabile, sorta di nastro di nastro di Möbius cine-televisivo, già ben chiarito nella struttura di Lost Highways. Durante un rapporto sessuale a dir poco straniante, capiamo che Diane (del resto la divinità pagana Diana è associata al concetto di fuoco) sta cogliendo una mutazione già in atto: copre il volto di Cooper con le mani, gesto che Gordon Cole faceva su se stesso di fronte a Lil, in presenza di Chester Desmond.
La storica collaboratrice di Coop ci viene mostrata, prima di assumere di nuovo la fisionomia dell’attrice Laura Dern, come una giovane donna con gli occhi sigillati: ne abbiamo vista una simile, in un altro momento cruciale per l’agente. Nello sciamanesimo giapponese, in particolare nella regione del Tohoku, esiste la figura della Itako, medium cieca, legata alle pratiche negromantiche; Itako-Ithaca-Odyssey-Odessa: l’esemplificazione del viaggio e del ritorno, in termini omerici.
Mentre consuma l’amplesso, Diane ha l’espressione contratta da un dolore intenso; una sua tulpa aveva confessato di essere stata stuprata da Mr. C e il nome, Richard, che verrà attribuito all’uomo che ha l’aspetto di Dale Cooper, ha in effetti a che fare con un abuso sessuale, perpetrato a ridosso dell’esplosione della banca. I tulpa sono associati al colore blu (blue rose), lo stesso della box di Mulholland Drive o del personaggio che Nikki Grace vuole interpretare in On High in Blue Tomorrows, il film nel film di INLAND EMPIRE; lo stesso della pelle del dio Vishnu – una delle espressioni del Brahman –, la divinità dai molti avatar, preposta al mantenimento dell’equilibrio tra forze contrapposte. In sanscrito, per indicare il gioco sacro del Brahman, viene utilizzato il sostantivo līlā; ci appare così evidente l’assonanza con il nome della dancer di Fuoco cammina con me.
Richard Horne era il figlio di Audrey, con ogni probabilità violentata da Bob-Cooper, durante il coma, con la complicità – non ne conosciamo la ragione né le precise modalità – di Jerry Horne, in seguito impazzito. La suggestione deriva dal comportamento proprio di Horne in occasione della morte-sparizione del congiunto, avvenuta con una particolare folgorazione elettrica che lo aveva polverizzato mentre si trovava sopra un macigno, in un luogo dove Bob-Cooper lo aveva condotto (e teniamo a mente che l’aura luminosa del bambino che Richard aveva investito si era congiunta proprio con il flusso di corrente, all’altezza del palo numero sei). Jerry guarda la scena con il binocolo al contrario, allontanando quindi l’immagine del suo senso di colpa dai propri occhi. Si convince poi di essere stato la causa di quella dipartita, quando invece potrebbe essere stato la concausa della disgraziata – però ineluttabile, in un’ottica non moralista, e di moralismo non v’è traccia nella filosofia di David Lynch – nascita. Se Diane sta registrando un mutamento – ed è plausibile, dal momento che il luogo dell’amplesso sembra non essere più lo stesso quando Cooper-Richard si sveglia e trova il biglietto, firmato Linda – è immaginabile che questo sia connesso a qualcosa di nero, programmaticamente tale, che di nuovo vive dentro l’agente.
Si ha l’impressione di un antico disegno che si compie, attraverso la tripartizione (che è una pentapartizione per Kyle MacLachlan, la cui performance è calibrata e magnifica, sia nel registro comico che in quello drammatico); il numero 3 campeggiava sulla presa di corrente che ha permesso a Cooper di ri-nascere come Dougie e, in riferimento alle teoria neurobiologica – dunque non psichica, ma strutturale – di Paul MacLean sul triune brain, rilevante anche come sottotraccia di Mon oncle d'Amérique di Alain Resnais, questo numero può riguardare un equilibrio arduo da raggiungere e agognato.

E chi è dunque Diane-Linda?
Come al solito si possono imboccare varie direzioni, alcune diegetiche – Linda è la moglie, solo nominata, di Mickey, uno dei residenti del Fat Trout Trailer Park – altre ancora, frutto di una mera fascinazione mnemonica.
La corrispondenza dei nomi propri non è nuova all’universo di Twin Peaks: MIKE e Bob non sono Mike e Bob(bie), sono altro/i, come Coop precisa allo sceriffo Truman – quello sceriffo Truman, non l’altro – e a Lucy Moran, nel quarto episodio della prima stagione. Anche gli omaggi possono frammentarsi in piccoli lampi, tanto suggestivi quanto, talvolta, indecifrabili. È il caso della sala da gioco-bordello, sorta di Loggia di questo mondo, One Eyed Jacks, che mutua il proprio nome dall’unico film diretto da Marlon Brando. Il divo ricorre in un personaggio che si presenta, all’apparenza, con un costume di scena: Wally Brando, vestito come Johnny Strabler de Il selvaggio, viene introdotto come il figlio di Lucy e del vicesceriffo Andy Brennan e potrebbe impersonare la sublimazione s-mascherata di un desiderio di maternità. One-Eyed Jack è anche il titolo di un album del 1978 di Garland Jeffryes: il nome, al di là della differente grafia, non può non risuonare come la congiunzione di quello di due personaggi connessi con altre dimensioni. Tuttavia è la dedica che colpisce in modo particolare: «in Memory of my childhood idol, Jackie Robinson...here comes the One-Eyed Jack, sometimes white and sometimes black».
Tornando al nome dichiarato da Diane, proprio una suggestione mi ha portato a pensare a una raccolta, datata 1990, dal titolo The Things They Carried (Quanto pesano i fantasmi, Leonardo, 1991); i protagonisti principali della storia sono soldati americani, di stanza in Vietnam. Nell’ultimo racconto, The Lives of the Dead, l’autore, Tim O’Brian, introduce però il personaggio di Linda, una bambina, morta prematuramente, che continua a vivere nel ricordo di chi l’ha amata. Rappresenta, insomma, l’egemonia della memoria sulla materia.
C’è poi un altro indizio a cui dobbiamo prestare attenzione: la musica che sentiamo durante il rapporto sessuale è la stessa che l’emittente radiofonica sta passando quando il woodsman-Lincoln interrompe la trasmissione con la sua litania e l’insetto-anfibio entra nella bocca di Sarah Novak. Si tratta di My Prayer dei Platters, un vecchio pezzo, inciso dal gruppo nel 1956.
Is it the future or is it the past?
In effetti anche a noi adesso Cooper sembra diverso, come se in lui convivessero il simpatico agente con doti deduttive alla Sherlock Holmes, alimentate a cherry pie e a caffè, anzi a damn fine coffee, black like midnight on a moonless night, e qualcosa di più oscuro. Sta di fatto che Jeffrey Beaumont ha smesso di nascondersi e un «leave her alone» è qui scandito senza paura o esitazioni. Se si analizza la sceneggiatura di Blue Velvet, si può scoprire come l’esortazione sia presente due volte; solo di una, pronunciata in occasione della joyride con Frank Booth, abbiamo testimonianza nel montaggio finale del quarto film di David Lynch: «Finally, he leaves the furnace room, and, as he does so, he calls out: «hey, shit head. Leave her alone. Don’t force girls […] I am describing a scene from the film Blue Velvet, directed by David Lynch (1986). Except that I am not: it is a scene from the screenplay for Blue Velvet: it was filmed but cut out during the editing process». (The scene of Violence: Cinema, Crime, Affect, di Alison Young, Routledge, 2010).
Ciò che Cooper-Richard scopre a Odessa, dopo la sosta in un diner dal nome significativo, Eat at Judy’s, è che Laura non si chiama Laura, ma Carrie Page e che la donna non ha alcuna cognizione dell’esistenza di Twin Peaks. Tuttavia l’agente insiste per portarla a casa. La casa di cui parla questa volta non è la Loggia Bianca, ma la vera abitazione dei Palmer, al civico 708 ed è probabile che questa traiettoria si leghi al mutamento dello stesso agente, attratto ormai da Laura quanto dall’entità. Giunti sul posto, siamo di nuovo messi di fronte a una scoperta che cambia le carte in tavola: la proprietaria della villetta (siamo a conoscenza del fatto che non si tratti di un’attrice, ma della vera proprietaria, segno che ormai non vi è più soluzione di continuità fra quel mondo e il nostro mondo) si chiama Tremond ed ha acquistato la struttura da una certa signora Chalfont. I due cognomi, legati a delle presenze della Loggia Nera, più volte riecheggiati sia in Fire Walk With Me che in Twin Peaks, fanno vacillare le convinzioni e sparigliano le coordinate.
«What year is this?» si domanda allora l’agente.
Non ottiene risposta. In sottofondo sentiamo Sarah Palmer che, come nel pilot della serie, chiama la figlia per nome, più volte, perché Laura non è più lì, è morta e non può rispondere. Laura/Carrie emette un grido, mentre un sovraccarico elettrico pare mandare in cortocircuito le luci della casa.
Che cosa è successo davvero in questa storia che tende i margini del quadro fino a straripare nel non visibile?
Non possiamo saperlo. Ciò che mi hanno suggerito le immagini è che si debbano far convergere i significati di due tra le più sibilline frasi, sentite in questo splendido ritorno. Il Fireman ha detto: «4-3-0. Richard and Linda. Two birds with one stone». La stone a cui si riferisce – il pensiero va alla grande roccia sul lago sotto la quale fu rinvenuto il corpo di Laura – potrebbe essere quella dove il giovane Richard muore folgorato: i due massi si assomigliano. Una parte di Richard, figura cupa, violenta, immorale, è adesso in Cooper che, nella sua versione Mr. C, ha contribuito a generarlo. Gli uccelli sono il medesimo Cooper e Laura, e proprio l’effige di un volatile è presente sul cornicione di casa Palmer. Il woodsman-Lincoln fa riferimento, come accennavo in un paragrafo precedente, a un cavallo bianco, scuro dentro (abbiamo visto un equino nelle visioni di Sarah e un piccolo soprammobile con questo aspetto è presente nella casa di Carrie Page). L’abitazione, con le luci spente, ci appare, simbolicamente, proprio caratterizzata da questi due colori: bianca per l’intonaco e nera per ciò che scorgiamo dalle finestre, non più illuminate dall’interno. Proseguendo con una lettura metaforica delle immagini, la casa è una struttura solida, con una base che può essere quadrata: il cubo, l’equilibrio.
Magari si può azzardare una riflessione che parta dall’inizio, dal titolo: Twin Peaks. Accanto all’ovvia natura morfologica del nome, subentrano input che attingono alla cosiddetta psicologia umanistica di Abraham H. Maslow, citata anche nelle definizioni di meditazione trascendentale, in particolare al concetto di peak experience (si veda Verso una psicologia dell’essere, pubblicato nel 1978 da Astrolabio Ubaldini Editore) e alle indagini di Josette Van Luytelaar (si legga, per una sintesi, Il flusso e la peak experience: sciogliere il congelamento dello shock su www.nicolettacinotti.net). La studiosa, nel saggio Lo specchio di Perseo o le risorse terapeutiche del flow and peak (in Manuale di analisi bioenergetica, a cura di Vita Heinrich-Clauer, FrancoAngeli, 2013), sostiene che: «Entrare in un alto livello energetico è condizionato dall’avere una peak experience. Inoltre il raggiungimento di livelli di energia sempre più elevati è una delle caratteristiche principali del flusso. Il concetto bioenergetico di carica è legato a questo […]». Aggiunge: «Una differenza, tuttavia, è che il flusso, in quanto tecnica occidentale, cerca di rafforzare il Sé (centratura), mentre il metodo orientale ha come obiettivo la scomparsa di sé (la fusione con l’universo)». Lo stesso Castaneda, ne Il potere del silenzio (BUR, 1999), enuclea alcuni elementi fondamentali dello sciamanesimo, proprio in termini energetici: «L’universo è un infinito agglomerato di campi di energia, che somigliano a fili di luminosità […] Poiché gli unici campi di energia percettibili sono quelli illuminati dal punto di intenso splendore, quel punto viene chiamato […] “il punto di unione” […] Quando il punto di unione si sposta, rende possibile la percezione di un mondo del tutto diverso, altrettanto obiettivo e reale di quello che percepiamo di solito».Ancora una volta: cosa è successo davvero in questo viaggio che comincia e si conclude con una madre?
Non lo so.
Ragionando attraverso gli indizi che Lynch e Frost hanno disseminato lungo il cammino, ritengo che quest’ultima scena possa rappresentare un omaggio del regista al potere infinito della mente (della mente che trascende, nel caso specifico).
Secondo le leggi fisiche non possiamo tornare indietro nel tempo perché non è possibile ridurre l’entropia di un sistema isolato: la freccia va solo in avanti.
La nostra mente (e il cinema o la tv che ne diventano compiuta espressione) può invece, attraverso i ricordi o i sogni, re-immaginare un ordine in ciò che, per natura, tenderebbe a divenire disordinato, infine a morire (la morte termica si realizzerà quando tutto il calore – il fuoco – sarà dissipato). La mente umana ha la facoltà di rendere il tempo bidirezionale.
Di nuovo: cosa è successo davvero in questo percorso tortuoso nella mente di David Lynch, una mente che è riuscita ad allontanare il più bel personaggio dell’original run dal miraggio feticista, scomponendo il prototipo in svariati personaggi altrettanto straordinari?
Non lo so e ritengo che sia un dono meraviglioso.
Rodolfo Rosa, sul magazine online della società italiana di statistica, riporta un estratto da Gli apprendisti stregoni: storia degli scienziati atomici di Robert Jungk (Einaudi, 1958): «Nonostante la serietà dei piani la bomba [atomica] restava pur sempre un prodotto…dell’azzardo. Tanto è vero che i matematici, giudicando cosa disperata un calcolo esatto del comportamento dei neutroni che provocavano la reazione a catena, erano a loro tempo ricorsi a un nuovo tipo di calcolo delle probabilità. Presentiamo i nostri problemi davanti alla ruota di una roulette, — si erano detti, — e avremo forse una risposta statistica su quanti neutroni in media vengono inghiottiti dai nuclei di uranio e quanti vengono emessi». Evidenzia poi che «l’algoritmo di Metropolis (basato sullo stesso metodo utilizzato per la costruzione della prima bomba atomica, ovvero il Metodo Monte Carlo N.d.R.) è l’algoritmo di minimizzazione usato da Madre Natura: un sistema può uscire da un minimo di energia per cercarne uno migliore […] Codificando questo principio, i Nostri ottengono una catena di Markov». I processi di Markov rappresentano un tipo di processi stocastici tali per cui «il futuro, dato il presente, è indipendente dal passato».
Is it the future or is it the past?
 Non è così importante, in fondo. Cooper-Richard e Laura-Carrie («Laura is the one» e il verbo to carry significa sia portare che riecheggiare: chi sta conducendo chi?) sono dove dovrebbero essere al momento giusto perché quella storia – una storia che ha donato a Norma e Big Ed un lieto fine tattile – possa ricominciare all’infinito: «I am dead, yet I live».
Non è così importante, in fondo. Cooper-Richard e Laura-Carrie («Laura is the one» e il verbo to carry significa sia portare che riecheggiare: chi sta conducendo chi?) sono dove dovrebbero essere al momento giusto perché quella storia – una storia che ha donato a Norma e Big Ed un lieto fine tattile – possa ricominciare all’infinito: «I am dead, yet I live».
E dopotutto lo sosteneva anche Dorothy (interpretata nientemeno che da Judy Garland) in The Wonderful Wizard of Oz, opera particolarmente cara (e assai citata, basti pensare alle ricorrenze testuali, evocative o dichiarate, in Wild at Heart) al regista di Missoula: «There’s no place like home».
Il nero prima dei titoli di coda dura vari secondi (ne ho contati trentacinque): eternity in an hour, per dirla con i versi di William Blake.
Vediamo infine Laura, all’interno della Red Room, sussurrare nell’orecchio di Cooper delle parole inudibili: la stessa scena che si ripete dopo tutti questi anni. Il Nano, nella medesima occasione, aveva introdotto quella Laura come sua cugina («she’s my cousin»): parole identiche a quelle che aveva usato Gordon, al cospetto di Desmond e di Sam Stanley, a proposito di Lil.
Per due volte ci è precluso il sentire, come a Gordon Cole: ciò forse ci avvicina a una comprensione di natura diversa.
Comunque sia andata, il ceppo è diventato d’oro e we’re home: è tempo anche per noi di provare a svegliarsi.
P.s. Mentre ero impegnata a riguardare Twin Peaks, ho sognato David Lynch che mi spiegava in modo dettagliato il significato dell’ultimo episodio della stagione. Durante il sonno ero convintissima di aver trovato finalmente il Graal. Al risveglio, non ricordavo più nulla.
Ecco, se un senso c’è, credo che stia proprio da quelle parti.



