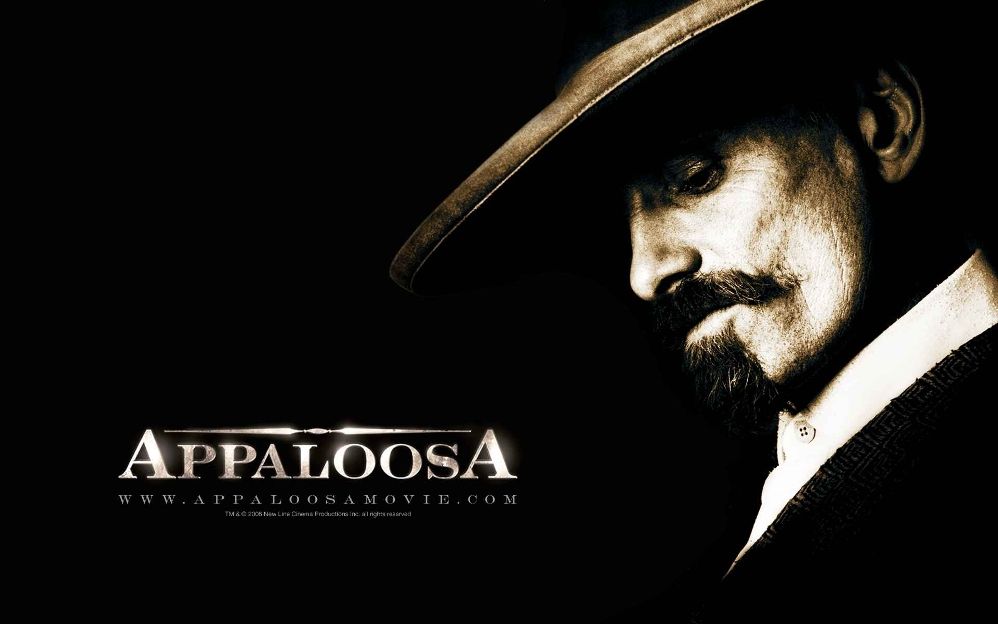TRAMA
New Mexico 1882. Randall Bragg ruba e uccide nella città di Appaloosa, Virgil Cole e la sua spalla Everett Hitch sono pagati per fermarlo.
RECENSIONI

Western degenere
Dal libro-pretesto di Robert B. Parker, riscritto filologicamente con Robert Knott, Ed Harris gira e interpreta un western che coincide con il suo superamento: la totale confidenza con i codici ottiene una rilettura studiata e consapevole. A partire dal prologo musicale di Jeff Beal, che include il rullio degli zoccoli nel sound complessivo, e sfocia nella parodo dei bimbi in veste corifea per definire gli accadimenti considerati. In questi il carattere di Virgil Cole è segnato dalla sovrapposizione: il lavoro di sceriffo trabocca nella vita - come da segnalazione diegetica di Allison French -, il ruolo è talmente elevato da confondersi con il giusto e dettare la Legge. Cole che cambia le regole di Appaloosa è Harris che rivede il codice di genere: in questo West il primo pistolero è afflitto da una gamma di debolezze (il principio di dislessia: la voce classica fatica a parlare) e finisce con un handicap impensabile per la frontiera, l'aurea romantica non avvolge la donna bensì l'uomo, il duello decisivo è affidato al comprimario. A ben guardare, però, Appaloosa mette in dubbio il concetto stesso di protagonista: Mortensen e Zellweger, che girano intorno a Harris in funzione di catalizzatore, tentano di liberarsi per guadagnare lo status di 'character dominante', non di rado vi riescono pienamente. Oltre le ovvie citazioni (Ford e Hawks su tutti), allora, il western si specchia e si vede rovesciato; imprime così una forte impronta metatestuale, con tracce letterali ma anche implicite (Virgil che scruta Allison al binocolo, ovvero 'mettere a fuoco' il contesto), rivoltamenti ironici e mai univoci, parecchie porte spalancate che invitano all'interpretazione. Profondo resta il rispetto verso i padri: si prenda la lunga vestizione di Cole, un'attenzione al dettaglio minimo che confessa la riverenza al modello di riferimento, insieme all'idea che la svolta ha più valore se prima si imbocca la strada principale. Appaloosa è il film che ufficializza il sodalizio Harris/Mortensen: l'influenza del secondo va vista come dato pesante, non solo sulle scelte tecniche, e se non è regia a quattro mani diventa ormai lecito puntare sul prossimo esordio dell'attore; d'altronde la coppia già rielabora l'esperienza comune, vedi l'esplosione violenta di Virgil nel pub che, a ruoli invertiti, si riallaccia alla metamorfosi di Tom Stall nel giardino di casa in A History of Violence. Deviazioni dalla superficie.

Il gusto del western
In Appaloosa la maestosità del New Mexico, collocazione ideale per una cittadina che porta il nome di una razza di cavalli, travalica nettamente la semplice funzione di cornice esornativa o ambientazione evocativa, scandendo i tempi e regolando il respiro cinematografico di una pellicola che ha nella ruvidezza e nella laconicità i suoi maggiori punti di forza. Al secondo film da regista, Ed Harris, anche coautore della sceneggiatura nonché paroliere e interprete della canzone You’ll Never Leave My Heart che chiude i titoli di coda, si immerge completamente nelle atmosfere assolate e cocenti del western assorbendone i valori narrativi (asciuttezza, essenzialità, elementarità) e morali (lealtà, virilità, fedeltà). Portando sullo schermo l’omonimo romanzo di Robert Parker, Harris aderisce con totale convinzione alla filosofia di vita che lo permea, infondendo al racconto un palpabile amore per gli spazi e manifestando una marcata predilezione per i rapporti umani schietti ma non irrispettosi, diretti ma non irriverenti. L’amicizia tra i due “pacificatori” Virgil (interpretato dallo stesso Harris con ogni sua ruga) e Everett (un misuratissimo Viggo Mortensen) non è tanto questione di parole o dichiarazioni di affetto quanto di comportamenti e silenzi d’intesa. La loro intimità è talmente collaudata che non ha bisogno di esternazioni, al contrario si nutre di una reciprocità implicita, di continui sottintesi pragmatici. Non mancano i momenti in cui i due fanno il punto della situazione, ma in questi frangenti i dialoghi non sono altro che la ratifica di una situazione che si è già definita di fatto: le scelte non si discutono, si compiono nel chiuso della propria coscienza. Questa lapidarietà trova la sua dimensione naturale nella rocciosa imponenza del New Mexico, terra che prosciuga ogni smanceria e genera riflessioni di esemplare sinteticità (la voce narrante di Everett racchiude il senso della vicenda in pochissimi interventi). Il cinemascope è formato d’obbligo, non soltanto per magnificare paesaggi, orizzonti e cieli, ma soprattutto per iscrivere i personaggi nel contesto, rendendoli diretta emanazione del territorio: il prepotente Randall Bragg (Jeremy Irons) incorniciato dalla porta del suo ranch, Virgil e Everett sovrastati dal deserto e dalle mesas, Allie (Renée Zellweger) “partorita” dalla stazione ferroviaria. Proveniente da una città imprecisata, sarà proprio lei a mettere in crisi il sodalizio dei peacekeeper, inserendosi tra i due come un corpo estraneo che esercita su Virgil un fascino irresistibile. La cittadina di Appaloosa, sorta intorno all’estrazione del rame successivamente interrottasi, costituisce il punto di convergenza dei vari personaggi: né città-fantasma né paese in crescita, rappresenta il luogo di conflitto tra la legge (demandata al duo di pacificatori) e l’arbitrio (la violenza del ranchero Bragg), tra la giustizia armata e la rapina indiscriminata. Ma al di là dell’esattezza spaziale e dell’esemplarità narrativa, il valore aggiunto della pellicola risiede nel piacere del western che promana da ogni inquadratura: scenografie accuratissime (dalla carta da parati ai legni del saloon), costumi individualizzati (completi scuri per Virgil, abiti vezzosi per Allie) e preziosismi fotografici (culminanti nei magnifici titoli di coda “oggettuali”) rendono la visione di Appaloosa un’esperienza di edonismo a 24 fotogrammi al secondo. Osservazione conclusiva sulle sequenze di duello: rapide, secche e despettacolarizzate, prendono le distanze sia dalla centralità drammatica dei modelli classici sia dalle esasperazioni enfatiche del western maturo, testimoniando quanto il nucleo del film non consista nel dinamismo o nella tensione, ma nelle psicologie austere e nelle situazioni di stallo apparente. Per assaporare, senza fretta, il gusto del western.


Seconda regia, dopo Pollock, dell’attore Ed Harris, che ha dichiarato di essersi ispirato a L’Uomo che Uccise Liberty Valance di John Ford e al romanzo “Riders of the purple sage” di Zane Grey (ma ne adatta uno di Robert B. Parker del 2005), che aveva già interpretato e prodotto per la Tv nel 1996: finalmente un vero western, classico, con uomini “maschi” (chi meglio di Viggo Mortensen a fargli da spalla?), la Giustizia che si ottiene con la pistola, ricchi e potenti passati per corrotti e ridicoli pavidi, l’amicizia virile e la figura femminile che non può che rompere un equilibrio perfetto. All’entrata in scena di Renée Zellweger parte la commedia sentimentale con il duro-e-puro personaggio di Harris (anche folle, come dice il suo vice, “Se no che pistolero è?”) che rivela tutti i suoi impacci, ma anche una potente, insolita vena misogina dove la donna, per quanto infingarda, viene comunque perdonata dall’uomo che (prima) niente lo piegava. È esaltante (ri)vedere questo modello maschile scomparso, senza compromessi, in pace con i propri lati bui. La regia è abbastanza accademica e senza guizzi: a colpire maggiormente è il disegno dei personaggi, la marcata (troppo?) vena romantica nel dipingere un’amicizia in complicità totale, con gesti d’amore (il finale) quasi omosessuali. L’equilibrio fra commedia e dramma è spesso a rischio ma non deborda. Harris scrive e canta anche la canzone “You’ll never leave my heart”.