
TRAMA
Fred e Mick, due vecchi amici, sono in vacanza in un elegante albergo ai piedi delle Alpi in compagnia di Leda, figlia di Fred. Mick, un regista, sta ancora lavorando.
RECENSIONI
 Con Youth Paolo Sorrentino prosegue nella sollecitazione smodata, perfino impudica, degli effetti più smaccatamente 'belli', sollecitanti, che, da Le conseguenze dell'amore, contraddistingue il suo gesto registico, teso ad amplificare, fin quasi ad arrivare alla parodia eccessiva, la stupefazione per un'immagine esteticamente potente che attrae al di là della significazione. Il regista, con i propri lavori, sembra assecondare quel bisogno, descritto da Milan Kundera ne L'arte del romanzo, «di guardarsi allo specchio della menzogna che abbellisce e di riconoscervisi con commossa soddisfazione»; che è poi il segreto che lega Fred Ballinger e Mick Boyle di Youth, come loro stessi raccontano a chi gli chiede della loro lunga amicizia: 'Ci raccontiamo solo le cose belle'. Questa stimolazione programmata dell'effetto è ottenuta per mezzo di un linguaggio (sia in fase di scrittura che di messa in scena) artificiosamente liricizzante, che trascende l'atteggiamento estetico stravolgendolo in estetismo, e dalla tendenza a raffigurare personaggi apparentemente 'universali' (su tutti, probabilmente, Jep Gambardella de La grande bellezza) sovraccarichi di messaggi altrettanto 'assoluti'; così enfatici e declamatori da dare l'impressione che a muoverli non siano tanto i sentimenti quanto il sentimentalismo. Sorrentino compie una vera e propria enfatizzazione del lato melodrammatico, per cui gli aspetti emotivi e sentimentali sono innalzati a valori assoluti: Kundera la chiama «dittatura del cuore», un segno distintivo che è proprio del kitsch, una categoria estetica che non può essere risolta sbrigativamente ricorrendo all'etichetta di «cattivo gusto». L'autore de L'insostenibile leggerezza dell'essere prova, ad esempio, a spiegarla così: «Il kitsch fa spuntare, una dietro l'altra, due lacrime di commozione. La prima lacrima dice: Come sono belli i bambini che corrono sul prato! La seconda lacrima dice: Come è bello essere commossi insieme a tutta l'umanità alla vista dei bambini che corrono sul prato! È soltanto la seconda lacrima a fare del kitsch il kitsch». Ecco, il cinema di Sorrentino (e lo si prenda senza intenti pregiudizievoli) cerca di provocare quella seconda lacrima, in quanto elegge come proprio fine la reazione emotiva dello spettatore.
Con Youth Paolo Sorrentino prosegue nella sollecitazione smodata, perfino impudica, degli effetti più smaccatamente 'belli', sollecitanti, che, da Le conseguenze dell'amore, contraddistingue il suo gesto registico, teso ad amplificare, fin quasi ad arrivare alla parodia eccessiva, la stupefazione per un'immagine esteticamente potente che attrae al di là della significazione. Il regista, con i propri lavori, sembra assecondare quel bisogno, descritto da Milan Kundera ne L'arte del romanzo, «di guardarsi allo specchio della menzogna che abbellisce e di riconoscervisi con commossa soddisfazione»; che è poi il segreto che lega Fred Ballinger e Mick Boyle di Youth, come loro stessi raccontano a chi gli chiede della loro lunga amicizia: 'Ci raccontiamo solo le cose belle'. Questa stimolazione programmata dell'effetto è ottenuta per mezzo di un linguaggio (sia in fase di scrittura che di messa in scena) artificiosamente liricizzante, che trascende l'atteggiamento estetico stravolgendolo in estetismo, e dalla tendenza a raffigurare personaggi apparentemente 'universali' (su tutti, probabilmente, Jep Gambardella de La grande bellezza) sovraccarichi di messaggi altrettanto 'assoluti'; così enfatici e declamatori da dare l'impressione che a muoverli non siano tanto i sentimenti quanto il sentimentalismo. Sorrentino compie una vera e propria enfatizzazione del lato melodrammatico, per cui gli aspetti emotivi e sentimentali sono innalzati a valori assoluti: Kundera la chiama «dittatura del cuore», un segno distintivo che è proprio del kitsch, una categoria estetica che non può essere risolta sbrigativamente ricorrendo all'etichetta di «cattivo gusto». L'autore de L'insostenibile leggerezza dell'essere prova, ad esempio, a spiegarla così: «Il kitsch fa spuntare, una dietro l'altra, due lacrime di commozione. La prima lacrima dice: Come sono belli i bambini che corrono sul prato! La seconda lacrima dice: Come è bello essere commossi insieme a tutta l'umanità alla vista dei bambini che corrono sul prato! È soltanto la seconda lacrima a fare del kitsch il kitsch». Ecco, il cinema di Sorrentino (e lo si prenda senza intenti pregiudizievoli) cerca di provocare quella seconda lacrima, in quanto elegge come proprio fine la reazione emotiva dello spettatore.
 Tutto ciò registicamente si traduce in forme di sorpresa e originalità a tutti i costi; un'aggressione compiuta per mezzo di deformazioni bizzarre non prive di abbreviazioni balbettanti: basti vedere come viene delineata (in Youth, ma più in generale nell'intera filmografia sorrentiniana) la schiera dei personaggi di contorno che il regista tende a stravolgere verso esiti 'espressionisti' e caricaturali, figure distorte e 'astigmatiche', dai modi e dalle fisionomie inquiete e irrealisticamente stilizzate. Presagi di sventura del gusto, che è sì una delle peculiarità del kitchs, portata però in eredità dalla maniera barocca. Ritornano a mente allora ancora le parole di Kundera (spogliate però dagli intenti giudicanti e prese come dato di fatto), quando scrive «il kitsch è il paravento della morte», che tracciano una continuità con il sentimento barocco, ossessionato dalla percezione del tempo e dall'epifania della fine. Lo stile neobarocco [1] di Sorrentino fatto, come detto, di disarmonie, eccessi, complicazioni e sovrabbondanza, in Youth (anche per la ragione che qui irride con minor strafottenza il vuoto solenne delle esistenza ritratte) trova legittima giustificazione, dato che il film si confronta direttamente con i temi di splendore e decadenza, con la tragedia silenziosa della finitezza. Le sue immagini finte, stucchevoli, proprio perché degradano consapevolmente il bello in fastosità dozzinale, riescono a trasmettere in qualche modo l'umore profondo appena accennato. Con Youth il regista pone al centro della propria riflessione il tema della vanitas, connaturato ad ogni natura morta, rappresentazione pittorica che può essere letta come termine di riferimento compositivo del film.
Tutto ciò registicamente si traduce in forme di sorpresa e originalità a tutti i costi; un'aggressione compiuta per mezzo di deformazioni bizzarre non prive di abbreviazioni balbettanti: basti vedere come viene delineata (in Youth, ma più in generale nell'intera filmografia sorrentiniana) la schiera dei personaggi di contorno che il regista tende a stravolgere verso esiti 'espressionisti' e caricaturali, figure distorte e 'astigmatiche', dai modi e dalle fisionomie inquiete e irrealisticamente stilizzate. Presagi di sventura del gusto, che è sì una delle peculiarità del kitchs, portata però in eredità dalla maniera barocca. Ritornano a mente allora ancora le parole di Kundera (spogliate però dagli intenti giudicanti e prese come dato di fatto), quando scrive «il kitsch è il paravento della morte», che tracciano una continuità con il sentimento barocco, ossessionato dalla percezione del tempo e dall'epifania della fine. Lo stile neobarocco [1] di Sorrentino fatto, come detto, di disarmonie, eccessi, complicazioni e sovrabbondanza, in Youth (anche per la ragione che qui irride con minor strafottenza il vuoto solenne delle esistenza ritratte) trova legittima giustificazione, dato che il film si confronta direttamente con i temi di splendore e decadenza, con la tragedia silenziosa della finitezza. Le sue immagini finte, stucchevoli, proprio perché degradano consapevolmente il bello in fastosità dozzinale, riescono a trasmettere in qualche modo l'umore profondo appena accennato. Con Youth il regista pone al centro della propria riflessione il tema della vanitas, connaturato ad ogni natura morta, rappresentazione pittorica che può essere letta come termine di riferimento compositivo del film.
Come sostiene Gianni Canova, la scrittura di Sorrentino «non si struttura su nessi consequenziali, né su una progressione narrativa basata sulla logica di causa e effetto. Piuttosto slitta, salta, ritorna». Un modus operandi conforme alle istanze neobarocche che abbandonano l'ordine e la simmetria a favore del disarmonico e dell'asimmetrico: «assistiamo alla perdita dell'interezza, della globalità, della sistematicità ordinata in cambio dell'instabilità, della polidimensionalità, della mutevolezza» [2].
Viene meno il rapporto tra il frammento e l'intero, Youth si struttura come una serie di scene madri prive di armonizzazione con le note contigue, tanto che va pensato non in termini di superarchitettura, bensì come un insieme di sottoarchitetture, ognuna orientata a effetti particolari. È il tramonto dell'interezza a vantaggio dei dettagli che diventano, per l'appunto, «fatti autonomi, con proprie valorizzazioni, e fanno letteralmente 'perdere di vista' i grandi quadri di riferimento generale» [3]. Possiamo dire che Sorrentino elabori una forma filmica disposta ad assecondare le nuove abitudini spettatoriali, quelle di un pubblico tendenzialmente individuale, desideroso di personalizzare la visione, di impadronirsi di momenti da antologia da rivedersi a casa (da qui anche l'impiego di una colonna sonora adoperata non solo in termini di stimolazione 'fisiologica', quindi come commento o contrappunto rispetto alla sequenza ma che ne determina anche la durata, tanto da permettere di parlare di una percezione temporale legata alla musica). Del resto, oggi, nel sistema della convergenza digitale, i media sono sempre più simili a vasi comunicanti che dissolvono i parametri tradizionali di coinvolgimento del pubblico nella ricezione dell'opera: «perduta ormai da tempo l'unicità esclusiva della sala come luogo proprio, assistiamo a una disseminante dislocazione del cinema [e più in generale dell'audiovisivo], espanso oltre ogni confine, disperso a perdita d'occhio in quel luogo globale che è la Rete, immenso ipertesto planetario» [4].
[1] Come scrive Omar Calabrese ne L'età neobarocca questo gusto sembra avere un andamento doppio: lavora sugli eccessi ma si configura in perenne sospensione, non tende cioè a produrre ribaltamenti veri e propri. L’impressione, insomma, è di “eccesso moderato”, se si accetta questo ossimoro.
[2] Omar Calabrese, L’età neobarocca, Laterza, Roma-Bari, 1987, p. VI.
[3] Ibid p.95
[4] Luciano De Giusti, Immagini migranti. Forme intermediali del cinema nell’era digitale, Marsilio, Venezia, 2008, p.17


La tormentata combriccola abbarbicata alle Alpi, in bilico tra vertiginose altezze esistenziali e ordinarie banalità di vite comuni in perplessa rotazione attorno a due artisti in impasse, riesce inaspettatamente a coniugare sibillina loquela e saccente verbosità. Difficile dire se le frequenti inconsistenze (talune madornali) di noiose conversazioni – cumuli di luoghi comuni, banalità epigrammatiche, lapidarie insensatezze – siano frutto di un’ubriacatura intellettuale dell’autore più che del suo odio verso i personaggi, o gli spettatori: ciò che ne La Grande Bellezza, con sforzo di fantasia e benevolenza, poteva essere considerato il portato di una visione sarcastica, qui apparentemente vorrebbe essere di sofferta intensità, mentre risulta soltanto tremendamente innaturale; come se l’autore avesse voluto forzare la propria materia, con atto d’imperio, a manifestare una grandezza o una bruttura che essa non possiede, giacché solo la forma la renderebbe degna di interesse e ammirazione. La pesantezza didascalica della scrittura fa soffrire da subito e senza tregua; ogni fatto o circostanza diventa pretesto perché questo o quel personaggio – spesso uno dei protagonisti, gli onesti e spaesati Caine e Keitel – elargisca sciocchezze da ginnasiale col tono supponente d’un oracolo. La sciatta insistenza nel sottolineare ciò che è già massimanente evidente – il confronto tra l’attrice di terza età venduta alla fiction televisiva e il regista che eroicamente rivendica il diritto a fare arte è tristemente esemplare – è vinta solo dalla fastidiosa imbecillità del gag del guitto truccato da Hitler che comunica all’attonito interlocutore di aver infine risolto l’immortale dilemma, se rappresentare il desiderio o l’orrore.
Allo spettatore non tramortito e non sufficientemente indispettito, Sorrentino riserva memorabili lezioni di cinema; i suoi automatismi estetici sono notori, e li sciorina con spirito inflattivo, ma senza baldanza e anzi con tetra sistematicità (ancora una volta, dimostrativa): iperboli, ridondanze, dolly, carrelli, climax d’imbarazzante cattivo gusto negli stentorei movimenti di macchina, di petulante insistenza, in avanti e avvolgenti. Il fellinismo di ritorno si risolve in un’accozzaglia di immagini lambiccate, gonfie di retorica, in un incedere tronfio e greve: le mani del musicista – inquadrate ben a lungo, se no lo spettatore non capisce – che danno il la a pacifiche e malcapitate vacche, la bocca del soprano spalancata nel gorgheggio (effetto assurdamente ridicolo, nel momento dell’apoteosi del protagonista), la solennità meditabonda con cui si pronunciano massime polverose, quasi fossero geniali intuizioni. Questo nulla con la superbia intorno, che cerca di occultare la volgarità – al contrario esaltandola – con l’ostentazione della padronanza del mezzo e con l’insana civetteria della dedica a quell’autentico artista e intellettuale che fu Francesco Rosi, potrebbe suscitare qualche riflessione meno legata alla contingenza: un triste interrogativo sul destino dell’illusione – ormai coltivata come un vizio, in una disperata solitudine – che vide nel cinema una possibile arte intellettuale di massa, mentre la radicale trasformazione, indotta negli ultimi trenta o quarant’anni, dei luoghi e dei criteri di elaborazione del senso sociale ne ha castrato la generosa ambizione, forse rivelandone il carattere inevitabilmente utopistico, e l’ha ormai ridotto a mera propaggine della società dello spettacolo.

«Io quello che credo è che la giovinezza sia bella ma non ho una prova» - Dargen D'amico, Io, quello che credo
«Il kitsch è la forma più adatta ad assolvere al tradizionale compito dell'arte e a esprimere la nostra epoca in termini sensibili» - Hermann Broch, Il kitsch
Una premessa è una premessa

C'è un film che spiega di cosa è fatto il cinema di Paolo Sorrentino. Ed è quello, l'unico, basato su una storia vera. Perché Il divo – lo abbiamo scritto - non era un film su Giulio Andreotti, ma sull'immaginario da esso prodotto. Sulla vox populi intorno al politico, su frammenti di cronaca e ciarla in remix, sui detriti di storie ammonticchiati sull'uomo, sulla maschera sformata della satira, su stralci di un pubblico processo: tutto, le bugie e le realtà, il mito e il dato, sullo stesso livello, fagocitate dallo spettacolo pop e barocco, in una coreografia di forme eccitate l'una sull'altra, nella gioia del kitsch, di un carnevale che sfigura, sminuisce ogni cosa. Estasi del cinema, morte del vero, gioco della politica: il godimento del linguaggio è anche lo scacco della verità, il trionfo dell'enigma, l'allontanamento del reale dietro il filtro opaco della retorica. Questo è il territorio in cui si muove – perché si muove - Sorrentino: nel continuo ribadimento, tra il funebre e l'euforico, della tragica autonomia dello spettacolo, nel suo separarsi dal vero. Ricordate? La grande bellezza era un titolo flebile, pronto a scomparire nella notte del cielo, sullo sfondo di una festa romana, da parte al campeggiar del logo Martini. In un'immagine una visione di mondo, l'obiettivo del protagonista, che era il titolo stesso, obnubilato dalla pubblicità. La grande bellezza era quel mondo ridotto a spettacolo sfatto e imperante: in un film in cui il simbolico era sfinito (Serena Grandi era Serena Grandi, i due personaggi usciti dalla scena fagocitante di Roma si chiamavano Romano e Ramona, «Roma No», nel nome, per sciocco anagramma), Jep Gambardella smontava retoriche e ci si perdeva, in quelle degli altri e nella sua, soprattutto, tra sentenze irrise e motti seriosi, semplificazione contro semplificazione, critico del linguaggio e insieme suo ostaggio: di fronte al protagonista, come allo spettatore, c'era il costante enigma dell'autenticità, l'impossibilità di riconoscere il reale dalla posa. Quel «le radici sono importanti» era una frase rivelatoria o una pillola di francescanesimo d'accatto? E il raggiungimento della grande bellezza, quel seno ricordato per anni, era la risoluzione o un ripiegamento? La gioia delle piccole cose o un semplice paio di tette? Sorrentino su questo lavora: su un kitsch rivendicato, ovvero su un mondo ridotto a puro ammiccante ambiguo linguaggio, a impero del misero senso e del segno sovrabbondante, gaudentemente giostrato, a retorica secessionista ed esaltata, lontanissima dal referente, in esilio. Frasi letteralmente a effetto, frammenti di cinema-performance da consegnare a YouTube, stimoli usa e getta, posa su posa, dittatura della fiction, della serialità, della citazione, godimento e tragedia del linguaggio per il linguaggio, caricatura e parossismo, apoteosi della moda, gabbia del midcult. Ed è dunque ridicolo lamentarsi del vuoto delle forme di Sorrentino, quanto è ottuso deridere (a suon di una lingua ridotta al tweet e allo status) i suoi dialoghi da “Baci Perugina”: è la materia da cui il suo cinema nasce, si celebra sino allo stucchevole per poi guardarsi impotente, è la tritura di linguaggio in cui s’esaltano, e con cui si soffocano, i suoi personaggi.
Personaggi in cerca d'amore
 In questo esteso dominio della fiction, in cui tutto è puro estetismo (Marx è un tatuaggio sulla schiena di Maradona), in cui ogni gerarchia dell'informazione e della morale tende all'annullamento e in cui ogni dettaglio - la carta delle Rossana, una coppia muta, una pallina da tennis - apre ad associazioni esistenziali e soprattutto formali, a esercizi stranianti d'accostamento audio/video, a non necessitate digressioni, a frammenti di poesia anche semplice, anche misera, sicuramente kitsch e midcult, l'uomo si riduce alla maschera, l'albergo di Youth - La giovinezza è un museo delle cere, il cinema è un ospizio di sosia (Maradona, la Regina, Caine che sfacciatamente replica Servillo), un mondo popolato da stanchi simulacri, un teatro di sfingi monologanti, uno spettacolo costantemente al lavoro (concerti, mimi, attori e modelle): il reale è lontano, l'emozione con esso, il cruccio del cripto-rifacimento felliniano è riuscire a trovare l'autentico. I ricordi (Gilda Black) chiedono il filtro della bugia («la prima volta che sono andato in bicicletta»), per rinascere necessitano la messa in scena a pagamento (la passeggiata con la prostituta), un amore decennale è consumato solo nel rapporto regista/attrice, il limite cognitivo per eccellenza, la morte, è un altrove in cui si gira «un altro film». Un incubo è un videoclip à la Joseph Kahn, personaggi del nostro mondo dello spettacolo si mischiano a quelli di quel mondo (Paloma Faith), Miss Universo compare sulle pagine di un giornale, entra nelle visioni sognanti di Caine, fa il suo ingresso nell'albergo e infine si spoglia, ed è come se non ci fossero differenti livelli di reale, come se tutto, il vero e il sogno, la fantasia e la passerella, fossero solo lo stesso spettacolo di consumo, da cui sono esclusi i problemi del mondo. Hitler è una maschera oscena rimessa in scena, non è l'orrore a interessare, ma «il desiderio». Questo è quello che ricerca Sorrentino: il desiderio che sfalda i confini del ruolo, l'uscita dall'apatia puro sensibilista dell'immagine, dall'atarassia dello spettacolo. O dello spettacolo dalla sua atarassia. «Il futuro» detto da un uomo che è l'ombra del suo mito, del suo passato, Maradona, come sfregio al cinismo semplificatorio: come i precedenti, Youth è un film che s'abbiglia di e soffre scientemente la malattia del contemporaneo, l'ironia come una condanna, la parodia come rifugio, la vergogna di prendere le cose sul serio, un film in cui a ogni tono grave segue il suo alleggerimento demistificante, ogni romanticismo è ridotto a goffaggine o stucchevole falso (la caramellosa CGI della montagna nel finale dedicato alla figlia), ogni momento d'espressione interiore è riducibile alla performance (il monologo della figlia si fa, in quel piano fisso costretto sul volto, la prova di bravura di Rachel Weisz), all'estatica goduriosa del cinema, alla frase da Smemoranda. Quell'estasi superficiale in cui la ricerca della grande bellezza si perdeva, dispersa nello strabordio degli stimoli, come a dire dell'impossibilità di concentrarsi, di perseguire un obiettivo, una rivelazione d'autentico, in un mondo che ammalia e abbaglia di spettacolo incessante, nell'eccesso d'immagine e di stimoli, nel reale in cui tutto è sistematicamente in posa, nel circo pubblicitario dei sé (alla fin fine, la pubblicità della 500 in tv, durante la messa in onda di La grande bellezza, era un gesto di situazionismo paradossale, triviale e amorale). Come in Birdman, come in Sils Maria, come in Foxcatcher, la ricerca di sé è solo un sé da offrire al pubblico, tramite la maschera, (d'attore: vedi Paul Dano): essere amati è oggi l'essere riconosciuti nello spettacolo. È la maschera, a essere. La fiction per fare autofiction. Per uscire da questa patologia identitaria, a questo autismo comunicativo, i personaggi di Sorrentino, nel corso degli anni, si sono trovati di fronte a differenti forme di relazione, a residui di sentimento nell'impero del linguaggio amorale. Se il principio primo dell'etica è quello di pensarsi nel ruolo dell'altro, in L'uomo in più era il nome dei personaggi, una questione elementarmente nominale, a far circolare l'empatia del destino, in Le conseguenze dell'amore era il sacrificio per un amore scientemente illusorio e anaffettivo, in This Must Be the Place era una questione d'estetica politica (come poi in The Act of Killing di Oppenheimer, per esempio): mettere il nazista nel ruolo dell'oppresso, farne spettacolo, perché il cinema di Sorrentino è tutto lì dentro, nello spettacolo si risolve, nello spettacolo si chiude, e non sa uscirne (pensate all'agonia dei finali che si rincorrono). Cul de sac. Come fanno pochi registi, a Sorrentino interessa lo scontro tra l'uomo e l'immaginario. Come Wes Anderson con le sue geometrie, con il senso per il pop hispterico, con le case di bambola retrò, come Harmony Korine con il videoclip rap, il lessico gangsta, con la bassissima tv, come Cronenberg con la smaterializzazione del tardocapitalismo e l'oblio del reale al tempo dei social, Sorrentino racconta di uomini parlati, mossi, fagocitati da un immaginario: postmodernariato baricchiano, fellinismo di riporto, aforismi da cinema classico, massime da social, playlist dei brani amati, pose da controintellettuale, macinatura di cultura bassa e alta. Ma se in Korine, per esempio, c'è un realismo che si corrompe e s'allucina a suon di hip hop, valori bassoventrali e sentenze criminali, in Sorrentino la dialettica manca, il suo universo è disperato perché chiuso in una bolla autosufficiente, sostanzialmente priva d'altrove. Un film come Youth non si pone problemi differenti da uno come Holy Motors. E se La grande bellezza si chiudeva sull'enigma dell'autentico, ed era una constatazione della prigionia, del doppio segno dell'immagine, Youth cerca la liberazione di quelle figure ingessate, di quei sosia, di quell'umanità svuotata al mero segno (cfr. la moglie): lo fa banalmente, nella bellezza del gesto di un obeso sportivo, nell'elogio del corpo della massaggiatrice, lo fa soprattutto, come è ovvio che sia, con la musica, con un'arte priva di referente reale, che è impossibile degradare a immagine simulacrale, a caricatura grottesca. Se il miracolo della Santa non era risolutivo, e probabilmente non era che spettacolo, qui, sulle note dei God Speed You! Black Emperor, il monaco levita, c'è materiale fuor di retorica in cui provare a credere.
In questo esteso dominio della fiction, in cui tutto è puro estetismo (Marx è un tatuaggio sulla schiena di Maradona), in cui ogni gerarchia dell'informazione e della morale tende all'annullamento e in cui ogni dettaglio - la carta delle Rossana, una coppia muta, una pallina da tennis - apre ad associazioni esistenziali e soprattutto formali, a esercizi stranianti d'accostamento audio/video, a non necessitate digressioni, a frammenti di poesia anche semplice, anche misera, sicuramente kitsch e midcult, l'uomo si riduce alla maschera, l'albergo di Youth - La giovinezza è un museo delle cere, il cinema è un ospizio di sosia (Maradona, la Regina, Caine che sfacciatamente replica Servillo), un mondo popolato da stanchi simulacri, un teatro di sfingi monologanti, uno spettacolo costantemente al lavoro (concerti, mimi, attori e modelle): il reale è lontano, l'emozione con esso, il cruccio del cripto-rifacimento felliniano è riuscire a trovare l'autentico. I ricordi (Gilda Black) chiedono il filtro della bugia («la prima volta che sono andato in bicicletta»), per rinascere necessitano la messa in scena a pagamento (la passeggiata con la prostituta), un amore decennale è consumato solo nel rapporto regista/attrice, il limite cognitivo per eccellenza, la morte, è un altrove in cui si gira «un altro film». Un incubo è un videoclip à la Joseph Kahn, personaggi del nostro mondo dello spettacolo si mischiano a quelli di quel mondo (Paloma Faith), Miss Universo compare sulle pagine di un giornale, entra nelle visioni sognanti di Caine, fa il suo ingresso nell'albergo e infine si spoglia, ed è come se non ci fossero differenti livelli di reale, come se tutto, il vero e il sogno, la fantasia e la passerella, fossero solo lo stesso spettacolo di consumo, da cui sono esclusi i problemi del mondo. Hitler è una maschera oscena rimessa in scena, non è l'orrore a interessare, ma «il desiderio». Questo è quello che ricerca Sorrentino: il desiderio che sfalda i confini del ruolo, l'uscita dall'apatia puro sensibilista dell'immagine, dall'atarassia dello spettacolo. O dello spettacolo dalla sua atarassia. «Il futuro» detto da un uomo che è l'ombra del suo mito, del suo passato, Maradona, come sfregio al cinismo semplificatorio: come i precedenti, Youth è un film che s'abbiglia di e soffre scientemente la malattia del contemporaneo, l'ironia come una condanna, la parodia come rifugio, la vergogna di prendere le cose sul serio, un film in cui a ogni tono grave segue il suo alleggerimento demistificante, ogni romanticismo è ridotto a goffaggine o stucchevole falso (la caramellosa CGI della montagna nel finale dedicato alla figlia), ogni momento d'espressione interiore è riducibile alla performance (il monologo della figlia si fa, in quel piano fisso costretto sul volto, la prova di bravura di Rachel Weisz), all'estatica goduriosa del cinema, alla frase da Smemoranda. Quell'estasi superficiale in cui la ricerca della grande bellezza si perdeva, dispersa nello strabordio degli stimoli, come a dire dell'impossibilità di concentrarsi, di perseguire un obiettivo, una rivelazione d'autentico, in un mondo che ammalia e abbaglia di spettacolo incessante, nell'eccesso d'immagine e di stimoli, nel reale in cui tutto è sistematicamente in posa, nel circo pubblicitario dei sé (alla fin fine, la pubblicità della 500 in tv, durante la messa in onda di La grande bellezza, era un gesto di situazionismo paradossale, triviale e amorale). Come in Birdman, come in Sils Maria, come in Foxcatcher, la ricerca di sé è solo un sé da offrire al pubblico, tramite la maschera, (d'attore: vedi Paul Dano): essere amati è oggi l'essere riconosciuti nello spettacolo. È la maschera, a essere. La fiction per fare autofiction. Per uscire da questa patologia identitaria, a questo autismo comunicativo, i personaggi di Sorrentino, nel corso degli anni, si sono trovati di fronte a differenti forme di relazione, a residui di sentimento nell'impero del linguaggio amorale. Se il principio primo dell'etica è quello di pensarsi nel ruolo dell'altro, in L'uomo in più era il nome dei personaggi, una questione elementarmente nominale, a far circolare l'empatia del destino, in Le conseguenze dell'amore era il sacrificio per un amore scientemente illusorio e anaffettivo, in This Must Be the Place era una questione d'estetica politica (come poi in The Act of Killing di Oppenheimer, per esempio): mettere il nazista nel ruolo dell'oppresso, farne spettacolo, perché il cinema di Sorrentino è tutto lì dentro, nello spettacolo si risolve, nello spettacolo si chiude, e non sa uscirne (pensate all'agonia dei finali che si rincorrono). Cul de sac. Come fanno pochi registi, a Sorrentino interessa lo scontro tra l'uomo e l'immaginario. Come Wes Anderson con le sue geometrie, con il senso per il pop hispterico, con le case di bambola retrò, come Harmony Korine con il videoclip rap, il lessico gangsta, con la bassissima tv, come Cronenberg con la smaterializzazione del tardocapitalismo e l'oblio del reale al tempo dei social, Sorrentino racconta di uomini parlati, mossi, fagocitati da un immaginario: postmodernariato baricchiano, fellinismo di riporto, aforismi da cinema classico, massime da social, playlist dei brani amati, pose da controintellettuale, macinatura di cultura bassa e alta. Ma se in Korine, per esempio, c'è un realismo che si corrompe e s'allucina a suon di hip hop, valori bassoventrali e sentenze criminali, in Sorrentino la dialettica manca, il suo universo è disperato perché chiuso in una bolla autosufficiente, sostanzialmente priva d'altrove. Un film come Youth non si pone problemi differenti da uno come Holy Motors. E se La grande bellezza si chiudeva sull'enigma dell'autentico, ed era una constatazione della prigionia, del doppio segno dell'immagine, Youth cerca la liberazione di quelle figure ingessate, di quei sosia, di quell'umanità svuotata al mero segno (cfr. la moglie): lo fa banalmente, nella bellezza del gesto di un obeso sportivo, nell'elogio del corpo della massaggiatrice, lo fa soprattutto, come è ovvio che sia, con la musica, con un'arte priva di referente reale, che è impossibile degradare a immagine simulacrale, a caricatura grottesca. Se il miracolo della Santa non era risolutivo, e probabilmente non era che spettacolo, qui, sulle note dei God Speed You! Black Emperor, il monaco levita, c'è materiale fuor di retorica in cui provare a credere.
Saluti e baci

E dunque: mi è piaciuto, Youth?
È importante?
No.
Perché preferisco cercare di leggerlo, un film, prima di giudicarlo.
Sorrentino, con Lars Von Trier, con Gaspar Noé, è un regista che continua a lavorare sull'immaginario contemporaneo, sulle sue forme degradate ed eccitate, abbandonandosi a esse con gioia onanista ma mai subdola mentre le espone a una possibile problematicità, giostrandosi con diabolica cura tra le retoriche che opprimono la cultura, le pretese intellettuali di una critica tristemente mai aggiornata al presente, le risibili regole del mercato dell'art film, l'autorialismo for the masses, la provocazione all'acqua di rose, le patetiche reazioni ciarlanti del mondo 2.0. Youth non finisce al cinema, purtroppo. Per me sarebbe a sufficienza. Finisce nel chiacchiericcio che se ne fa, così coerente con quanto messo in scena, così chiuso nello scialo delle retoriche, così in gabbia nello stesso stanco copione.
A chi vuole, il circo dei voti:

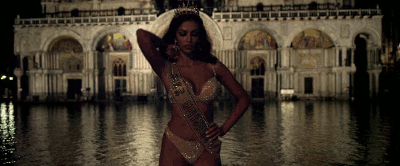
La Grande Bellezza ha segnato un nuovo percorso, più faticoso, midcult, radical chic, intellettualistico per Paolo Sorrentino che, dopo i richiami a La Dolce Vita, pare rifarsi ancora a Federico Fellini, questa volta a 8 ½ e al suo albergo termale. Ha perduto o non rincorre più l’inventiva sorprendente, sperando in illuminazioni intime che scaturiscano da una serie di dialoghi con aforismi. Non vuole più ridere né sorridere, si bea di un enchiridio sulla giovinezza, ovvero sul come la vecchiaia guarda al passato oppure, ma è arduo esserne certi in una struttura episodica che tenta di progredire per frasi ad effetto e scene emblematiche, sulla giovinezza di spirito da preservare al di là dell’età anagrafica (così sentenzia la parte finale con diagnosi per il personaggio di Michael Caine). In un’opera ancora girata in inglese, i suoi caratteri combattono sempre con le emozioni ma si rinchiudono in un microcosmo che non è surreal-folle come Hotel New Hampshire e che si regge sulle sole battute fra Caine (fantastico) e Harvey Keitel, su nuovi amori giovanili, su comprimari buttati nel mucchio a caso, sul convenzionale dramma di una figlia che accusa l’assenza del padre, su sparute riflessioni sul ruolo dell’arte nella vita (dove si dice tutto e niente: non siamo artisti ma comparse; la giovinezza è insita nel valore che la tua arte ha lasciato nel mondo), mentre il talento dell’autore è relegato nella pittoricità di contorno, quando osserva gli ospiti termali in quadri strabilianti per composizione e fotografia.



