TRAMA
1923, Richmond in Inghilterra: una giornata di Virginia Woolf. 1951, Los Angeles: una giornata di Laura Brown. 2001, New York: una giornata di Clarissa Vaughan.
RECENSIONI
"Ti amo. Suona banale?"
La signora Dalloway disse che avrebbe comprato lei i fiori. Lucy aveva fin troppo lavoro.
Le porte dovevano essere tolte dai cardini; stavano arrivando gli uomini di Rumpelmayer. E poi, pensò Clarissa Dalloway, che bella mattina, fresca come se fosse stata pensata per dei bambini su una spiaggia.
V. Woolf - La signora Dalloway
Può impugnare la penna e seguirla con la mano mentre si muove per il foglio; può impugnare la penna e scoprire che è solo lei: una donna in vestaglia che regge una penna, timorosa e incerta, con una competenza solo superficiale e nessuna idea su dove cominciare e cosa scrivere.
Impugna la penna.
La signora Dalloway disse che avrebbe comprato lei i fiori.
Che eccitazione, che shock, essere viva in una mattina di giugno, florida, scandalosamente privilegiata, con una semplice commissione da fare. Lei Clarissa Vaughan, una persona comune (a questa età, perché preoccuparsi di negarlo?) ha dei fiori da comprare e una festa da dare.
Richie sorride; guarda intensamente il viso di lei. Lei ricambia lo sguardo. Si fermano, immobili, a osservarsi, e per un momento lei è precisamente quello che le capita di essere: una madre incinta che si inginocchia in una cucina con suo figlio di tre anni, il quale conosce il numero quattro. Lei è se stessa, ed è l'immagine perfetta di se stessa: non c'è differenza. Sta per preparare una torta di compleanno - solo una torta - ma, in questo momento, nella sua mente la torta è lucida e splendente come le fotografie sulle riviste.
M. Cunningham - Le ore
* IL ROMANZO - Uscito con grande clamore critico, ho inizialmente snobbato il romanzo premio Pulitzer dal quale il film è tratto, scettico da sempre nei confronti di certi casi che il più delle volte risultano pompati ad arte, e preso com'ero da tutt'altra narrativa americana, che fosse quella iper immaginativa di Leyner, quella apocalittica, "politica", vagamente situazionista di un Palahniuk o quella frammentata e inafferrabile di un Moody, tanto per non ripetere i soliti (venerabili) nomi che faccio da sempre. Dopo Pynchon e DeLillo (autori enormi che reggo a fasi alterne) la letteratura statunitense mi è apparsa come una tavola imbandita di pietanze nuove e stimolanti che trovavo si attagliassero in maniera perfetta ai miei gusti. Finita, per me, l'era dei neoclassici alla Irving, ero preso da tutt'altro e un ritorno a certi sapori, i Kinder o i Chabon o (tanto per nominare l'ultimo) gli Enger per esempio, lo praticavo occasionalmente con curiosità e scetticismo, traendone comunque un discreto godimento. Fu in questa congiuntura "di ritorno" che approdai a Carne e Sangue di Michael Cunningham che ritenevo (non mi si chieda perché, non lo so) si collocasse sulla stessa linea dei predetti. Niente di più sbagliato. Il romanzo, di scrittura solida e intarsiata, aveva sì le cadenze del classico ma smentite da una struttura particolarissima che poneva la narrazione dei destini dei membri di una famiglia su una sorta di scacchiera destrutturante. Conquistato ed entusiasta decido di leggere Le Ore e mi trovo di fronte a un piccolo capolavoro. Tre storie di 24 ore, in epoche diverse, che intrecciano progressivamente i loro legami: la giornata di Virginia Woolf alle prese con la scrittura de La Signora Dalloway, quella della editor Clarissa (che può considerarsi, anche narrativamente, la variazione su tema più riconoscibile della novella woolfiana), quella della casalinga Laura che legge quel romanzo. Tutto questo con uno stile delicato e pregno di senso: lo scavo intimo è seducente, i personaggi toccanti, l'agnizione finale abbagliante (lo scrittore è bravissimo nel farcela inconsciamente intuire senza darcene la piena consapevolezza se non nel momento narrativo da lui prescelto). Il tentativo di Cunningham di mantenere il romanzo profondamente proprio, per quanto giocato sui continui rimandi e immerso nelle fluenti onde della scrittura di Virginia Woolf, cosa che ne impone un'affascinante lettura a più gradi, può dirsi pienamente riuscito sia sul piano tematico che su quello squisitamente letterario.
* LA SCENEGGIATURA - L'adattamento di THE HOURS è affidato al veterano David Hare. E' tra i più rappresentati autori di teatro britannici (suoi Plenty, da cui Schepisi trasse un film con la Streep, e la reinvenzione della Ronde schnitzleriana, The Blue Room, per la regia di Mendes, che portò Kidman sui palcoscenici londinesi). Anche regista cinematografico, a lui si deve il bello e pinteresque WETHERBY, Orso d'oro a Berlino, con un gran cast in cui spiccava la protagonista, Vanessa Redgrave. Il lavoro sulla sceneggiatura di un romanzo in cui accade pochissimo e che si sofferma soprattutto sul lato interiore dei personaggi appariva un'impresa di difficile realizzazione che lo scrittore risolve con suprema eleganza riportandone gli eventi di superficie e insinuandosi con molto tatto nei vari risvolti, senza speciosi approfondimenti, lasciando molto all'intuizione dello spettatore: in questo modo, senza ricorrere ad artifici di sorta, che molto avrebbero appesantito, né tantomeno limitandosi a un lavoro di mera illustrazione esteriore, lo script riesce a trattare i nodi cardinali della novella mantenendone pressoché intatta l'intensità. Hare, lavorando di fino, rinunciando al facile espediente della voce off che per la riduzione di un romanzo del genere sarebbe stato visto da altri come imprescindibile escamotage, elimina comprensibilmente qualche passaggio e ne modifica altri: in particolare cambia il contesto, arricchisce e rincara la dose drammatica dell'ultimo scambio di battute tra la Woolf e il marito e riconsidera le modalità di esposizione del rapporto tra Laura e il figlio, che Cunningham cura moltissimo, preferendo all'inizio farne scorgere il disagio di fondo in controluce e concedendosi un fitto dialogo finale tra Clarissa e Laura, momento questo che non stona affatto nell'economia del film, essendo esplicativo, certo, ma con apprezzabile discrezione. Un lavoro di adattamento davvero esemplare.
* LE ATTRICI - Ho visto il film doppiato e mi riservo, appena possibile, di riguardarlo in lingua originale: quanto strepitosa sappia essere Meryl Streep lo può dire solo chi ha la sentita recitare con la sua voce (curiosa e sottilmente autoreferenziale la scelta della Streep nel ruolo di Clarissa tenendo conto che nel romanzo la donna incrocia un'attrice e, non riuscendo ad identificarla, fa l'ipotesi che si tratti proprio di Meryl Streep): si intuisce comunque di trovarsi di fronte alla solita magnifica performance, quella di un'interprete meravigliosa che, finalmente, e anche ADAPTATION ne è la dimostrazione, ritroviamo sullo schermo con lavori degni del suo talento smisurato. Ineccepibile ci pare poi la Kidman nella parte della Woolf per quanto il trucco appaia palesemente fittizio: non ci si libera, insomma, dell'impressione di stare a guardare la bella attrice travestita da bruttona; l'interpretazione svaporata della Moore parrebbe anch'essa degna di nota (l'attrice ha una voce italiana che accentua troppo il registro svenevole - e non è la prima volta - laddove l'interprete è solitamente più rigorosa e pulita).
* LA MUSICA - THE HOURS si pregia delle musiche di Philip Glass, uno dei nomi chiave di quel movimento che Michael Nyman definì per primo, in un celebre saggio, minimalismo (nel quale peraltro Glass non si riconosce più). Reduce dalla prova sontuosa di NAQOYQATSI, quarta collaborazione col regista Godfrey Reggio, e dalla pubblicazione di Saxophone per l'esecuzione del Rascher's Saxophone Quartet, il musicista sfodera il solito score di gran classe, tutto gocato sugli archi e i delicati ricami pianistici. E' piuttosto difficile tener dietro alla sconfinata discografia del grande compositore: del primo, fondamentale periodo, vale la pena ricordare il monumentale Music in 12 parts, un vero manifesto, e Einstein on the beach, la partitura per lo storico, omonimo allestimento teatrale di Robert Wilson. Dopo un periodo di vaga incertezza, interrotto da alcuni lampi di meravigliosa stupefazione sonora (SONGS FROM LIQUID DAYS su testi di Byrne, Anderson, Vega, Simon), Glass ritrova la sua vena più felice con le due sinfonie tratte dalle omonime opere berlinesi firmate BowieEno (Low e Heroes), Passages con Ravi Shankar (proprio la trascrizione delle partiture dell'indiano, negli anni 70, fu decisiva nella definizione del suo particolarissimo mondo musicale) e, soprattutto, con le rimeditazioni liriche di tre film di Jean Cocteau in cui, genialmente, il musicista usò le sceneggiature come un libretto: le perfomance consistevano nella riproposizione del film, senza audio, e i cantanti, accompagnati dall'orchestra, che mimavano, in maniera perfettamente sincronica, il labiale degli attori (ebbi la fortuna di trascorrere un pomeriggio con Philip Glass e quando gli ho chiesto come aveva fatto a ottenere questo difficilissimo risultato mi rispose: "Oh, è stato piuttosto semplice: basta conoscere le note e avere un buon cronometro"). Nominata, per tutte le altre, la musica per il balletto coreografato dall'incomparabile Twyla Tharp, In the upper room (una trentina di minuti di sublime fusione tra corpo e note, un crescendo da lacrime agli occhi, l'Esperienza della suprema bellezza: l'ho visto al teatro di Amsterdam e l'ho intravisto in RAI - Maratona d'estate - una volta: se qualche lettore se lo ritrova in vhs sappia che il sottoscritto è disposto ad atti irragionevoli per averlo), capitolo a parte è costituito dalle colonne sonore (è da qualche tempo disponibile un cofanetto antologico benché sintetico, Philip on film, che ricomprende anche il soundtrack "posticcio" del DRACULA di Browning; inoltre THE MAN IN THE BATH - per l'omonimo corto di Greenaway - e DIASPORA - per Egoyan - altrimenti inedite). Le migliori colonne sonore rimangono quella di MISHIMA, uno dei miei dischi preferiti in assoluto, quella de LA SOTTILE LINEA BLU di Morris (non acquistate il disco, non vi sto a dire perché, è troppo lungo: optate per le versioni pianistiche contenute in Solo Piano, che prendono il nome di Metamorphosis, e di cui THE HOURS utilizza il secondo, splendido, movimento) e per THE SECRET AGENT; da snobbare senza alcun rimpianto la sopravvalutatissima e assai pallosa KUNDUN. Val la pena ricordare che Cunningham ha passato la sua giovinezza al college ascoltando EINSTEIN ON THE BEACH: molti dei suoi romanzi hanno dentro, in un certo senso, le note di Glass che facevano da sottofondo alle sue ore di scrittura.
* LA REGIA - Il film, inizialmente affidato ad Alan Parker, è diretto da Stephen Daldry. Reduce dal successo del semitelevisivo BILLY ELLIOTT, Daldry svolge in questo caso un lavoro di conveniente prosciugatura, rimanendo saldamente attaccato alla sceneggiatura, risultando da un lato impeccabile e dall'altro poco coraggioso (ma per un azzardo in materia c'era bisogno di un direttore con le palle, quindi è forse da apprezzare la rinuncia a qualsiasi azzardo).
* LE ORE - Una volta tanto la somma degli addendi fa il risultato. Non lo nego: la concentrazione di tanti fattori interessanti e la nefasta produzione Miramax lasciavano presagire la solita "operazione" potenzialmente fallimentare. Il film, fin dall'inizio invece (con quel bel montaggio alternato che rende in pochi minuti il tema del parallelismo delle storie senza sottolineature o facili rigiramenti), gioca bene le sue carte, smentendo - per la sua composita struttura, mancando fortunatamente tutti gli appuntamenti con il facile ammicco e risultando commovente senza essere mai stucchevole - la sua apparenza di film "per signore" (cos'è un film per signore? Suvvia, non è necessario che lo dica, chi frequenta i cinema sa che certi lo sono, e che lo siano lo dimostra una sbirciata nelle sale a certe ore, in certi giorni). Difficile rendere l'ansia del quotidiano, la fatica nell'affrontarlo come il banale enigma del quale trovare la risaputa soluzione, la ritrosia a vivere l'ovvio, ad accettarne l'incanto e la necessità senza cadere nel perverso e immotivato terrore dell'ordinario: perché è molto più difficile spostarsi per frazioni di millimetri che percorrere chilometri. Il film riesce a muoversi bene in questo insidioso, perché difficilmente delimitabile, territorio tematico e lo fa proponendo le sue storie senza teoremi, basandosi proprio sul gesto minimo, sul dettaglio apparentemente insignificante, sul ricorrere di certi particolari: il dolore è di tutti, i carnefici di alcuni sono stati le vittime di altri e per tutti le ore occasionali di felicità sono sparsi granelli dorati in un mucchietto di tempo cupo e difficile, nel grande cumulo di altre innumerevoli ore, calme o vuote.
Solo il cielo sa perché lo amiamo tanto.

Una vita in una sola giornata. Un arco temporale apparentemente breve sottende un segmento di vita determinante nell’esistenza di tre donne diverse ma accomunate da una latente infelicità. Tre storie montate fra di loro da oggetti-immagini, feticci che il Stephen Daldry utilizza per collegare – non solo sul piano visivo – i movimenti, le ossessioni e le pulsioni di queste tre donne, cucendo fra di loro ottant’anni di storia, due continenti, tre modi di vivere diversi. La ricerca di identità affettiva le porta alla deriva, confondendo i limiti fra sessualità e amore, fra solidarietà e affetto. Tre baci saffici sigillano l’incertezza, lo smarrimento, sospeso fra l’incredulità e il desiderio, inevitabilmente beffato dalle circostanze, dalle convenzioni sociali, dal gioco di ruoli che è evidentemente modellato dal tempo. Virginia Woolf mostra segni di evidente squilibrio – o di illuminata ma ermetica saggezza – che gradualmente la condurranno al suicidio, e grida il suo allarme alla sorella, sconcertata ma sorda, apparentemente incapace di offrire il suo aiuto ad una personalità troppo complessa per essere capita. Laura Brown vive sull’orlo della crisi, schiacciata dalla serenità del marito che tutto percepisce e tutto elabora in funzione della sua bella e sana famiglia americana dell’era post-bellica; affascinata dalla pienezza – che se contrappone al vuoto delle apparenze – della sua sfera emotiva, decide di investigarla più a fondo e si conduce al baratro, che osserverà attentamente ma che non sceglierà. Piuttosto sceglierà di vivere la sua natura, la sua vertigine, il suo squilibrio con integrità, scegliendo di abbandonare proprio quel nucleo affettivo che gravita intorno a lei. Privato del suo centro, esso si disgregherà, segnando la morte in giovane età del marito e della figlia – che resterà un’ombra proiettata dal pancione della mamma sullo schermo – e la deriva sessuale ed esistenziale del figlio, che persosi la propria identità ne creerà una alternativa fatta di parole – poesie ed un famigerato romanzo – che gli varranno un riconoscimento letterario – il più prestigioso – e una morte violenta. Richard infatti diverrà l’amante-chimera di Clarissa “Mrs. Dalloway” Vaughn, che ama l’uomo e l’artista al punto di farne il suo carceriere al contrario: recluso a causa dell’AIDS lui, libera e omosessuale lei, i due vivono un rapporto di interdipendenza che sopperisce al trauma affettivo di Richard – mai ripresosi dall’abbandono della madre – un personaggio capriccioso e lunatico, vorace in tutte le sue espressioni artistiche e sessuali. Il film si apre con il suicidio della scrittrice, “la morte del poeta” e poi scorre via con lentezza e solennità, portandosi appresso un bagaglio d’ansia che la musica di Philip Glass carica fin dai titoli di testa, come caricasse un orologio a molla e poi lo lasciasse andare fino all’esaurimento della sua energia. Infatti la pellicola si chiude proprio con lo stesso avvenimento, con una pennellata vigorosa e ellittica che tutto riassume e tutto compendia, sottolineando per l’ultima volta la complessità dell’universo su cui ci siamo solamente affacciati per un istante, per un giorno, per un brevissimo momento che può significare tutto, stravolgere tutto, compromettere tutto, o, semplicemente, decretarne la fine.

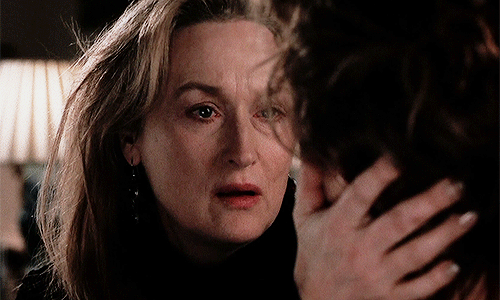
I Vivi e i Morti
Il montaggio parallelo svela lentamente il filo rosso che lega sguardi, silenzi, depressioni e crolli. L’opera d’arte (di Daldry, della Woolf) si scrive sotto i nostri occhi, in un momento senza Tempo, alla ricerca della Verità. “La Signora Dalloway” di Virginia Woolf (interpretata da un’irriconoscibile Nicole Kidman), in un primo momento, doveva intitolarsi “The hours” e far morire la propria eroina. Ma la pace non si trova sottraendosi alla vita (Si può morire…veramente?). L’ostico romanzo scritto dal personaggio di Ed Harris racconta di Clarissa (Meryl Streep), la neo-Signora Dalloway: ai lettori/spettatori appare noioso, senza ragione d’essere. Manca il palesamento di una vita non vissuta. C’è un'altra affinità essenziale, quella fra il romanzo premio Pulitzer di Michael Cunningham e la poetica del commediografo/regista David Hare che l’ha adattato: in Il Mistero di Wetherby, esordio del secondo, c’era lo stesso labirinto narrativo all’ombra del suicidio, della solitudine e dell’alienante omologazione. Opere d’arte e coscienze dei personaggi si leggono a vicenda: la sinergia dei punti di contatto è atta a scardinare le apparenze che ingannano, a spiegare l’attrazione per la morte (la Kidman e l’uccellino morto, la Moore sommersa dall’acqua che ha accolto il corpo della Woolf), gli urli di disagio (il figlio che non riesce a costruire una casa di legno, i baci omosessuali rubati). Il doloroso giallo psicologico denuncia esistenze anestetizzate, finte quieti, idee di felicità non condivise. È preferibile una folle scossa alla gabbia dorata di un amore che soffoca e (si) mantiene in vita oltre la propria volontà. I fantasmi si riuniscono per la festa del morto e squarciano la maschera di chi, rincorrendo la felicità, vive la vita altrui rimpiangendo la propria. La presa di coscienza (dei personaggi, dello spettatore) è catartica ma richiede un sacrificio: la Woolf e Cunningham/Hare/Daldry uccidono l’artista visionario, affinché la sua morte spieghi ai non-vivi che la vita va guardata in faccia, amata per quello che è, fra mille volti, poesia e tragedia. Agli zombie si lasciano lettere di commiato di finta perfezione. Ai vivi si donano le ore, per sempre.

Il Male di Vivere
Tre donne, lontane nel tempo ma profondamente complici nel sentirsi inadeguate, sono le protagoniste del film di Stephen Daldry tratto dall'omonimo romanzo di Michael Cunningham. Dopo il furbo ed energico "Billy Elliot", il regista compie un completo cambio di registro e si addentra in punta di piedi nell'atmosfera di placida disperazione in cui fa muovere le sue protagoniste. Un andamento lento, sottolineato dal crescendo musicale privo di sfogo di Philip Glass, ci trasporta nella quotidianita' di tre donne che soffrono. Nessun rapporto causa-effetto a giustificare il dolore profondo che si respira nella pellicola, ma un male di vivere che trae forza dall'insoddisfazione di un'esistenza diversa da quella desiderata, una sensazione di disagio incolmabile che trasforma un semplice atto quotidiano in una forzatura priva di senso. Il film abbraccia tre epoche: l'Inghilterra del 1923, in cui termina i suoi giorni Virginia Woolf; gli anni cinquanta in chiave grottesca, dove Julianne Moore pare sempre piu' "far from heaven", e la contemporaneita' newyorchese, con Meryl Streep alla difficile ricerca di un equilibrio tra i tanti fantasmi del passato che la assillano. Tre donne diverse legate dalla matrice letteraria della Woolf, intenta a scrivere il romanzo "Mrs. Dalloway", letto dalla Moore e vissuto dalla Streep. Tre volti differenti per un unico ritratto femminile fuori dal tempo e dalle convenzioni. Con un soggetto cosi' interessante ci si aspetta un grande coinvolgimento, invece si resta abbastanza freddi e distaccati. Il compiacimento e' una spada di Damocle che sfiora piu' volte la narrazione, ma il regista riesce per un soffio a evitare scelte di gratuita grevita' e a non far crogiolare i personaggi tra rimpianti e rimorsi. Nonostante la tristezza diffusa che si respira, infatti, il film oppone alla speranza una tragica lucidita' che si rivela in qualche modo consolatoria. Una consapevolezza che si traduce in un grido di liberta'. La sobrieta' della messa in scena e' ravvivata da un montaggio incrociato, che affida alle immagini il compito di spiegare cio' che le parole finirebbero per banalizzare. A risaltare sono soprattutto le sfumature interpretative degli attori (in questo Daldry si era gia' dimostrato molto attento anche in "Billy Elliot"): Nicole Kidman non scompare dietro al naso posticcio e al trucco che la rendono quasi irriconoscibile e rivela il suo carisma senza prevaricare il personaggio; Julianne Moore ci ha ormai abituati alle lacrime e al look anni cinquanta, ma conferma il suo spessore interpretativo; come Meryl Streep, sempre capace di accendere ogni scena di cui e' protagonista; convince anche Ed Harris, che intepreta il personaggio piu' stereotipato (l'artistoide sieropositivo) e a rischio gigioneria, ma riesce a non esagerare (e dopo il monumento fatto di scene madri e finta misura che si e' costruito con "Pollock" e' davvero un bel risultato). Ma sono al posto giusto anche Toni Collette, Jeff Bridges, John C. Reilly, Claire Danes e Miranda Richardson che in poche sequenze, e grazie a personaggi ottimamente caratterizzati, riescono a rendere incisiva la loro presenza.

V’adoro, pupille
Tre donne lontane, anzi più che mai vicine, tre facce di un’Eva postmoderna, fragile e disperatamente determinata a convivere col male di vivere. Esposto in questi termini, THE HOURS sembra l’usuale polpettone a rosario, in cui la struttura a episodi (non) nasconde l’assenza di idee di scrittura e/o di regia e il minimo dettaglio è accordato in chiave rigorosamente “femminile”, nel senso più bamboleggiante possibile. In realtà, il termine televisivo può essere associato al film di Daldry solo in senso etimologico: la visione a distanza è il tema di questo film affilato e struggente, immoto e “noioso”, disperato e ironico come la vita e la narrazione. Perseguitati da voci insistenti, sguardi sfuggenti, da tutto il clamore, intimo ed esterno, di una vita che è melma intossicante e talamo insidiosamente accogliente di nevrosi ereditarie, i personaggi trovano un po’ di calma unicamente in una proiezione fantastica, che supera e annulla le ingannevoli barriere dello spazio e del tempo, in una visione “altra”, in un mondo di spettri in cui la mente plasma, indisturbata e disturbante, nuove (im)possibili esistenze. Ma anche questa parentesi si rivela effimera, e non c’è che tornare alla vita, al tempo che fluisce in un solo senso, almeno fino alla prossima illuminazione, come un mazzo di fiori nel pozzo buio di un ascensore per il patibolo. La centralità della visione è sottolineata da un’ammaliante rete di primi e primissimi piani, in cui gli occhi risplendenti delle tre magnifiche primedonne (e di molti altri, a cominciare dal lacerante poeta interpretato da Harris e dall’enigmatica Vanessa Bell di un’ammirevole Richardson), fonti di luce in un universo dominato da colori freddi e smorti, come un acquario sorto dalle alghe, formano una continuità, intrecciando i fili di misteriose corrispondenze gestuali ed emotive, e contemporaneamente la negano, frammentando un Tempo (non più) unico e irreversibile. Virginia e Richard, “doppi” del regista, mettono in scena le esistenze altrui e ne sono condizionati: la scrittrice discende in un abisso (pre)autobiografico (il fiume che irrompe nella stanza d’albergo è il solo momento di fantasmagoria barocca di tutto il film, e ha un fascino dolce e funereo che lascia letteralmente senza fiato), il poeta svanisce in un quadro di luce livida e polverosa, una finestra non molto diversa da uno schermo cinematografico. Il suicidio dei creatori apre e chiude il film: l’acqua e la luce, elementi di vita, si accumulano e danno la morte, perché un’altra vita possa nascere, come un fiore, dalla terra cosparsa di cadaveri; il bacio di disperata ribellione si placa, senza ammorbidirsi, nell’abbraccio rasserenato alla totalità dell’esistenza. Lo schermo s’immerge nel buio. Nota a margine: nel contesto della magnifica prova (che neanche la putrida abitudine del doppiaggio riesce ad avvilire in maniera irreparabile) di un cast sublime, il ritratto di scrittrice proposto da Kidman sta a sé. Non si sta parlando di mera mimesi, studio delle fonti biografiche o altro. Indipendentemente da somiglianze fisiche e/o gestuali, dal naso finto, dalle vesti informi, dalle dita sporche di tabacco, l’attrice sa diventare Virginia Woolf: nei suoi occhi di diamante vediamo, splendide e opache, la bellezza e la crudeltà della scrittura. Un solo termine di paragone: la Marguerite Duras di Jeanne Moreau (in CET AMOUR – Là di Josée Dayan).



